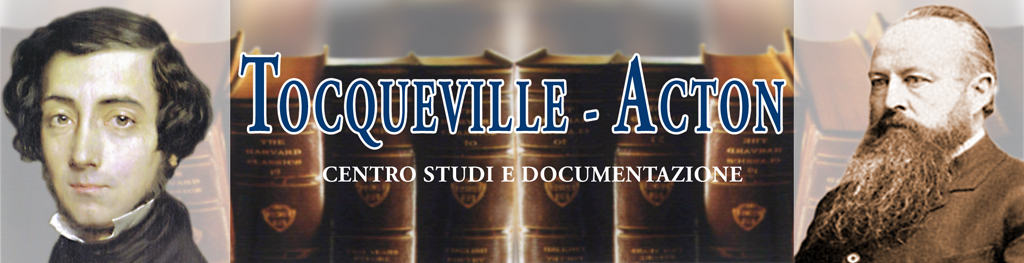
Alexis de Tocqueville
Discorso sulla libert� religiosa1
Dario Antiseri, Cattolici a difesa del mercato, a cura di F. Felice, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2005
Signori,
prego la Camera di notare che siamo qui di fronte a due questioni diverse: una di fatto ed una di diritto.
Stando a quanto il signor guardasigilli ha appena detto sembra che non tutti i protestanti di Francia siano d�accordo se lagnarsi, e ci� non deve sorprenderci.
Quelli, tra loro, il cui culto � sovvenzionato, quelli che possono governare la loro chiesa si ritengono soddisfatti, � semplicissimo; mentre, al contrario, sono quelli che vogliono sottrarsi a questi governi ecclesiastici per adorare Dio a modo loro che si lamentano.
Koechlin � Quelli non sono protestanti (moti discordi).
De Tocqueville � Avete capito bene signor de Gasparin. Sembrerebbe, dunque, che i protestanti francesi siano divisi su questo punto. Ma che ce ne importa? Deve forse la questione che ci occupa svuotarsi a causa delle opinioni, degli interessi delle s�tte protestanti? Non si tratta di una questione che domina tutti i culti, che interessa tutti i cittadini? Si tratta forse di sapere se questi o quei protestanti sono soddisfatti della attuale giurisprudenza? No, no: la questione � pi� alta, essa si libra al di sopra di tutte le religioni. Non � un problema religioso, � un problema di diritto. Si tratta di sapere se, in questo paese libero, la prima, la pi� santa, la pi� sacra di tutte le libert� umane, la libert� religiosa, sia stata dalla Francia cap�ta prima che io abbia avuto bisogno di nominargliela; se in questo libero paese sar� o meno permesso di adorare il proprio Dio senza l�autorizzazione del commissario di polizia (a sinistra: ecco il punto!).
Questo � il problema, e nessun altro. Tale problema � stato lungamente, eloquentemente sviluppato davanti alla Camera un anno fa e, vedendo il voto cos� disputato, cos� combattuto, ottenere una maggioranza decisiva, avevo pensato che il signor guardasigilli non avrebbe tardato a domandare una risoluzione al Parlamento. Ma egli non l�ha fatto ed �, invece, ricorso ad un espediente che, oso dire, � caratteristico dell�abituale temperamento del gabinetto, un espediente che, come al solito, non ha soddisfatto nessuno. Egli ha lasciato sussistere la giurisprudenza anteriore; ha lasciato che le autorit� locali dessero inizio, in virt� di questa giurisprudenza, a dei procedimenti penali; ma non ha lasciato che questi ultimi giungessero fino ai tribunali. In tal modo egli ha detto ai partigiani del monopolio di Stato: potete ben vedere che io agisco in tribunale, e a quelli della libert� ha potuto dire: vedete bene che non faccio condannare.
Riconosco che, in questo modo, egli ha smorzato l�irritazione prodottasi in precedenza: in questo modo un gran numero di persone, che avevano avuto di che lagnarsi, non si sono lagnate: ma, in fondo, egli non ha fatto nulla che potesse dare alla sacra libert� di cui ho appena parlato quella legittima soddisfazione che le era dovuta.
E allora, signori, vi domando (non voglio assolutamente entrare nei particolari della questione, voglio solo porvi la questione stessa in due parole, e credo che porla significhi risolverla); allora, che dice la Carta costituzionale? La Carta dice che ogni cittadino avr� la libert� religiosa. Che cos�� la libert� religiosa? � la libert� accordata ad ogni uomo di credere, nel fondo della propria coscienza, ci� che pi� gli piace? Ma quale governo, signori, avrebbe il potere di strappare questa libert�? Quale tiranno ha mai avuto la pensata, non dir� atroce, ma ridicola, di impedire a qualcuno di credere nel Foro interno? Che � allora la libert� religiosa? Signori, � la libert� di culto; la libert� religiosa � tutta contenuta nella libert� di culto, nel diritto di pregare in comune.
Ed ora, che cos�� la libert� di culto? Esisterebbe se, per esercitare il mio culto, che agli occhi della mia coscienza � il primo dei miei doveri, fossi costretto ad ottenere previamente un�autorizzazione? Di grazia, signori, risalite all�indietro, esaminate nella vostra memoria cosa, in tutti i tempi e in particolare in questo paese, ha sempre costituito la libert�. Dove trovate l�obbligo di autorizzazione precedere una libert�? Da nessuna parte. Quando avete creduto di avere la libert� di stampa? Il giorno in cui � scomparsa l�autorizzazione. Quando si riconoscer� di avere realmente la libert� di istruzione? Il giorno in cui si toglier� all�Universit� il diritto di concedere l�autorizzazione. Anche gli uomini meno favorevoli alla libert� di insegnamento hanno dovuto riconoscere, in questa Camera e nell�altra, questa verit�: la si � solennemente riconosciuta in quello stesso rapporto che vi � stato sottoposto l�anno scorso: Thiers ha riconosciuto che fintanto che la libert� di insegnamento dipender� da una autorizzazione, essa non esister�.
Diciamo, quindi, col buon senso di tutti i secoli, con la esperienza di questo stesso paese: libert� ed autorizzazione pregiudiziale sono parole che fanno a pugni e che non possono andare insieme.
Ebbene! Ecco a quale regime � affidata la prima, la pi� inalienabile di tutte le libert�, in questo paese che nel nome sacro della libert� ha fatto tante rivoluzioni sanguinose: ecco a che punto si riduce la pi� preziosa di tutte le libert�, la libert� religiosa.
Signori, lo confesso, quanto ho detto mi sembra cos� elementare, cos� chiaro, cos� evidente, che, per comprender come mai il governo, senza alcuna necessit�, abbia misconosciuto una verit� cos� evidente, non posso impedirmi di pensare che esso ha creduto di avere un grande interesse a farlo.
E qual � tale interesse? L�ordine pubblico, si dir�. Ma io non credo che si facesse questione di ordine pubblico; non lo credo soprattutto quando vedo che non si tratta qui di una di quelle fantasticherie dello spirito umano che possono ornarsi, a torto o a ragione, del titolo di religione, ma di un culto riconosciuto dallo stesso Stato. L�ordine pubblico non era quindi in pericolo. Perch� allora il governo ha violato una libert� cos� sacra? Ve lo dir� in poche parole, poich� non voglio toglier tempo ad una solenne discussione che avr� luogo tra breve in quest�aula. Sono portato a credere che i ripetuti atti di cui parliamo, atti che rimontano fino a parecchi anni fa, che sono stati in tali anni precedenti molto pi� numerosi, lo confesso, molto pi� oppressivi di quanto non lo siano ora; sono portato a credere, dico, che nel momento in cui il governo si � abbandonato a tali atti non faceva che applicare una idea generale. E qual era, signori, tale idea generale? L�idea generale, secondo me, era la seguente: il governo ha visto che, dopo la Rivoluzione di Luglio, per questa stessa rivoluzione che aveva felicemente tagliato i legami che univano la Chiesa allo Stato, la religione, per la prima volta, sembrava rialzarsi nel paese, che le credenze religiose sembravano riprender radice nei cuori; esso lo ha visto e immediatamente ha voluto mettere a partito questa forza nuova che si presentava; immediatamente, con un insieme di misure che ci sarebbe facile ricordare, ma che non ricorder� perch� voglio essere breve, esso si e sforzato di attirare a s� il cattolicesimo, di metter la mano sul clero di farne un agente del governo (moti discordi. Agitazione). Eh, signori, la Camera vedr� subito che, rivangando per un momento questa faccenda cos� scottante, non cedo a delle miserabili questioni di partito: essa lo vedr�. Dicevo, dunque, che il governo aveva creduto fosse nel suo interesse riconciliarsi il clero, fare del clero, lo ripeto, uno strumento del governo.
Dico che gran parte degli atti di cui ci lamentiamo ora a questa tribuna hanno avuto origine da un tal pensiero. � cos� che, tanto per non uscire dal caso che ci occupa, il governo ha voluto mostrare al cattolicesimo di piazzarsi, per cos� dire, tra lui ed i suoi avversari; che al bisogno sapeva difenderlo contro il proselitismo; che vegliava per lui, acciocch� il proselitismo stesso non divenisse formidabile; che sapeva, al bisogno, essere il braccio secolare della Chiesa. Qual � il risultato di questi e di molti altri atti che non voglio qui ricordare? Due cose ne sono risultate: tutti gli antichi avversari del cattolicesimo si sono rianimati, risvegliati, alla vista di questa parzialit� del potere pubblico. Non solo i protestanti si son sentiti inquieti e turbati nel vedere questa unione nuova, che sembrava rinascere tra Chiesa e Stato; ma i liberi pensatori, ma tutti gli uomini sinceri di tutte le comunioni e di tutte le opinioni, che vogliono la libert� completa, che non la vogliono solo per se stessi e i loro amici, ma per tutti quanti, tutti questi uomini si sono preoccupati; una sorda agitazione si � ben presto manifestata non solo contro il clero, ma contro lo stesso cattolicesimo. D�altra parte, nello stesso tempo ed in seguito agli stessi fatti, il clero, o piuttosto alcuni uomini all�interno del clero, si sono imbaldanziti. Gli uomini intolleranti e ambiziosi del clero, ve ne sono di simili in tutti i corpi, anche nei corpi pi� onorevoli e pi� santi, hanno creduto fosse giunto il momento di agire, di far qualcosa di nuovo, di riprender l�offensiva. Rassicurati da questo segreto appoggio che credevano di trovare nel governo, si sono lasciati andare a quegli attacchi, a quelle provocazioni, a quelle violenze deplorevoli di cui siamo stati testimoni e che, per un inevitabile contraccolpo, hanno a loro volta portato le violente rappresaglie a cui assistiamo.
Cosa � derivato da tutto ci�? Ne � derivato, a mio avviso, qualcosa di profondamente deplorevole: ne � derivato che la grande e sfortunata guerra che si era un tempo avuta tra la societ� nuova e la religione, questa guerra che sembrava se non altro sospesa, questa guerra � ripresa da ogni parte con violenza, finch� siamo giunti a contemplare il triste spettacolo di discordia religiosa che abbiamo oggigiorno sotto gli occhi. Ne � derivato che abbiamo visto prodursi quelle divisioni deplorevoli, divisioni funeste e che non dureranno per sempre, spero, tra le idee religiose e le idee liberali; divisioni che, per mio conto, deploro con tutta l�anima, che considero come il peggior male che potesse colpire la societ� del nostro tempo.
Quanto a me, sono convinto, e tale convinzione non sarebbe meno ferma se dovesse rimanere isolata, sono profondamente convinto che, in questo paese, in Francia, la religione non otterr� mai quell�impero sui cuori che le � dovuto; non spinger� mai le anime all�altezza a cui pu� sollevarle; non sar� mai completamente grande, se si allontana dalla libert�; e d�altra parte sono profondamente convinto che, se la libert� si separa in modo definitivo e completo dallo spirito religioso, le mancher� sempre ci� che con tanta ammirazione le ho visto avere in altri paesi, le mancher� sempre quell�elemento di moralit�, di stabilit�, di tranquillit�, di vita che solo la rende grande e feconda (molto bene!).
Non � questo che sognavo per il mio paese; ho sempre pensato che, per quanto questa alleanza dello spirito religioso con lo spirito liberale in Francia non esistesse, per delle cause al cui esame non voglio ritornare, ho sempre pensato, dico, che questa unione tanto necessaria tra religione e libert� presto o tardi si sarebbe fatta l�ho creduta compiuta dopo la Rivoluzione di Luglio, allorch� infine vidi la religione e lo Stato separarsi in modo completo e assoluto; il prete chiuso nella sua sfera, lontano dal potere; quando vidi, in s�guito a questa separazione tanto felice e desiderabile, che le anime pi� elevate si lanciavano come da sole verso le credenze religiose; quando ho visto da una parte gli uomini religiosi tendere la mano agli uomini liberali, e dall�altra questi ultimi tender la mano agli uomini religiosi, ho creduto che questa unione stesse per farsi e ne ho provato una grande e patriottica gioia; e quando poi ho visto prodursi delle impressioni contrarie, ne ho provato un gran dolore per il mio paese. Chi accusare di un male cos� grande? Non posso fare a meno di dirlo: prima di tutti il governo.
� soprattutto a causa della condotta tenuta in questi ultimi anni dal governo verso il clero, che c�pita tutto ci� che sta capitando; � questa condotta ad aver allarmato gli uni e ad aver dato una cos� imprudente confidenza agli altri. � soprattutto questa condotta tanto pericolosa nella sua fatalit� ad aver risvegliato da ogni parte vecchi odi che, nell�interesse della patria, si sarebbero dovuti seppellire per sempre (molto bene!).
(A. De Tocqueville, Scritti politici, I, a cura di N. Matteucci,
UTET, Torino 1969, pp. 228-233).
1 Questo discorso venne pronunciato alla Camera dei deputati il 28 aprile 1845, in polemica con il Ministro della giustizia e dei culti, Martin du Nord, il quale sosteneva che l�art. 29 del Codice penale potesse applicarsi anche alle riunioni religiose e che, pertanto, tali riunioni non potessero aver luogo senza l�autorizzazione del governo.
Discorso sul diritto al lavoro1
Se non erro non ci si attende da me che io risponda all�ultima parte del discorso che avete appena udito. In essa � contenuta l�enunciazione di un sistema completo e complicato al quale non ho il compito di opporre un altro sistema.
Il mio fine, in questo momento, � solo quello di discutere l�emendamento in favore del quale, o, piuttosto, a proposito del quale l�oratore precedente ha parlato.
Qual � tale emendamento? Quale la sua portata? Quale la sua tendenza, secondo me fatale? Ecco ci� che debbo esaminare.
Una parola, innanzi tutto, sul lavoro della Commissione2.
La Commissione, come vi ha detto il precedente oratore, ha in realt� fatto due redazioni, ma in fondo essa non ha avuto e non continua ad avere che un solo pensiero. Dapprima si era servita di una formula; ma le parole pronunciate a questa tribuna e altrove e, meglio delle parole, i fatti, le hanno dimostrato che questa formula esprimeva in modo incompleto e pericoloso il suo pensiero; essa vi ha rinunciato, non al pensiero, ma alla forma.
Questa formula viene ripresa ed � di fronte ad essa che in questo momento ci troviamo.
Si mettono le due redazioni l�una di fronte all�altra; sia. Paragoniamole alla nuova luce dei fatti.
Con la sua ultima redazione la Commissione si limita ad imporre alla societ� il dovere di venire in aiuto, sia col lavoro che col soccorso propriamente detto e nella misura delle sue risorse, a tutte le miserie; ci� dicendo la Commissione ha, senza dubbio, voluto imporre allo Stato un dovere pi� esteso, pi� sacro di quello che esso si era imposto finora; ma non ha voluto fare una cosa assolutamente nuova: ha voluto accrescere, consacrare, regolarizzare la carit� pubblica, non ha voluto fare null�altro che della carit� pubblica. L�emendamento, al contrario, fa una cosa diversa e fa ben di pi�; l�emendamento, nel senso che le parole che sono state pronunciate e soprattutto i fatti recenti gli d�nno, l�emendamento che accorda ad ogni uomo in particolare il diritto generale, assoluto, irresistibile, al lavoro, questo emendamento porta necessariamente ad una delle seguenti conseguenze: o lo Stato si assume il compito di dare a tutti i lavoratori che si presenteranno a lui l�impiego che non hanno, e allora viene a poco a poco trascinato a fare l�industriale; e dato che esso � l�imprenditore che si incontra ovunque, il solo che non possa rifiutare il lavoro e quello che di solito impone il compito minore, esso � invincibilmente condotto a rendersi il principale e, ben presto, l�unico imprenditore dell�industria. Una volta giunti a questo punto l�imposta non � pi� il modo per far funzionare la macchina del governo, ma il grande mezzo per alimentare l�industria. Accumulando, cos�, nelle proprie mani tutti i capitali dei singoli, lo Stato finisce col divenire l�unico proprietario di ogni cosa. Ora, questo � comunismo (sensazione).
Se, al contrario, lo Stato vuol sfuggire alla fatale necessit� di cui ho parlato, se vuole dar lavoro a tutti gli operai che si presentano, non pi� da solo e con le proprie risorse, ma vegliando acch� essi ne trovino presso i privati, � fatalmente trascinato a tentare quella regolamentazione dell�industria che, se non erro, adottava nel suo sistema l�onorevole collega che mi ha preceduto. Esso � obbligato a fare in modo che non vi sia disoccupazione, cosa che lo porta forzatamente a distribuire i lavoratori in modo che non si facciano concorrenza, a regolare i salari, a moderare a volte la produzione, a volte ad accelerarla, in una parola a farla da grande ed unico organizzatore del lavoro (movimento).
In conseguenza, per quanto a prima vista la redazione della Commissione e quella dell�emendamento sembrino toccarsi, esse portano a risultati del tutto opposti; sono come due strade che, partendo all�inizio dal medesimo punto, finiscano con l�essere separate da un immenso spazio: l�una porta all�estensione della carit� pubblica; in fondo all�altra che vedo? Il socialismo (segni di approvazione).
Non nascondiamocelo, non si guadagna nulla ad aggiornare delle discussioni il cui germe si trova alla base stessa della societ� e che, presto o tardi, in un modo o nell�altro, apparirebbero alla superficie, sia con parole che con fatti. Ci� di cui oggi si tratta, ci� che si trova, forse all�insaputa del suo autore, ma che io ci� nonostante vedo per mio conto, con la stessa chiarezza del giorno che mi illumina, in fondo all�emendamento dell�onorevole Mathieu, e il socialismo... (prolungata sensazione � mormorii a sinistra).
S�, signori, bisogna che presto o tardi questa questione del socialismo, che tutti temono e che nessuno, finora, osa trattare, giunga a questa tribuna; bisogna che l�Assemblea la recida, bisogna che scarichiamo il paese dal peso che il pensiero del socialismo ha posto, per cos� dire, sul suo petto; bisogna che a proposito di questo emendamento � ed � soprattutto per questo, lo confesso, che sono salito a questa tribuna � la questione del socialismo sia recisa; bisogna che si sappia, bisogna che l�Assemblea nazionale sappia, che tutta quanta la Francia sappia se la Rivoluzione di Febbraio � stata o no una rivoluzione socialista (molto bene!).
Lo si dice; lo si ripete; quante volte, da dietro le barricate di Giugno non ho sentito uscire questo grido: Viva la repubblica democratica e SOCIALE? Che si intende con questa parola? Si tratta di saperlo; si tratta soprattutto che l�Assemblea nazionale lo dica (agitazione a sinistra).
L�Assemblea pu� credere che non � mia intenzione esaminare davanti a lei i differenti sistemi che, tutti, possono essere compresi in questa sola parola: il socialismo. Voglio solo cercar di riconoscere, in poche parole, quali sono i tratti caratteristici che si ritrovano in tutti tali sistemi e di vedere se � questa cosa, che porta tale fisionomia e tali tratti, che la Rivoluzione di Febbraio ha voluto.
Se non mi inganno, signori, il primo tratto caratterizzante tutti i sistemi che portano il nome di socialismo � un appello energico, continuo, smodato, alle passioni materiali dell�uomo (segni di approvazione).
� per questo che gli uni hanno detto �che si trattava di riabilitare la carne�, che gli altri hanno detto �che bisognava che il lavoro, anche il pi� duro, non fosse solo utile, ma piacevole�3, che altri ancora hanno detto che bisognava �che gli uomini fossero retribuiti, non in proporzione ai loro meriti, ma in proporzione ai loro bisogni�4 e, infine, che l�ultimo dei socialisti di cui voglio parlare � venuto qui a dirvi che il fine del sistema socialista, e, secondo lui, il fine della Rivoluzione di Febbraio, era stato quello di procurare a tutti un consumo illimitato.
Ho dunque ragione di dire, signori, che il tratto caratteristico e generale di tutte le scuole socialiste � un appello energico e continuo alle passioni materiali dell�uomo.
Ve ne � un secondo, ed � un attacco, a volte diretto, a volte indiretto, ma sempre continuo, ai princ�pi stessi della propriet� individuale. Dal primo socialista5, che cinquant�anni fa diceva che la propriet� era l�origine di tutti i mali del mondo, fino al socialista che abbiamo ascoltato a questa tribuna6 e che, meno caritatevole del primo, passando dalla propriet� al proprietario, ci diceva che la propriet� era un furto, tutti i socialisti, tutti, oso dire, attaccano in modo diretto o indiretto la propriet� (� vero! � vero!). Non pretendo dire che tutti l�attacchino nella maniera franca e, permettetemi di dirlo, un po� brutale, adottata da un nostro collega, ma dico che tutti, per vie pi� o meno traverse, se non la distruggono, la trasformano, la diminuiscono, la molestano, la limitano, e ne fanno una cosa diversa dalla propriet� individuale che conosciamo e che si conosce dall�inizio del mondo (vivissimi segni di assenso).
Ed ecco il terzo ed ultimo tratto, quello che sopra ogni altro caratterizza ai miei occhi i socialisti di tutti i colori, di tutte le scuole, ed � una sfiducia profonda per la libert�, per la ragione umana; un profondo disprezzo per l�individuo preso in se stesso, al suo stato di uomo; ci� che li caratterizza tutti � un tentativo continuo, vario, incessante, per mutilare, per raccorciare, per molestare in tutti i modi la libert� umana; � l�idea che lo Stato non debba soltanto essere il direttore della societ�, ma debba essere, per cos� dire, il padrone di ogni uomo, che dico! il suo padrone, il suo precettore, il suo pedagogo (molto bene!); che, per tema di non lasciarlo sbagliare, debba senza cessa porsi al suo fianco, sopra di lui, attorno a lui, per guidarlo, garantirlo, mantenerlo, trattenerlo; in una parola, � la confisca, come ho detto or ora, in un grado pi� o meno grande, della libert� umana (nuovi segni di assenso), a tal punto che, se dovessi trovare una formula generale per esprimere ci� che il socialismo mi sembra nel suo insieme, direi che � una nuova forma di servit� (approvazioni assai vive).
Signori, vedete che non sono entrato nei particolari dei sistemi; ho dipinto il socialismo nei suoi tratti principali, sufficienti per farlo riconoscere; ovunque li vedrete siate sicuri che l� vi � il socialismo, e ovunque vedrete il socialismo siate sicuri di ritrovare tali tratti.
Ebbene, signori, che � tutto ci�? � forse, come si � preteso tante volte, la continuazione, il legittimo completamento, il perfezionamento della Rivoluzione francese? E forse, come si � detto tante volte, il completamento, lo sviluppo naturale della democrazia? No, signori, non � n� l�uno, n� l�altro; richiamate alla vostra mente, signori, la Rivoluzione francese; risalite a questa terribile e gloriosa origine della nostra storia moderna. � dunque, come pretendeva ieri un oratore, parlando ai sentimenti materiali, ai bisogni materiali dell�uomo, che la Rivoluzione francese ha fatto grandi cose che le hanno dato lustro nel mondo? Credete che ci� sia avvenuto parlando di salario, di benessere, di consumi illimitati, di soddisfazione senza limiti dei bisogni fisici?
Il cittadino Mathieu (de la Dr�me) � Non ho detto nulla di simile.
Il cittadino di Tocqueville � Credete che sia stato parlando di tali cose che essa ha potuto svegliare, che essa ha animato, che essa ha messo in piedi, spinto alle frontiere, gettato tra i pericoli della guerra, messo di fronte alla morte una generazione intera? No, signori, no; � stato parlando di cose pi� alte e pi� belle, � stato parlando di amor di patria, di onore della patria; � stato parlando di virt�, di generosit� di sentimenti disinteressati, di gloria, che essa ha fatto queste grandi cose; perch�, dopo tutto, signori, siate certi che non vi � che un segreto per far fare grandi cose agli uomini: ed � di fare appello ai grandi sentimenti (molto bene! molto bene!).
E la propriet�, signori, la propriet�! La Rivoluzione francese ha indubbiamente fatto una guerra energica, crudele, a un certo numero di proprietari: ma quanto al principio stesso della propriet� individuale, lo ha sempre rispettato, onorato; l�ha messo al primo posto nelle sue costituzioni. Nessun popolo l�ha trattato in modo pi� magnifico; essa lo ha iınpresso sul frontespizio stesso delle sue leggi.
La Rivoluzione francese ha fatto di pi�; non solo ha consacrato la propriet� individuale, ma la ha estesa; ne ha reso partecipe un maggior numero di cittadini (esclamazioni contrastanti � � quello che noi domandiamo!).
Ed � grazie ad essa, signori, che non dobbiamo oggi temere le funeste conseguenze delle dottrine che i socialisti spandono nel paese, e perfino in quest�aula; � perch� la Rivoluzione francese ha popolato questa Francia di dieci milioni di proprietari, che, senza pericolo, si possono lasciare le vostre dottrine prodursi a questa tribuna, esse indubbiamente possono portar desolazione nella societ�, ma, grazie alla Rivoluzione francese, non prevarranno contro di essa e non la distruggeranno (molto bene!).
E infine, signori, quanto alla libert�, vi � una cosa che mi colpisce: ed � che l�antico regime, il quale senza dubbio, in molti punti bisogna riconoscerlo, era di diversa opinione dai socialisti, aveva tuttavia, in materia politica, delle idee meno lontane da essi di quanto non si potrebbe credere. In definitiva, era assai pi� vicino a loro di noi. L�antico regime, infatti, professava l�opinione secondo la quale l�unica saggezza � nello Stato, i sudditi sono degli esseri infermi e deboli che bisogna sempre tenere per mano, per tema che non cadano o non si facciano male; l�opinione che � bene molestare, contrariare, comprimere senza posa le libert� individuali; che � necessario regolamentare l�industria, assicurare la bont� dei prodotti, impedire la libera concorrenza.
Su questo punto l�antico regime la pensava esattamente come i socialisti di oggi. E chi la pensava in altro modo? La Rivoluzione francese.
Signori, cosa ha rotto tutte le pastoie che da ogni parte arrestavano il libero movimento delle persone, dei beni, delle idee? Cosa ha restituito all�uomo la sua grandezza individuale, la sua vera grandezza, cosa? La Rivoluzione francese stessa (approvazioni e rumori). � la Rivoluzione francese che ha abolito tutte queste pastoie, che ha rotto tutte queste catene che, sotto diverso nome, voi vorreste ristabilire, e non sono solo i membri di questa Assemblea immortale, l�Assemblea costituente, di questa Assemblea che ha fondato la libert�, non solo nella Francia, ma nel mondo; non sono solo i membri di questa illustre Assemblea ad aver respinto queste dottrine dell�antico regime, ma anche gli uomini eminenti di tutte le Assemblee che l�hanno segu�ta: � lo stesso rappresentante della sanguinosa dittatura della Convenzione. Ancora l�altro giorno leggevo le sue parole; eccole:
�Fuggite, diceva Robespierre, fuggite la man�a antica... � Vedete che non � nuova (sorrisi) � Fuggite la man�a antica di voler troppo governare; lasciate agli individui, lasciate alle famiglie il diritto di fare liberamente tutto ci� che non nuoce agli altri; lasciate ai comuni il diritto di regolare da soli i propri affari; in una parola, rendete alla libert� degli individui tutto ci� che � stato loro illegittimamente tolto, ci� che non appartiene necessariamente alla pubblica autorit�7 (sensazione).
E allora, signori, tutto questo grande movimento della Rivoluzione francese non avrebbe portato ad altro che a questa societ� che i socialisti ci dipingono con delizia, a questa societ� regolamentata, compassata, in cui lo Stato si incarica di tutto, in cui l�individuo non � nulla, in cui la societ� agglomera in se stessa, riassume in se stessa tutta la forza, tutta la vita, in cui il fine assegnato all�uomo � unicamente il benessere, questa societ� in cui manca l�aria! Ove quasi non penetra pi� la luce. Allora! Sarebbe per questa societ� di api o di castori, per questa societ� pi� da animali sapienti che da uomini liberi e civili, che si sarebbe fatta la Rivoluzione francese! � per questo che tanti uomini illustri sarebbero morti sui campi di battaglia o sul patibolo, che tanto sangue glorioso avrebbe inondato la terra; � per questo che si sarebbero eccitate tante passioni, che tanti geni, tante virt� sarebbero apparsi al mondo!
No, no, lo giuro per quegli uomini che soccombettero per questa grande causa; no, non � per questo che essi sono morti; � per qualcosa di pi� grande, di pi� sacro, di pi� degno di loro e dell�umanit� (molto bene!). Se non vi fosse stato da fare che quello, la Rivoluzione sarebbe stata inutile, l�antico regime perfezionato sarebbe stato sufficiente (movimento prolungato).
Dicevo or ora che il socialismo pretenderebbe essere lo sviluppo legittimo della democrazia; non cercher�, io, come hanno cercato di fare parecchi nostri colleghi, quale sia la vera etimologia della parola democrazia. Non percorrer�, come si faceva ieri, il giardino delle radici greche per sapere da dove viene questa parola (si ride). Cercher� la democrazia dove l�ho vista, viva, attiva, trionfante, nel solo paese al mondo ove esiste, ove ha potuto fondare finora, nel mondo moderno, qualcosa di durevole e di grande, in America (bisbigli).
L� vedrete un popolo in cui le condizioni sono pi� uguali di quanto non lo siano neppure tra noi; in cui l�assetto sociale, i costumi, le leggi, tutto � democratico; in cui tutto emana dal popolo e vi rientra, e dove, tuttavia, ogni individuo gode di una indipendenza pi� intera, di una libert� pi� grande che in alcun altro tempo o in alcuna altra contrada della terra; un paese essenzialmente democratico, lo ripeto, la sola democrazia che esista oggigiorno al mondo, le sole repubbliche democratiche che si conoscano nella storia. E in queste repubbliche cerchereste invano il socialismo. Non solo le teorie dei socialisti l� non si sono impadronite dello spirito pubblico, ma hanno giocato un ruolo cos� piccolo nella discussione e negli affari di questa grande nazione, che non hanno neppure avuto il diritto di dire che le si temeva.
L�America � oggi il paese al mondo in cui la democrazia si esercita in modo pi� sovrano, ed � anche quello in cui le dottrine socialiste, che voi pretendete siano cos� bene in accordo con la democrazia, hanno meno corso, il paese dell�universo in cui gli uomini che sostengono queste dottrine avrebbero certamente il minor vantaggio a presentarsi. Per mio conto non vedrei, lo confesso, un inconveniente tanto grande per coloro che andassero in America; ma non consiglio loro, nel loro interesse, di farlo (risa rumorose).
Un membro � Si vendono i loro beni in questo momento!
Il cittadino de Tocqueville � No, signori, la democrazia e il socialismo non sono solidali l�una con l�altro. Sono cose non solo differenti, ma contrarie. La democrazia consiste forse nel creare un governo pi� fastidioso, pi� particolareggiato, pi� restrittivo di tutti gli altri, con la sola differenza che lo si farebbe eleggere dal popolo e che esso agirebbe in nome del popolo? Ma che avreste allora fatto? se non dare alla tirannia un�aria legittima, che essa non aveva, e assicurarle l�onnipotenza e la forza, che le mancavano. La democrazia estende la sfera dell�indipendenza individuale, il socialismo la restringe. La democrazia d� ad ogni uomo tutto il valore possibile, il socialismo fa di ogni uomo un agente, uno strumento, una cifra. La democrazia e il socialismo non hanno in comune che una parola, l�uguaglianza; ma state attenti alla differenza: la democrazia vuole l�uguaglianza nella libert� e il socialismo vuole l�uguaglianza nella molestia e nella servit� (molto bene! molto bene!).
Non � dunque necessario che la Rivoluzione di Febbraio sia sociale; se non � necessario, bisogna avere il coraggio di dirlo; se non deve esserlo, bisogna avere l�energia di proclamarlo a voce alta, come lo faccio io qui. Quando non si vuole il fine non bisogna volere i mezzi; se non si vuole lo scopo non bisogna entrare nella via che ad esso porta. Oggi vi si propone di entrarvi.
Non bisogna seguire la politica che indicava Babeuf8, questo nonno di tutti i socialisti moderni (risa di approvazione). Non bisogna cadere nella trappola che indicava egli stesso, o piuttosto che indicava a suo nome il suo storico, il suo amico, il suo allievo, Buonarroti9. Ascoltate quanto diceva Buonarroti, perch� merita di essere ascoltato, anche dopo cinquant�anni
Un membro � Qui non vi sono seguaci di Babeuf.
Il cittadino di Tocqueville � �L�abolizione della propriet� privata e la fondazione della grande comunit� nazionale erano lo scopo finale dei suoi lavori [di Babeuf]. Tuttavia egli si sarebbe ben guardato dal farne oggetto di un ordine dopo il suo trionfo; egli pensava che bisognava condursi in modo da far s� che tutto il popolo proscrivesse la propriet� privata, come suo bisogno e suo interesse�.
Ed ecco le principali ricette di cui egli contava servirsi: (� l�autore del suo panegirico che parla) �Stabilire, per legge, un ordine pubblico in cui i proprietari, pur mantenendo provvisoriamente i loro beni, non vi trovino pi� n� abbondanza, n� piacere, n� considerazione; in cui essi, costretti a spendere la maggior parte delle loro entrate per spese culturali ed imposte, prostrati sotto il peso dell�imposta progressiva, allontanati dagli affari, privati di ogni influenza, non formando pi� all�interno dello Stato che una classe sospetta di stranieri, siano forzati ad emigrare abbandonando i loro beni, o ridotti a suggellare con la loro adesione lo stabilirsi della comunit� universale�10 (si ride).
Un rappresentante � Eccoci a quel punto!
Il cittadino de Tocqueville � Ecco, signori, il programma di Babeuf; io desidero con tutto il cuore che esso non sia quello della Repubblica di Febbraio; no, la Repubblica di Febbraio deve essere democratica, ma non deve essere socialista...
Una voce a sinistra � S�! (no! No! � interruzione).
Il cittadino de Tocqueville � E se non � socialista, cosa sar�?
Un membro a sinistra � Realista!
Il cittadino de Tocqueville � (voltandosi da quella parte) Pu� darsi lo diventi, se si lascia fare a voi (vive approvazioni), ma non lo diventer�.
Se la Rivoluzione di Febbraio non � socialista, cosa sar�? Essa � forse, come molti dicono e credono, un puro accidente? Non dovr� essere che un semplice cambiamento di persone o di leggi? Non lo credo.
Quando, lo scorso gennaio, io dicevo, in seno alla Camera dei deputati, in presenza della maggioranza di allora, che mormorava su questi banchi, per motivi diversi, ma esattamente come si mormorava or ora su questi... (molto bene! molto bene!) (L�oratore indica la sinistra).
Io le dicevo: state in guardia, il vento delle rivoluzioni si � alzato non lo sentite? Le rivoluzioni si avvicinano, non le vedete? Noi siamo su un vulcano. Ecco cosa dicevo; il �Moniteur� ne fa fede. E perch� lo dicevo?... (interruzione a sinistra).
Avevo la debolezza di spirito di credere che le rivoluzioni si avvicinavano, perch� questo o quell�uomo erano al potere, perch� questo o quell�incidente della vita politica agitava un istante il paese? No, signori. Ci� che mi faceva credere che le rivoluzioni si stavano avvicinando, ci� che, in effetti, ha prodotto la rivoluzione era questo: mi accorgevo che, derogando profondamente ai pi� sacri princ�pi che la Rivoluzione francese aveva sparso nel mondo, il potere, l�influenza, gli onori, la vita, per cos� dire, erano stati rinserrati nei ristrettissimi limiti di una sola classe, di modo che non vi era alcun paese al mondo che presentasse un aspetto simile; anche nell�aristocratica Inghilterra, in questa Inghilterra che allora avevamo cos� spesso il torto di prendere ad esempio e a modello; nell�aristocratica Inghilterra il popolo aveva una parte, se non completamente diretta, almeno considerevole, per quanto indiretta, agli affari; se non votava (e votava spesso), faceva almeno sentire la sua voce; faceva conoscere la sua volont� ai governanti; era da essi sentito e li sentiva
Qui, nulla di simile. Lo ripeto: tutti i diritti, tutto il potere, tutta l�influenza, tutti gli onori, la vita politica tutta intera, erano racchiusi nel seno di una classe politica estremamente ristretta, e al di sopra, nulla!
Ebbene! ecco ci� che mi faceva credere che la rivoluzione fosse alle porte. Vedevo che, nel seno di questa piccola classe privilegiata, succedeva ci� che alla lunga sempre accade nelle piccole aristocrazie esclusive, succedeva che la vita pubblica si spegneva, che la corruzione guadagnava terreno ogni giorno, che l�intrigo prendeva il posto delle virt� pubbliche, che tutto rimpiccioliva, si deteriorava.
Ci� per quanto riguarda le classi superiori.
Che avveniva in quelle inferiori? Pi� in basso di quello che si chiamava allora il paese legale, il popolo propriamente detto, il popolo che era meno maltrattato di quanto si dica (bisogna essere giusti soprattutto verso le potenze decadute), ma al quale si pensava troppo poco; il popolo che viveva, per cos� dire, al di fuori di ogni movimento ufficiale, si faceva una vita propria: distaccandosi sempre pi� nello spirito e nel cuore da quelli che si riteneva lo dovessero guidare, offriva il suo spirito e il suo cuore a quelli che erano naturalmente in rapporto con lui, e molti di costoro erano questi vani utopisti di cui ci stiamo occupando, oppure dei pericolosi demagoghi.
� perch� vedevo queste due classi, l�una piccola, l�altra numerosa, separarsi poco a poco l�una dall�altra; l�una piena di gelosia, di sfiducia, di collera, l�altra di noncuranza, e qualche volta di egoismo e di insensibilit�, perch� vedevo queste due classi marciare isolatamente in direzione opposta, che dicevo, che avevo il diritto di dire: il vento della rivoluzione si sta levando, ben presto si avr� la rivoluzione (molto bene!).
� per compiere qualcosa di simile a questo che si � fatta la Rivoluzione di Febbraio? No, signori, non lo credo; come ciascuno di voi, credo il contrario, voglio il contrario, lo voglio non solo nell�interesse della libert�, ma anche nell�interesse della sicurezza pubblica.
Non ho lavorato io, non ho il diritto di dirlo, non ho lavorato alla Rivoluzione di Febbraio, lo ammetto; ma una volta che questa Rivoluzione si � fatta, voglio che sia una rivoluzione seria, perch� voglio che sia l�ultima. So che non vi sono che le rivoluzioni serie che siano capaci di durare; una rivoluzione che non produce nulla, che � colpita da sterilit� fin dalla nascita, che non fa nascer nulla dai suoi fianchi, non pu� servire che a una cosa sola, a far nascere altre rivoluzioni che la seguiranno (approvazioni).
Voglio dunque che la Rivoluzione di Febbraio abbia un senso, un senso chiaro, preciso, percettibile, che rifulga all�esterno, che tutti possano vedere.
E quale � tale senso? Lo indico in due parole: la Rivoluzione di Febbraio deve essere la vera continuazione, la reale e sincera esecuzione di ci� che la Rivoluzione francese ha voluto; deve essere la messa in opera di ci� che i nostri padri non avevano che pensato (vivi consensi).
Il cittadino Ledru-Rollin � Domando la parola.
Il cittadino de Tocqueville � Ecco ci� che la Rivoluzione deve essere, n� pi�, n� meno. La Rivoluzione francese aveva voluto che non vi fossero pi� classi che non ve ne fossero nella societ�, essa non aveva mai avuto l�idea di dividere i cittadini, come voi fate, tra proprietari e proletari. Non troverete queste parole cariche di odio e di guerra in alcuno dei grandi documenti della Rivoluzione francese. La Rivoluzione ha voluto che, politicamente, non vi fossero pi� classi; la Restaurazione, la Monarchia di Luglio hanno voluto il contrario. Noi dobbiamo volere ci� che hanno voluto i nostri padri.
La Rivoluzione aveva voluto che le cariche pubbliche fossero uguali, realmente uguali per tutti i cittadini: ma su questo scoglio si � arenata. Le cariche pubbliche sono rimaste, in certe parti, ineguali: dobbiamo far s� che esse siano uguali; anche su questo punto dobbiamo volere ci� che i nostri padri hanno voluto ed eseguire ci� che essi non hanno potuto eseguire (molto bene!).
La Rivoluzione francese, ve l�ho gi� detto, non ha avuto la ridicola pretesa di creare un potere sociale che facesse direttamente da solo la fortuna, il benessere, l�agiatezza di ogni cittadino, che sostituisse la assai contestabile saggezza dei governi alla saggezza pratica ed interessata dei governati; essa ha creduto che fosse sufficiente per adempiere al suo compito dare ad ogni cittadino lumi e libert� (molto bene!).
Essa ha avuto questa forma, questa nobile, questa orgogliosa fede che non sembra voi abbiate, che sia sufficiente all�uomo coraggioso ed onesto avere queste due cose, lumi e libert� per non dover domandare altro a quelli che lo governano.
Questo � ci� che la Rivoluzione ha voluto; essa non ha avuto n� il tempo, n� i mezzi per farlo. Noi dobbiamo volerlo e farlo.
Infine, la Rivoluzione francese ha avuto il desiderio, ed � questo desiderio che l�ha resa non solo sacra, ma santa agli occhi dei popoli, ha avuto il desiderio di introdurre la carit� nella politica; ha concepito dei doveri dello Stato verso i poveri, verso i cittadini che soffrono, una idea pi� estesa, pi� generale, pi� alta di quanto non si fosse avuto prima. � questa idea che dobbiamo riprendere, non, lo ripeto, mettendo la preveggenza e la saggezza dello Stato al posto della preveggenza e della saggezza individuali, ma venendo realmente, efficacemente, coi mezzi che lo Stato possiede, in soccorso di tutti coloro che soffrono, in soccorso di tutti quelli che, terminata ogni loro risorsa, sarebbero ridotti alla miseria se lo Stato non tendesse loro la mano.
Ecco cosa ha voluto fare la Rivoluzione francese; ecco ci� che dobbiamo fare noi stessi.
Vi � socialismo in questo?
Una voce a sinistra � S�! S�! Ve ne �.
Il cittadino de Tocqueville � No! No! No, non vi � socialismo, vi � carit� cristiana applicata alla politica; non vi � nulla... (interruzione).
Il cittadino presidente � Voi non vi capite; � chiaro come il giorno; non siete dello stesso parere; salirete alla tribuna, ma non interrompete.
Il cittadino de Tocqueville � Non vi � nulla che dia ai lavoratori un diritto sullo Stato, non vi � nulla che forzi lo Stato a mettersi al posto della previdenza individuale, al posto dell�economia, dell�onest� individuale; non vi � nulla che autorizzi lo Stato ad intromettersi nell�industria, ad imporre dei regolamenti, a tiranneggiare l�individuo per governarlo meglio o, come isolatamente si pretende, per salvarlo da se stesso; non vi � nulla tranne che del Cristianesimo applicato alla politica.
S�, la Rivoluzione di Febbraio deve essere cristiana e democratica; ma non deve essere socialista. Queste parole riassumono tutto il mio pensiero e termino pronunciandole (molto bene! molto bene!).
(A. De Tocqueville, Scritti politici, I, cit., pp. 281-294).
1 Era in discussione la proposta fatta da Mathieu de la Dr�me di emendare il paragrafo 8 del preambolo della Costituzione, proclamando esplicitamente il �diritto al lavoro�. Tocqueville pronunci� questo discorso all�Assemblea costituente il 12 settembre 1848, e l�emendamento venne respinto il 14 con 396 voti contro 187.
2 La Commissione incaricata di stendere la Costituzione, della quale il Tocqueville era membro.
3 Non � facile identificare gli autori di queste due affermazioni. La prima esprime un concetto ricorrente in autori come Alphonse Esquiros (1814-1876), che nel 1840 pubblic� L��vangile du peuple, o come Alphonse Constant (1816-1875), che nel 1841 pubblic� La Bible de la libert�; ma il tema si trova anche in Charles Fourier che, nel Nouveau monde industriel et soci�taire (1829), distingue le passioni dell�anima e quelle della carne.
La seconda risale, forse, ancora al Fourier, e alla sua Th�orie de l�unit� universelle.
4 Si tratta di un�affermazione delle correnti eredi del Babeuf, le quali agivano a Parigi verso il 1840, con la quale si contrapponevano al ben noto principio dei sansimoniani: �A ciascuno secondo le sue capacit�, a ogni capacit� secondo il suo rendimento�.
5 Forse Fran�ois-No�l Babeuf (cfr. pi� avanti nota 8); ma la tesi era gi� stata sostenuta per la prima volta dal Morelly nel suo Code de la nature (1755).
6 Quasi certamente Pierre-Joseph Proudhon, che popolarizz� questa formula nel suo Qu�est-ce que la propriet�? (1840); ma l�affermazione era gi� stata fatta da Jacques Pierre Brisset de Warville (1754-1793) in Sur la propri�t� et sur le vol (1782).
7 Maximilien Robespierre, Discours sur la Constitution, 10 maggio 1793, in: Oeuvres, IX, Paris 1958, pp. 501-502.
8 Fran�ois-No�l Babeuf (1760-1797), rivoluzionario francese, direttore del giornale Le Tribun du Peuple. Dopo il Termidoro si mise a capo del movimento che voleva spingere la rivoluzione sino a conclusioni comunistiche, ma la �congiura degli eguali� fall�, e il Babeuf venne condannato a morte.
9 Filippo Buonarroti (1761-1837), rivoluzionario di origine italiana. Collabor� con Babeuf nell�organizzare la �congiura degli eguali�; dopo tre anni di carcere, emigr� in Svizzera poi in Belgio ove pubblic� la Conspiration pour l��galit� dite de Babeuf; Bruxelles 1828.
10 Cfr. F. Buonarroti, Conspiration pour l��galit� dite de Babeuf, Bruxelles, 1828 (trad. it., Torino 1946, p. 197), ma la citazione del Tocqueville non � del tutto testuale.
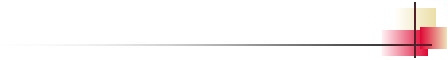
vai indietro