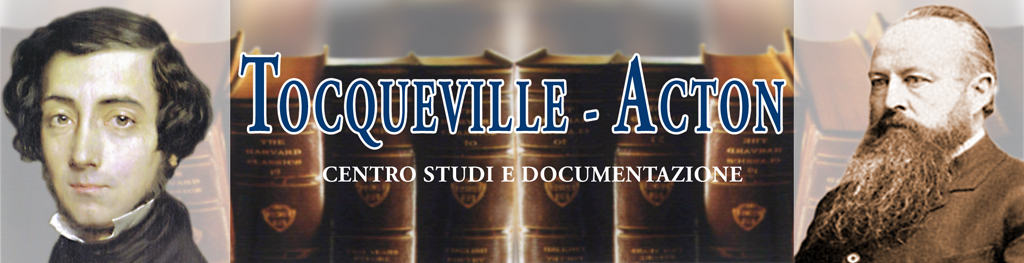
![]() O. Bazzichi,
Il Concilio
Vaticano II: Punto Di Svolta Della DSC
O. Bazzichi,
Il Concilio
Vaticano II: Punto Di Svolta Della DSC
![]() M. Tringali,
Antonio Rosmini e il Marchese Gustavo Benso di Cavour
M. Tringali,
Antonio Rosmini e il Marchese Gustavo Benso di Cavour
![]() P. Zanotto,
Liberalismo e tradizione cattolica.
Osservazioni critiche su Juan de Mariana (1535-1624)
P. Zanotto,
Liberalismo e tradizione cattolica.
Osservazioni critiche su Juan de Mariana (1535-1624)
vai indietro
Il Concilio Vaticano II: Punto Di Svolta Della DSC
di O. Bazzichi
Sono passati quarant�anni dall�inizio del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962). La domanda che sorge quando ci si sofferma sul quarantennio �: quale influsso, in questo periodo di tempo, ha avuto sulla vita della Chiesa? La risposta � semplice : il Concilio ha costituito una svolta storica nella vita della Chiesa non solo dal punto di vista teologico e pastorale, ma anche per quanto riguarda la DSC(1).
1-Punto di arrivo e punto di partenza
Il Concilio Vaticano II � penetrato in profondit� nel mondo e nel nostro tempo, e le sue ripercussioni, nonostante siano trascorsi quarant�anni, sono tutt�altro che esaurite.
Se la Chiesa oggi pu� rivendicare le esigenze della pace e della giustizia, lo pu� perch� erede e custode di un Concilio ecumenico che ha proclamato la libert� di tutti gli uomini, uguali davanti a Dio creatore e uguali nel poter decidere il proprio destino.
Oggi, infatti, � diventata pi� chiara questa scelta antropologica compiuta dalla Chiesa. Fu una scelta profetica -occorre sottolinearlo - le cui fondamenta furono gettate in quella lontana mattina dell�11 ottobre 1962, con un discorso di un Papa ottuagenario, minato irreparabilmente da un male terribile, ma capace di intuire profeticamente e indicare le nuove vie che la Chiesa avrebbe dovuto percorrere. Accanto al mondo, nel mondo, con l�uomo e al servizio dell�uomo.
A quarant�anni di distanza , dopo i documenti conciliari che si riferiscono al dialogo della Chiesa con il mondo- dalla Dichiarazione �Nostra Aetate� sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane(promulgata il 28 ottobre 1965) alla Dichiarazione�Dignitatis Humanae� sulla libert� religiosa (promulgata il 7 dicembre 1965), dalla Dichiarazione �Humanitatis Redintegratio� sull�ecumenismo(promulgata il 21 novembre 1964) alla Costituzione pastorale �Gaudium et spes� sul dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo (promulgata il 7 dicembre 1965), dalla Costituzione dogmatica �Lumen Gentium� sulla Chiesa (promulgata il 21 novembre 1964) al Decreto �Inter Mirifica� sui mezzi di comunicazione di massa (promulgato il 4 dicembre 1963) dal Decreto �Apostolicam Actuositatem� sull�apostolato dei laici (promulgato il 18 novembre 1965) alla Dichiarazione �Gravissimum Educationis� sull�educazione cristiana (promulgata il 28 ottobre 1965)- � ancora urgente l�analisi e l�approfondimento biblico, storico, filosofico, sociologico e teologico sui contenuti e le risposte del �depositum fidei� alle domande che salgono dall�umanit�.
Abbiamo voluto elencare alcuni dei pi� importanti documenti del Concilio perch� abbiamo avuto l�impressione che per molti cattolici di oggi essi siano poco apprezzati o addirittura sconosciuti. Questo impedisce di vedere e valutare i significativi cambiamenti da essi introdotti nella vita della Chiesa. In realt�, soltanto chi conosce come era la Chiesa prima del Concilio e quanto complesso e difficile sia stato il travaglio dei lavori conciliari pu� rendersi conto del rinnovamento avvenuto nella Chiesa Cattolica nei quarant�anni passati dall�apertura del Concilio.
Oggi uno dei temi pi� impellenti della teologia riguarda la funzione delle religioni, di tutte le religioni, nella storia della salvezza. E� questo, in un mondo globalizzato, il grande problema del nostro tempo:dove e come ci liberiamo e ci salviamo? In realt�, dopo il Concilio Vaticano II, la teologia si � interrogata sull�uomo nel mondo e nel tempo, sull�uomo che crede e su quello che non crede. Tuttavia, non avrebbe potuto parlare dell�uomo senza fare riferimento a Cristo uomo-Dio, il quale � la chiave che apre e svela la verit� dell�uomo. E non potrebbe essere altrimenti , dal momento che � stato l�approccio cristologico del Concilio a portare la teologia a convergere sull�aspetto antropologico.(2)
Il riconoscimento ufficiale di questo metodo antropologico e cristologico � espresso chiaramente e ripetutamente nei documenti conciliari. Per la Costituzione �Dei Verbum� sulla rivelazione, il Cristo � allo stesso tempo mediatore, pienezza e segno della rivelazione (n.4). Per la Costituzione �Lumen Gentium�, il Cristo � �luce dei popoli�, mentre la Chiesa � �in Cristo�, sacramento primordiale, �segno e strumento dell�unione con Dio e dell�umanit� di tutto il genere umano�(n.1). La Costituzione �Gaudium et Spes� dichiara che �solamente nel mistero del Verbo Incarnato trova vera luce il mistero dell�uomo�(N.22).
Il Decreto �Unitatis Redintegratio� propone �il ristabilimento dell�unit� fra tutti i cristiani� sia dell�area del protestantesimo sia dell�area dell�ortodossia(n.1). La Dichiarazione�Nostra Aetate�apprezza ci� che c�� di �vero e santo nelle religioni non cristiane�. Il Concilio ,perci�, facendo proprie�le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d�oggi�, si sente �realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia�(n.1) e desidera instaurare con l�umanit� un �dialogo�sui grandi problemi umani, �arrecando la luce che viene dal Vangelo�, allo scopo di �salvare le persone umane e di rinnovare l�umana societ�� (N.3). Sulla scia del Concilio ,l�enciclica �Redemptor Hominis� (1979), carta dell�uomo nuovo in Cristo, propone questi come�il centro del cosmo e della storia�, come il �Redentore dell�uomo e del mondo�(n.1).
2-Confronto della Chiesa con le �realt� temporali� attraverso l�apporto dei laici.
Il Concilio Vaticano II si pu� denominare anche �Concilio dei laici�, perch� ha indicato chiaramente il loro posto e ruolo essenziale nella Chiesa e si � sforzato di svegliare questo �popolo di Dio � che dormiva, dandogli la coscienza viva di essere Chiesa .
Prima del Concilio, era l�aspetto gerarchico quello che emergeva nella Chiesa , tanto che, quando ci si riferiva alla Chiesa, molti intendevano la �gerarchia�. In tale mentalit�, i laici si trovano emarginati ; non costituivano la Chiesa; erano ridotti a soggetti passivi nei quali non appariva n� la dignit� cristiana n� la libert� di figli di Dio(3).
Il Concilio ha decisamente rifiutato queste mentalit� quando a scelto l�ordine dei capitoli nella Costituzione Dogmatica sulla Chiesa �Lumen Gentium�. Infatti, dopo il primo capitolo sul �popolo di Dio�, capitolo che non era stato previsto nello schema iniziale. In questo capitolo viene inserito il �sacerdozio comune�, il quale ha la precedenza sul sacerdozio gerarchico; inoltre viene affermato che il �popolo di Dio�nel suo insieme ha il senso della fede e �non pu� sbagliarsi nel credere�; l�infallibilit� del popolo di Dio si trova quindi espressa prima che venga affermata l�infallibilit� dei vescovi uniti al Papa e l�infallibilit� stessa del Papa.
Con questa scelta significativa il Concilio ha relegato ad un posto meno vistoso l�aspetto gerarchico della Chiesa , per mettere al primo posto la realt� della comunicazione ecclesiale e della partecipazione di tutti alla vita della Chiesa. Questa visione riveste un�importanza enorme per la teologia cattolica, dando un vigoroso impulso simultaneamente al dinamismo di comunione e allo spirito di servizio. Anche il Codice di di diritto canonico ha seguito accuratamente l�orientamento del Concilio(4).
In quale contesto di rapporto fra la Chiesa e societ� si situa oggi l�impegno dei laici? Sviluppare questo tema significherebbe condurre un�approfondita analisi della dinamica della societ� italiana e della particolare forma di presenza che al suo interno realizza la Chiesa; compito in questa sede impossibile. Baster� dunque accennare ad alcune coordinate generali.
In questi ultimi decenni, dopo il Concilio ,l�ottica complessiva che si presenta � quella generale del �confronto�: non nel senso della semplice constatazione che la societ� � in continuo cambiamento, ma sul senso specifico della percezione dell�accelerazione del mutamento e della modernizzazione, per effetto dello sviluppo tecnologico. Non � sufficiente dire che la �societ� industriale� � alle nostre spalle e che ormai viviamo in una nuova societ� chiamata, con definizione di comodo, �post-industriale�(5).
Tra le ripercussioni , vaste e profonde , di questo processo di cambiamento del sistema economico, segnaliamo quelle che maggiormente hanno inciso nella societ�, determinando analisi e proposte da parte della DSC.
a- La societ� post-industriale � caratterizzata dal progressivo venir meno della �comunit� di lavoro�, in quanto il rapporto prevalente � quello che si stabilisce tra l�operatore e il computer . Da ci� ne deriva una ulteriore spinta all�individualismo e la tendenza, evidenziata dallo smodato utilizzo consumistico dei mass media, a ridurre al minimo i rapporti sociali . In questo contesto la Chiesa , per continuare la sua evangelizzazione , si propone come �comunit��, come luogo di rapporti profondi interpersonali e intrafamiliari.
b- La societ� post-industriale � contraddistinta da un progressivo restringimento , quantitativo e anche qualitativo, della vita di relazione interpersonale, fenomeno di cui il declino demografico e la limitazione delle nascite costituiscono la verifica statistica. In questa sorta di deserto di vita di relazione, in cui ciascuno si sente sempre pi� solo con se stesso, si aprono vari spazi di quella che potrebbe essere chiamata la �pastorale della solitudine�.
c- La societ� post-industriale ha messo in crisi le ideologie che cos� negativamente hanno inciso sul rapporto tra Chiesa e mondo moderno; ma dalle rovine delle ideologie � seguito il vuoto , o meglio ,le ideologie deboli del consumismo , dell�edonismo, dell�indifferenza , e il declino dei valori(6).
d- La societ� post-industriale, infine , mette in discussione non solo l�effetto principale della secolarizzazione, cio� l�esclusione della religione dalla sfera pubblica, ma il ruolo stesso della Chiesa nella societ� e conseguentemente la legittimit� stessa dell�opzione dell�uomo per una realt� trascendente.
Nell�attuale crisi delle grandi ideologie e di fronte ai mutamenti in atto nel mondo, in particolare per quanto riguarda la politica, l�economia, la cultura e i valori , la Chiesa si trova in una posizione di particolare rilievo, quale punto di riferimento per dare indicazioni sul futuro colmo di incognite. Scruta e legge i �segni dei tempi� e indica gli elementi teologici riguardanti il rapporto tra Dio e storia umana , tra salvezza eterna e progresso del mondo, tra speranza escatologica e speranze storiche umane. In questa lettura dei tempi il Magistero sociale della Chiesa ha bisogno delle professionalit� dei laici. Nella comunit� cristiana dovr� accreditarsi sempre pi�, tra i laici , l�impegno �politico� in senso ampio, l�impegno nella �polis� . Da parte del Magistero Ecclesiastico dovr� esserci coscienza e coerenza dei rischi che eventualmente si correranno lasciando libert� di vedute nella ricerca e nelle proposte, ma ne guadagner� in efficacia; si tratta di passare dalle proclamazioni e enunciazioni di principio ai processi ed alla prassi(7).
3-Nuove frontiere della DSC: la svolta della Costituzione �Gaudium et Spes�
Tra le quattro Costituzioni del Concilio la pi� conosciuta � la �Gaudium et Spes�, con cui la Chiesa si apre al mondo contemporaneo, chiudendo un periodo di rottura e di conflitto che, iniziato due secoli prima, si � a mano a mano aggravato successivamente con il �Sillabo dei principali errori della nostra epoca�, pubblicato nel 1864 in appendice all�Enciclica di Pio IX �Quanta Cura�, e avviando con tutti gli uomini un dialogo sugli interrogativi che oggi angustiano il mondo moderno.
Il cammino della DSC � un importante capitolo di questo lento e progressivo confronto con la modernit�, non pi� in termini di opposizione, ma di dialogo. Ripercorrerlo equivale a ricostruire una serie di cruciali momenti del rapporto tra Chiesa e modernit�(8).
Nella �Gaudium et Spes�, dunque , la chiesa espone il proprio pensiero sull�uomo, sulla dignit� della persona umana, sul peccato, sulla dignit� della coscienza morale, sull�eccellenza della libert�, sul mistero della morte, sull�ateismo, <<che va annoverato tra i fatti pi� gravi del nostro tempo>> (n.19)., in quanto mette in questione la dignit� dell�uomo che ha il suo apice nella comunione con Dio(n. 21). Tratta poi lungamente della comunit� degli uomini, dell�attivit� umana nell�universo e del suo valore, dell�aiuto che la Chiesa pu� dare sia ai singoli uomini , sia alla societ� umana, e dell�aiuto che la Chiesa pu� ricevere dal mondo contemporaneo. Infine, nella seconda parte della Costituzione , sono affrontati cinque <<problemi pi� urgenti>>: il matrimonio e la famiglia; la cultura umana; la vita economico-sociale; la solidariet� tra le nazioni e la pace. In tal modo, con la �Gaudium et Spes� il Concilio mostra la profonda preoccupazione della Chiesa per il mondo e per i suoi problemi.
Pertanto il punto di partenza � stato quello di applicare felicemente l�idea dei �segni dei tempi� di Giovanni XXIII: vedere , cio�, quello che abbiamo in comune prima di considerare quello che ci divide. Gi� le parole dell�esposizione introduttiva caratterizzano questa visione fondamentale di solidariet� fra tutti gli uomini nella gioia e nella speranza, nelle afflizioni e nelle angosce.
Tema centrale della Costituzione � il campo straordinariamente vasto, di ci� che i cristiani hanno in comune con tutti gli uomini: l�essere e l�agire nel mondo, l�aspirazione comune di edificare un mondo terreno di vera fraternit� e progresso, le attivit� economiche , sociali culturali, la comune relazione con gli ordinamenti fondamentali dell�esistenza, quali il matrimonio e la famiglia, lo stato e la comunit� dei popoli.
Il tentativo di presentare qui , anche solo per accenni, tutti i temi trascenderebbe di gran lunga i limiti di sintesi di questo lavoro. D�altra parte , data l�ampiezza del testo e dei problemi da affrontare , sar� sufficiente delineare le tematiche fondamentali nelle quali , in certo modo potranno apparire chiari il procedimento della costituzione, il suo modo di discutere e di affrontare i problemi, di entrare negli interrogativi dell�uomo moderno.
Va comunque tenuto presente che ogni affermazione pu� essere compresa in tutto il suo senso , solo se collocata nel pi� ampio quadro della vocazione totale dell�uomo che, creato ad immagine e somiglianza di Dio, decide della sua sorte eterna durante il pellegrinaggio terreno.
L�insegnamento della �Gaudium et Spes� in campo economico e sociale � esposto nel capitolo terzo della seconda parte.Il capitolo che ha per titolo�vita economico-sociale� � formato da un introduzione (n. 63) nella quale si presenta la problematica reale della vita economica contemporanea nei suoi aspetti positivi e negativi , e di due sezioni: la prima (n. 64-66) analizza i problemi propri dello sviluppo economico, la seconda (n. 67-72) �alcuni principi relativi all�insieme della vita economico-sociale�.
Questi temi sono strettamente collegati con l�ultima sezione dell�ultimo capitolo che tratta della cooperazione internazionale e dello sviluppo universale (n . 82-90).
Le principali idee espresse in questo capitolo sono:
- il Concilio accetta il progresso tecnico ed economico , come un bene , perch� crea possibilit� pi� favorevoli per lo sviluppo materiale, intellettuale culturale, e religioso dell�uomo. Per raggiungere tale scopo , il progresso deve tuttavia rimanere sotto il controllo dell�uomo;
- il processo economico deve essere ordinato in armonia con la dignit� dell�uomo lavoratore. Per questo la vita economica dovr� essere organizzata in maniera che tutti, secondo la posizione di ciascuno, possano partecipare attivamente alla vita delle imprese e alle decisioni della produzione economica nazionale;
- i beni terreni sono destinati all�uso di tutti gli uomini;
- la propriet� privata , bench� la sicurezza sociale copra un certo grado di rischio economico-sociale, rimane necessaria anche alla grande massa della popolazione operaia , in quanto garantisce ad essa una certa misura di libert� e di responsabilit� economica;
- i paesi ricchi hanno lo stretto dovere di aiutare i paesi poveri, affinch� anch�essi possano raggiungere un pi� alto livello di vita. Ma le nazioni in via di sviluppo dovranno aiutarsi per conto loro, dovranno valorizzare pienamente ogni loro risorsa, la propria cultura e le proprie tradizioni. Le nazioni pi� favorite dovranno cooperare al raggiungimento di questi obiettivi , senza abusare n� della ricchezza n� della potenza di cui dispongono. E poich� si tratta di giustizia , toccher� alla Comunit� internazionale emanare regole e norme, che prevengano le ingiustizie e siano atte a tutelare le iniziative dei paesi membri e a coordinare il perseguimento del bene comune.
Come si vede , rispetto alla DSC precedente, pi� esplicita e impegnativa viene presentata la dottrina della destinazione dei beni terreni. Nuova ci sembra la trattazione sulla propriet� privata. Dalla �Rerum Novarum� alla�Gaudium et Spes� l�insegnamento sulla propriet� si � andato progressivamente integrando e adeguando alle condizioni storiche. Cos� si � assistito alla messa in risultato della sua funzione sociale, alla legittimit� della propriet� pubblica di grandi mezzi di produzione e al conseguente principio di sussidiariet� , alla fine della destinazione universale e comunitaria dei beni e al diritto primordiale dell�uso dei bendi stessi da parte di tutti,all�importanza crescente dei moderni sistemi d sicurezza sociale e delle capacit� professionali come garanzie per la sicurezza personale ( e quindi minore necessit� del possesso della terra), al diritto di tutti a partecipare alla vita dell�azienda e dell�iniziativa economica.
Tuttavia fino a Giovanni XXIII � costante l�affermazione della naturalit� del diritto di propriet� privata dei beni di produzione , anche ammettendo l�esigenza di partecipazione alle responsabilit� della vita dell�azienda e allo sviluppo economico. La �Gaudium et Spes� adopera invece un linguaggio pi� aperto e contiene un significativo silenzio sulla naturalit� del diritto di propriet� privata , soprattutto in riferimento ai grandi mezzi di produzione. Infatti, la costituzione, dopo aver sottolineato la destinazione dei beni della terra a tutti gli uomini, e la necessit� che le forme concrete di propriet� obbediscano a queste finalit�, afferma:
�Poich� la propriet� privata e le altre forme di potere privato contribuiscono all�espressione della persona e inoltre danno occasione all�uomo di esercitare il suo responsabile apporto nella societ� e nell�economia � di grande interesse favorire l�accesso di tutti , individualmente o in gruppo, a un certo potere sui beni esterni. La propriet� privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno una zona indispensabile di autonomia personale e familiare e devono considerarsi come prolungamento necessario della libert� umana�.(n.71)
Per quanto riguarda il linguaggio si rileva l�estrema cautela e apertura della terminologia: accanto al termine possesso si adopera quello di dominium, ossia di potere sui beni. La nozione di propriet� tende cos� a diventare �analoga� e andrebbe sempre pi� sostituita con quella del dominio sui beni, potere sui beni, che esprime meglio il diritto naturale della persona , che si pu� concretizzare in varie forme individuale o collettive. In tal modo la costituzione rende pi� generico il concetto di propriet� privata di cui afferma la necessit�, in modo che possa prestarsi a diverse interpretazioni. Il Concilio davanti ad un problema di grande complessit� ha preferito tenere una posizione di grande prudenza, lasciando possibilit� pi� ampie.
E� chiaro quindi che esso si � astenuto dall�affermare che la propriet� privata dei mezzi di produzione sia una esigenza positiva e inderogabile dell�ordine etico-soggettivo. E non mette qui conto ritornare su di essa. Essa sembra un punto accolto e condiviso da diversi autori. Tuttavia il Concilio neanche l�esclude, anzi parla di un contesto in cui non esiste la propriet� privata dei mezze di produzione.
Ci� che pi� importa rilevare � la prospettiva etica di fondo, originaria, su cui va misurato ogni sistema di possesso di beni, in condizioni di dignit� per la persona umana. E� questa la priorit� da affermare in modi e forme, che permettono l�esercizio della responsabilit� e dell�iniziativa e tutti gli appartenenti al processo produttivo. E questa partecipazione di carattere personale al dominio sui beni si pu� realizzare non solo in forma di propriet� privata in senso stretto, ma anche in forme adeguate di potere collettivo.
Perci� il problema � come si pu� dare a tutti , nella moderna economia industriale e tecnologica, una partecipazione veramente personale nel dominio degli strumenti di produzione che sono destinati a tutti gli uomini in quanto persone. La vita � cos� aperta alla ricerca di strutture industriali pi� umanizzanti e al servizio della crescita di tutti.
Perci�, se � vero che le realt� temporali (la politica, l�economia, la cultura, la scienza e la tecnica) hanno fini, valori e strumenti propri, che quindi � secondo la stessa volont� del Creatore - vanno rispettati nella loro�laicit��,allora dalla fede non si pu� dedurre un determinato modello �cattolico� politico o sociale, ma la DSC pu� e deve ispirare modelli diversi. In questo modo la Chiesa non si pone sullo stesso piano degli Stati, ma �in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunit� politica e non � legata ad alcun sistema politico�, poich� �� il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana� (Gaudium et Spes n . 76).
Ad un osservatore superficiale, che legge queste pagine, potrebbe sembrare ormai esaurita la funzione storica del Magistero sociale della Chiesa , dopo che le minacce arrecate alla fede ed alla morale dalle ideologie del liberalismo agnostico e del marxismo ateo sono decadute. Si tratterebbe ancora di un patrimonio, ideale importante ma solo ai fini storici.
In realt� non � cos�. E� vero che alcuni problemi , acutamente avvertiti all�epoca delle contrapposizioni ideologiche, possono considerarsi per lo pi� risolti: il riconoscimento da parte della Chiesa dei diritti umani(9),il valore della democrazia e del pluralismo (10), le potenzialit� dell�economia di mercato(11); ma , oggi, a minacciare il futuro dell�uomo ci sono nuove problematiche, che richiedono l�urgente e necessaria ripresa di riflessione da parte della DSC. Qui le richiamiamo soltanto: la qualit� della democrazia , in relazione ai temi della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; il controllo del processo di globalizzazione attualmente in corso; il problema della violenza, del terrorismo, della guerra e della pace.
Sono queste le nuove frontiere e le sfide che interpellano la DSC nel terzo millennio.
NOTE
- Per una ricostruzione essenziale di questo cammino, cfr. B. SORGE, A quarant�anni dal Concilio II, In �aggiornamenti Sociali�, 9-10 (2002) 621-626; Attualit� del Concilio Vaticano II, editoriale in �LA civilt� Cattolica� , IV (2002) 425-438.
-
Per un ritratto essenziale del Concilio nella sua fisionomia
semplice, concreta e fondamentale, espresso dai suoi molteplici documenti,
cfr. L. BETTAZZI, Il Concilio Vaticano II, QuerinianaueQQ, Brescia,
2000.
Per rivedere direttamente , passo dopo passo , le vicende che hanno accompagnato i lavori del Concilio, cfr. Y. CONGAR, Mon Journal Du Concile, 2 voll., Cerf , Paris 2002.
Per un bilancio approfondito dei percorsi della riforma post-conciliare, nelle sue acquisizioni fondamentali cos� come nelle sue incertezza, cfr. AA. VV. , A trent�anni dal Concilio , a cura di C.GHIDELLI, Edizioni Studium ,Roma 1996. - Per approfondire l�aspetto antropologico nella teologia post-conciliare, cfr. M. FLICK- Z. ALSZEGHY, Fondamenti di una antropologia teologica , Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1969; B. MONDIN , Antropologia teologica, Edizioni Paoline, Alba 1977. R. BULTMANN, Credere e comprendere, Queriniana , Brescia 1977; J. B. METZ, Al di l� della religione borghese, Queriniana, Brescia 1981; O.BAZZICHI , Antropologia cristiana, ESA Editrice, Roma 1981; K. RAHNER- K. HEINZ WEGER, Problemi di fede della nuova generazione, Queriniana, Brescia 1982; L. MEDUSA, Chi � l�uomo? prospettive di antropologia soprannaturale, Edizioniueriniana, Bres Dehoniene, Napoli 1982.
- Gi� nel 1849 Antonio Rosmini aveva denunciato, come prima delle �cinque piaghe della Santa Chiesa � la �divisione del popolo dal clero�soprattutto nella liturgia e aveva auspicato un ritorno alla prassi della Chiesa primitiva, quella in cui �tutti i fedeli, clero e popolo, rappresentano e formano quell�unit� bellissima di cui ha parlato Gristo�. Cfr. A. ROSMINI, Delle cinque piaghe della S. Chiesa, a cura di A. VALLE, Citt� Nuova, Roma 1981, p.27 e 29.
- Nel nuovo codice di diritto economico, dopo un primo libro che esprime i principi generali, viene un secondo libro dal titolo �Il popolo di Dio�, diviso in due parti, la prima concerne i �Cristifideles�, la seconda riguarda la costituzione gerarchica della Chiesa. Nella prima parte sui �cristifideles� i fedeli laici precedeno il clero. Cfr. A.VANHOYER, Appunti sulla teologia del laico, in �La civilt� Cattolica� , IV (1997) 128-139. La letteratura ecclesiologica sul laicato � vasta. Per un inquadramento storico-teologico, cfr. Y. CONGAR, Per una teologia del laico, Marcelliana, Brescia 1967; G. REGNIER, L�apostolato dei laici, Edizioni Dehaniane, Bologna 1987; B. FORTE, Laicato e laicit�, Marietti, Genova 1981.
- Con il termine post-industriale s�intende quel processo di transizione , tuttora in corso, che, sotto la spinta di variabili tecnologiche, economiche e sociali sta alterando i connotati tipici della societ� industriale : predominio dell�attivit� di servizio, le conoscenze, la creativit�, l�informazione e la comunicazione. Cfr. AA. VV. , L�avvento post industriale, a cura di D. DE MASI, F. Angeli, Milano 1985; A. DETRAGIACHE , La nuova transizione. Dalla societ� industriale alla societ� dell�informazione, F. Angeli , Milano 1988; M. CROZIER, L�impresa in ascolto. Il management nel mondo post-industriale�, IL Sole 24 Ore, Milano 1990; E. GERELLI, Societ� post-industriale e ambiente, Laterza, Bari 1995.
- Cfr. l�Enciclica Centesimus annus, soprattutto n. 36 e 37.
- Cfr. O. BAZZICHI, Etica ed economia: dalla teoria ai processi, dal dibattito alla prassi, in �Studi Sociali�, 2(1991) 34-42.
- Per una ricostruzione essenziale di questo cammino, limitatamente ad alcune opere pi� recenti, cfr. R. BUTTIGLIONE, Dottrina sociale e modernit�, Piemme, Casale Monferrato 1993; A.F. UTZ, Dottrina sociale della Chiesa e ordine economico, Edizione Devoniane, Bologna 1993;M. COZZOLI, Chiesa, Vangelo e societ� , Edizioni Paoline, Cinesello 1996; B. SORGE, Per una civilt� dell�amore. La proposta sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 1996; J. MEJIA, Temi di dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Citt� del Vaticano 1996; P. DONATI, Pensiero sociale cristiano e societ� moderna, AVE, Roma 1997; M. TOSO, Umanesimo sociale della Chiesa, LAS, Roma 2001.
- Per un inquadramento concettuale del tema, Cfr. F. COMPAGNONI, I diritti dell�uomo , genesi, storia e impegno cristiano, Edizioni Paoline ,Cenisello 1995.
- Sul rapporto tra Stato, politica, democrazia e solidariet�, cfr. O BAZZICHI, Etica e politica, in �Studi Sociali�, 3 (1992) 29-42; M. TOSO, Centesimus Annus e politica, Ibid., 6 (1992) 24-39.
- Sul rapporto tra morale e sistema economico, cfr. . O BAZZICHI Etica e mercato, in �Studi Sociali�, 10 (1994) 24-27; M. TOSO, L�apparto dell�insegnamento sociale della Chiesa all�elaborazione dello Stato sociale e democratico, Ibid., pp.30-61.
Antonio Rosmini e il Marchese Gustavo Benso di Cavour
di M. Tringali
�Non so indurmi a collocare i professori Sciolla e Corte e il marchese Cavour fra i veri e pretti rosminiani. Mi ricordo ancora delle lunghe conversazioni avute col primo, e a costo di essere tassato di temerit�, debbo dire che tengo le sue dottrine pi� accordabili con le mie che non quelle del Rosmini. Diglielo da mia parte, e se ha un momento da perdere leggigli la presente. Sono sicuro che piglier� a buon verso la mia sincerit�; sapendo da quanto cordiale affezione e riverenza sia accompagnata. Quanto al Corte, la rara moderazione con cui egli si � accinto a riesaminare la questione, fa segno di un abito filosofico che risponde alla fama che suona di lui, e non all�esperienza che tengo dalla pi� parte dei Rosminiani. Lo stesso dico del Cavour, il cui libro � savio, moderato, bello, e sarebbe ancor pi� bello, se non fosse scritto in francese�[1].
Gioberti si riferisce nelle ultime righe al marchese Gustavo Benso di Cavour, fratello del pi� noto conte Camillo, e in particolare ai Fragmens Philosophiques che aveva scritto per contribuire alla diffusione e all�apologia delle dottrine rosminiane in Francia e in Svizzera. L�elogio del Gioberti risale al 1841. Come vedremo, nel corso di meno di due anni, il suo giudizio muter� radicalmente, in occasione della polemica con i discepoli di Rosmini, tra cui � da annoverare, come fa lo stesso Gioberti, il marchese Gustavo di Cavour. In questo nostro studio cercheremo di ricostruire i rapporti tra Rosmini e il marchese Gustavo Benso di Cavour, cogliendone i tratti pi� significativi, nella consapevolezza di trattare un�importante pagina della storia del rosminianesimo.
1) I fratelli Cavour
Gustavo Benso di Cavour nacque a Torino il 27 giugno del 1806 da Michele Antonio di Cavour e da Adele de Sellon[2]. Grande influenza esercitarono sulla sua formazione la madre, la nonna paterna, Filippina de Sales, i precettori di famiglia, l�abate Ferrero e il boemo Joseph Marechal, che insegn� a Gustavo il tedesco, e, a partire dal 1822, l�abate Giovanni Fr�zet, professore di francese, sotto la cui direzione apprese il latino, il greco e il diritto. Fin dalla tenera infanzia Gustavo dimostr� indole studiosa e riflessiva, mettendo in luce un temperamento assai diverso dal fratello, Camillo, in cui spiccava l�attitudine al commercio con gli uomini e col mondo. I carteggi familiari documentano l�interesse e l�amore di tutto il parentado verso i due fratelli, �[...] gi� allora diversi e tendenti a diventarlo sempre pi�, al punto che la differenza dei due temperamenti apparir� addirittura opposizione�[3]. Il rapporto tra i due fu �travagliato�: a volte legatissimi, specie nell�infanzia e nell�adolescenza, a volte divisi da furiosi contrasti, al limite del rancore. A sottolineare la diversit� di carattere e di interessi dei due fratelli, il padre Michele spesso soleva ripetere che tra i due suoi figli aveva diviso l�universo, essendo toccati i noumena a Gustavo e i phaenomena a Camillo[4]. Questi scriver� a diciotto anni allo zio de Sellon di aver ceduto largamente alla tentazione del gioco. Passer� dal gioco prediletto del goffo e del whist praticato nei salotti torinesi o parigini[5] a quello pi� grande e rischioso della borsa e degli affari. E al gioco si aggiunse, nella vita di Camillo, un�altra e pi� seducente tentazione, quella del gentil sesso. Queste debolezze mettevano in luce un profondo disagio psicologico. Camillo, infatti, avendo abbracciato fino a farli propri i valori liberali, nutriva profondamente il desiderio di emanciparsi dalla famiglia aristocratica, ancora legata al mondo della Restaurazione, i cui valori contrastavano con la sua vivace curiosit� intellettuale e con il suo spirito ribelle[6]. E allora �questo stato d�animo e le frequenti discussioni che ne derivavano non potevano non avere riflessi anche tra le pareti domestiche. Per il giovane Camillo le idee professate da uomini come l�absoulutiste d�Auzers erano letteralmente rivoltanti; e anche con gli altri parenti il contrasto di idee finiva per inasprire e rendere pi� difficili i rapporti personali. Solo col fratello Gustavo, fra le pareti di palazzo Cavour, Camillo riesce in questi anni a stabilire una piena intesa di affetti e di idee. Anche Gustavo, allora, e fino alla crisi che sar� determinata qualche anno dopo dalla prematura scomparsa della giovane moglie, segue orientamenti dichiaratamente liberali[7], � il confidente e il sostegno del pi� giovane fratello, [�]�[8]. Gustavo condivideva gli ideali politici improntati ad un moderato liberalismo. Ogni avvenimento politico che si verificava in Europa era oggetto di conversazione con Camillo[9]. Quando, ad esempio, cadde Don Carlos scrisse al fratello: �ecco una nuova vittoria delle idee costituzionali. Vuolsi egli ancora arrestare nel suo corso questo torrente irresistibile?�[10]
In Gustavo col tempo crebbe l�interesse per le lingue classiche e per gli studi giuridici e filosofici. Si laure� in giurisprudenza a Torino nel 1826 cum laude. Lo stesso anno spos� Adele Lascaris di Ventimiglia[11]. Nel periodo che va dal 1826 al 1833, anno in cui muore la moglie, Gustavo assimila idee liberali e un orientamento religioso vagamente razionalista, grazie ai frequenti viaggi che compie, talvolta con il fratello, in Francia e in Svizzera, e ai rapporti diretti ed epistolari che intrattiene con i parenti ginevrini, i Sellon e i De la Rive, nonch� ai suoi studi di economia politica[12]. La prematura scomparsa della moglie, avvenuta il 31 dicembre del 1833, provoc� una crisi esistenziale profonda nell�animo di Gustavo. Cerc� conforto negli studi pi� propriamente filosofici e in particolare di metafisica e di filosofia morale[13].
La morte della moglie Adele incrin� i rapporti con il fratello Camillo che era legato alla cognata da particolare affetto. Camillo rimprover� al fratello la cattiva riuscita del suo matrimonio a causa dei frequenti dissapori che avevano reso infelice la vita della giovane sposa[14].
Dopo la scomparsa di Adele l�attenzione del parentado era tutta rivolta a favore del primogenito di Gustavo, Augusto. Ci� costitu� inizialmente motivo di gelosia da parte di Camillo. Ma presto i rapporti mutarono radicalmente. Mentre Augusto cresceva si instaur� un legame d�affetto del tutto particolare con lo zio. Quando la madre dei Cavour, Adele de Sellon, mor� nel 1846, Augusto, che, in quanto primogenito della famiglia di Gustavo, aveva ereditato gran parte del lascito testamentario della nonna, �ripar� a ci� che ai suoi occhi sembrava un�ingiustizia, lasciando allo zio una cospicua fortuna. Camillo vi rinunzi� passando il denaro a Gustavo per risarcire un vecchio debito di gioco. Ma volle a tutti costi conservare, in un�urna di vetro posta sotto il suo letto, l�uniforme ancora macchiata di sangue di Augusto, morto nella battaglia di Goito nel maggio del 1848. Fu questa la tragedia pi� grande che capit� a Camillo. E tale sventura lacer� a lungo i rapporti con Gustavo, contrario alla guerra di indipendenza. Camillo, invece, era favorevole, come scrisse il 21 marzo in un articolo apparso sul periodico Il Risorgimento. Camillo sosteneva la necessit� dell�intervento anche per evitare una diffusione di repubblicanesimo dalla Lombardia al Piemonte. Nel frattempo dal fronte Augusto, nelle lettere indirizzate ai familiari, segnalava la totale incompetenza degli ufficiali dell�esercito di Carlo Alberto e la mancanza di motivazioni presso la truppa. Fu allora che lo zio comment� coraggiosamente sulle pagine del Risorgimento le gravi deficienze militari segnalate dal nipote. Alla notizia della morte di Augusto, Camillo, che si trovava alla redazione del giornale, come testimonia uno dei collaboratori del Risorgimento,si accasci� sul pavimento in preda a grande dolore e sgomento. Mentre il padre, Gustavo, rivolgendosi al Rosmini implor� preghiere per il figlio, e rivel� che � �stato di qualche lenimento il sapere che egli � morto assistito da un buon sacerdote dal quale ha avuto tutti i conforti della religione�[15]. E nella stessa confessa al Rosmini: �In tutta confidenza le aprir� un pensiero penoso del mio cuore. Non sono pienamente tranquillo sulla giustizia e sulla legittimit� della presente guerra. A muoverla entrarono forse alcuni sentimenti nobili, ma nello stesso tempo vi concorsero molte ree passioni [�]�.
2) L�incontro di Gustavo di Cavour con Rosmini
L�incontro con l�abate Rosmini segna una tappa fondamentale del percorso intellettuale e umano di Gustavo. Rosmini, con la sua vita e con il suo pensiero, ha sempre costituito un esempio di come si possa essere cristiani vivendo nel proprio tempo, soprattutto recuperando l�amicizia tra la ragione e la fede. Il pensiero di Rosmini, in un�epoca in cui � diffuso un erroneo e cattivo uso della ragione, costituisce uno stimolo a dare un senso completo e soddisfacente alla propria esistenza. Per questo l�incontro tra Rosmini e il marchese Gustavo Benso di Cavour, avvenuto a Torino nell�ottobre del 1836, fu destinato a durare tutta una vita e ad essere molto fecondo, basti pensare all�intensit� dei dialoghi filosofici che si sono svolti presso la villa Bolongaro a Stresa tra Rosmini, Manzoni, il marchese Gustavo e il giovane napoletano Ruggero Bonghi[16]. A partire dall�esigenza di dare un senso alla propria vita avviene l�incontro di Cavour con Rosmini:
�Conobbi Rosmini soltanto nella mia et� gi� matura ed egli contava dieci anni pi� di me. Il periodo di pochi mesi bast� onde riconoscessi in lui un rispettato maestro ed un impareggiabile amico. Venti anni di preziosa intimit� fecero continuamente crescere in me l�ammirazione che mi ispiravano le sue pure ed amabili virt�. Niuno mi fece mai pi� profondamente sentire la verit� di quel detto registrato nel libro della sapienza: chi trova un amico trova un tesoro�[17].
Non c�� miglior traccia per mettere in piena luce la conversione di Gustavo che in queste righe indirizzate al fratello, dove tra l�altro auspicava che lo stesso Camillo, grazie al Rosmini, si convertisse pienamente al cattolicesimo e seguisse la Chiesa di Cristo, cosa che non avvenne[18]:
�Ho passato qualche giorno a Domodossola con l�abate Rosmini. Il modo con cui egli intende il cristianesimo � s� radicale che io mi sono messo tutt�affatto dalla sua. Egli ha rimosso molte difficolt� dalla mia mente, per cui rimasi meravigliato di ritrovarmi buon cristiano in mezzo ai miei studi di Kant e di Fichte�[19].
Il rapporto tra Rosmini e il marchese Gustavo Benso di Cavour ebbe inizio fin dal 1836, quando il re Carlo Alberto affid� la Sacra di san Michele a Rosmini che vi trasfer� da Stresa il Noviziato della sua Congregazione religiosa. Proprio il 26 ottobre di quell�anno conobbe Gustavo di Cavour e la sua famiglia. Rosmini fu sempre ben accolto dai Cavour e spesso loro ospite. Soggiorn� nel palazzo dei Cavour, talvolta insieme ai suoi religiosi, in diverse occasioni: nel maggio del 1842, nell�agosto del �45, del �51, e nel settembre del 1853. Ma � con Gustavo che Rosmini coltiv� i rapporti pi� intensi.
Gustavo trov� nel cattolicesimo e nella filosofia rosminiana il compimento degli interessi e delle dottrine fino ad allora professate. Le prime lettere del marchese indirizzate al Rosmini mostrano come egli fosse tormentato dal problema morale. Infatti scriveva al Rosmini che se l�onest� e la giustizia sono di certo le cose pi� belle e pi� dolci a praticarsi, la perfezione invece spaventa: come poter ad esempio seguire fedelmente il precetto �Ama il prossimo tuo come te stesso�, considerando il nostro quasi spontaneo egoismo, cio� il nostro limite, il nostro peccato? Ma la risposta del Rosmini mette subito in rilievo l�essenzialit� della grazia e dei sacramenti come unica via concessa all�uomo per essere veramente virtuoso. Infatti se la perfezione fosse esclusivamente opera nostra ci sarebbe motivo di disperare: �Ma ella � l�opera di Dio, poich� la perfezione non � altro appunto, che la comunicazione del creatore alla sua creatura�[20]. Rosmini cita S Paolo il quale afferma che la giustificazione non � ex operibus, ma ex fide, ossia non � il frutto del nostro sforzo, bens� della nostra fede in Dio misericordioso. Solo nell�ottica della fede l�Umilt� ci consente di raggiungere la perfezione, essendo essa il riconoscimento della nostra imperfezione e debolezza.
Questi argomenti hanno a tal punto colpito il marchese Gustavo di Cavour da indurlo a dedicarsi con grande ardore allo studio e alla diffusione dell�opera rosminiana. Come ha sostenuto il Berti: �contribu� pi� che qualsiasi altro scrittore contemporaneo a diffondere in Piemonte, in Isvizzera ed anche in Francia, la cognizione delle opere di Antonio Rosmini�[21]. La penna del marchese serviva da introduzione e da divulgazione in Francia e in Svizzera delle dottrine rosminiane, basti pensare all�edizione tradotta in francese, e che reca una introduzione dello stesso Gustavo di Cavour, del Nuovo saggio sull�origine delle idee.
Di ispirazione rosminiana � l�ampio saggio rimasto inedito, Essai sur la destination de l�homme. Si tratta di un documento importante e significativo dell�etica cattolico-borghese dell�Ottocento. L�opera contiene molti elementi che saranno sviluppati e ampliati nei successivi scritti filosofici e morali, primo fra tutti i Fragmens Philiosophiques, su cui ci soffermeremo diffusamente essendo l�opera pi� significativa del marchese. L�Essai assomiglia per taglio e interessi alle manzoniane Osservazioni sulla morale cattolica. Ne risulta una visione del cristianesimo in armonia con il progresso giudizioso e la convinzione di una prossima rinascita cattolica in Europa come conseguenza della diffusione del liberalismo moderato a sfondo religioso, e dell�adeguamento della Chiesa alla modernit� e di naturale confluire verso la dottrina cattolica dell�economia politica di stampo liberale.
Quando conobbe Rosmini, Gustavo di Cavour non era certo digiuno di filosofia. Aveva studiato i libri di Cousin[22] che conosceva e ammirava, ma essendo il suo interesse rivolto prevalentemente alla filosofia morale, nei confronti della quale si era accostato sotto l�influenza dell�educazione materna, e in seguito alla prematura scomparsa della moglie, pass� a leggere Kant, considerato �radicale conservatore�, Stewart e soprattutto lo scettico razionalista Th�odore Jouffroy[23]. Questi gli interlocutori, e in qualche modo i destinatari dei Fragmens philosophiques, l�opera pi� importante di Gustavo.
3) Fragmens Philosophiques: circostanze bio-bibliografiche
Nella sopraccitata lettera al fratello, riguardo all�incontro con Rosmini, troviamo l�abbozzo dell�opera filosofica di Gustavo: �Ho davanti a me materia per lunghi anni. Dar� da principio un volume per saggiare il pubblico col titolo: Essai sur la destination de l�homme. Dopo questo volume, mi dedicher� alla filosofia del cristianesimo, che piglier� pi� volumi, ed infine alla storia dell�umanit��.[24] A partire dal 1837 collabora con la Biblioth�que universelle de Gen�ve e scrive un articolo De l�ouvrage philosophique de M. l�abb� Rosmini in cui viene affrontata la dottrina rosminiana delle idee. Di questo articolo Rosmini ebbe notizia dai suoi amici milanesi: don Luigi Polidori, il conte Giulio Palludi. Per quest�ultimo Gustavo � �uno di quegli uomini coi quali non si getta la fatica a venire a sottili ragionamenti�[25] ed � persona che ha letto Rosmini, anche se gli sono sfuggite sfumature del suo sistema. Tuttavia lo stesso Rosmini riferendosi a quell�articolo ribatte scrivendo: �[�] fece progressi maggiori dopo quel suo lavoro [�] Sta componendo un�opera estesa, che forse far� rumore, se debbo giudicare da alcuni capitoli[�]�[26]. Qui Rosmini si riferisce ai Fragmens Philosophiques, saggi comparsi prima sulla Biblioth�que de Gen�ve e successivamente raccolti, dopo una approfondita e meditata revisione di cui ci d� testimonianza l�epistolario con il Rosmini, in un unico volume, con dedica al Roveretano, pubblicato dall�editore Fontana di Torino. Apprendiamo dall�epistolario col Rosmini che la parte morale � stata quella pi� difficoltosa: �[�] mi ha dato alquanto da studiare, ed ora lo ritocco e vi ritrovo come sempre accade molti difetti che mi scoraggiano non poco[�]�[27]. Non c�� da stupirsi dal momento che il problema della natura del principio morale[28] era ci� che pi� di ogni altra cosa tormentava l�animo inquieto e insieme fragile del Cavour. E la vera ed autentica soluzione al problema del destino dell�uomo, su cui Cavour si incontrava e scontrava con Jouffroy, veniva dal cristianesimo, dalla grazia divina. In altri termini, per Cavour la soluzione al problema del destino dell�uomo non � possibile all�uomo stesso, come al contrario pretendeva la filosofia moderna impregnata di pelagianesimo, n� pu� essere un fatto di ragione, bens� � solo la grazia, cio� un fatto reale, ma soprannaturale, a reggere i destini dell�umanit� e del singolo. Per questo Cavour considerava una disgrazia l�essere protestanti come scriver� nel dialogo Th�ophile del 1846[29]. Il Cavour termina i Fragmens nell�autunno del 1840, quando Rosmini aveva gi� letto la prima met� dell�opera, e dopo averne affidato la revisione al prof. Sciolla, di cui, su suggerimento del Rosmini, aveva fatto conoscenza nella primavera del 1839. Dello Sciolla ci basti riferire qui il giudizio, che � pi� di un semplice elogio, del Rosmini: �Quanto poi ai progressi della filosofia in cotesta Universit� sono tutti dovuti al Prof. Teol. Sciolla, che il primo ebbe il coraggio e mente d�alzar la voce e farsi udire�[30].
4) Contenuti specificidei Fragmens
Nei Fragmens philosophiques i precedenti studi su Kant, Cousin e Jouffroy vengono ampiamente messi a frutto, sotto l�influsso della filosofia rosminiana, allo scopo di dimostrare come la �vera filosofia� moderna tendesse ad aprirsi alla �possibilit� della fede�. Cos� la filosofia rosminiana costituisce in un certo qual modo una nuova forma di preambula fidei, in conseguenza dell�avvenuto superamento del sensismo e del razionalismo settecentesco. Per Gustavo di Cavour la crisi del razionalismo era l�occasione per la riscoperta delle verit� della fede, che pur definite, con terminologia vinetiana, �non evidenti�, riguadagnavano un loro valore razionale come risposta ai grandi interrogativi dell�esistenza, soprattutto nel campo morale.
Gustavo di Cavour nei primi due capitoli ricostruisce la storia della filosofia moderna alla luce dell�insegnamento di Rosmini. Gustavo di Cavour mette in luce fin dalle prime pagine come la filosofia della storia e la storia della filosofia mostrino il potere che le idee filosofiche, lungi dal non aver alcuna utilit� pratica, esercitano sul destino dei popoli. Afferma che �ci� che manca alla societ� odierna sono dottrine immutabili e definitive�[31]. Tuttavia vi sono due sistemi filosofici che hanno cercato di dichiarare la filosofia inutile o pericolosa: il sensismo e il materialismo da una parte; il fatalismo storico dall�altra. Di fronte a tali correnti culturali che aprono le porte all�ateismo e al pessimismo, Gustavo si domanda: �come recuperare con il ragionamento un uomo che non ha pi� fiducia nella ragione stessa?� La filosofia rosminana assolve a questo impegnativo compito. Infatti, proponendo un sistema filosofico solido e fondato su basi incontestabili si pu� offrire la risposta migliore a coloro che dubitano della filosofia stessa. Ma alla costruzione di un solido sistema filosofico d� il suo apporto anche l�eclettismo di Cousin, elevato dal Cavour a vero e proprio metodo filosofico.
Nel terzo capitolo Gustavo di Cavour fornisce una chiara e lucida esposizione della teoria rosminiana della conoscenza, dimostrando di possedere ormai una sicura padronanza del pensiero del Roveretano. In particolare nella trattazione dei verbi della mente umana e nella loro distinzione dall�idea, l�esposizione risulta straordinariamente chiara ed efficace.
Nel capitolo sulla natura del principio morale (problema che costituiva la costante della riflessione filosofica di Gustavo), l�autore dei Fragmens distingue l�idea del bene dall�amore o spirito di esso. Molti uomini, osserva il marchese, argomentano in maniera ineccepibile sui doveri di giustizia, di onest� e via discorrendo. Tuttavia, spesso si mostrano nei fatti ingiusti e disonesti: cherubini di sapere, satani nell�operare. Ora, per essere veramente morali occorre possedere quella facolt� che � lo spirito morale. Gustavo di Cavour si sofferma sull�intrinseca diversit� fra l�idea del bene e lo spirito di esso. Certamente la regola morale � una verit� proposta dall�intelletto, ma non si riduce ad una verit� astratta e solamente intellettuale. Si tratta di una verit� conosciuta come una sussistenza di cose veramente piacevoli, e, come tali capaci di muovere il nostro volere. I principi della matematica, ad esempio, possono essere percepiti e accolti come verit� anche da una mente separata dal cuore e dallo spirito. Viceversa i principi della morale esprimono un contenuto di verit�, che per� acquista significato soltanto per coloro che hanno lo spirito morale, che scaturisce da una primordiale esperienza: non si pu� predicare l�amore per il prossimo se non a coloro che hanno gi� sperimentato che cos�� l�amore. Tutti gli uomini dispongono della facolt� (chiamata esprit moral e che noi rendiamo �spirito morale�) di sentire il bene morale. Ma tale spirito morale � dormiente in noi finch� non venga una volta svegliato dal compimento di un primo atto virtuoso che facciamo spontaneamente, ossia senza ancora volerlo con volont� deliberata. Ma come potremmo volere una cosa che non conosciamo ancora? Gustavo di Cavour afferma che la nostra vita morale ha un suo primissimo inizio o per virt� degli esempi degli altri, o per impulso dell�educazione, o per effetto della grazia di Dio. In altri termini, l�idea del bene morale dapprima risulta essere dormiente in noi, ossia inadeguata, fino a quando non cominciamo a gustare �l�amabilissimo sapore del bene� in qualche atto istintivo o spontaneo. Chi volesse negare la necessit� di sentire e provare il bene almeno istintivamente, non disporrebbe di esempi di fatto, n� di argomenti a priori. Nessun argomento di fatto, poich� non troverebbe nessuno al mondo che non abbia operato il bene o per grazia divina o per educazione anche prima dell�uso della ragione. A nulla varrebbero i ragionamenti a priori, perch� � noto, sostiene il Cavour, che le facolt� umane non si sviluppano senza un�occasione esterna che fornisca a loro la materia prima. Cos�, sottolinea il Cavour, la nozione di virt� sorge solo quando si pratica liberamente un�azione morale. Ci� avviene quando la ragione lavora sulla materia che le viene presentata dallo spirito morale, formandosi un�idea precisa del bene morale. In seguito al primordiale e spontaneo atto morale, riconosce l�idea generica di bont�, che assume a norma suprema dell�operare. Da ci� consegue che l�idea morale � una verit� colta dall�intelletto che ci impone di fare il bene ovunque questo sia; mentre lo spirito morale � un sentire interno attraverso il quale prima percepiamo l�idea generale di bene, e successivamente lo pratichiamo. Ora, mentre le idee morali ci comandano di fare il bene, di seguire l�ordine e via dicendo, lo spirito morale ci fa sentire che questo bene risiede fuori di noi, e precisamente in Dio, e ce lo fa volere con amore disinteressato, ossia come un oggetto di per s� apprezzabile e degno di essere voluto. La virt� allora non � semplicemente un�idea, ma uno stato dell�animo informato da Dio, che ultimamente, in quanto virt� perfetta, consiste nel volere essere degni della santit� di fronte a Dio. E la virt� comporta l�amore disinteressato, il solo che ci fa apprezzare la bont� degli oggetti indipendentemente dall�utile personale. Il Cavour distingue tra virt� imperfetta e perfetta. La prima � la ricerca del bene individuale o di pochi uomini. La seconda, ossia la carit� cristiana, � l�azione rivolta per il bene universalissimo, vale a dire per Dio e per gli uomini per amore di Dio. Ma la virt� perfetta implica la grazia divina. In sintesi, l�agire morale comporta l�idea del bene e il sentimento morale. Ma Dio non si comunica al sentimento se non con la grazia. Dunque senza la grazia sarebbe impossibile l�adempimento della virt� perfetta e la carit�.
Nell�ultimo capitolo, dedicato alla Filosofia del cristianesimo e che affronta i rapporti tra fede e ragione, il Cavour distingue le idee che ci danno la conoscenza mentale delle cose dal senso che ci avverte della loro sussistenza, mentre la fede infonde amore, come a una sussistenza reale, all�ordine delle cose sovrasensibili, e senza di lei non conosceremmo nulla, se non solo speculativamente. Dunque a fondamento della conoscenza umana troviamo i sensi, l�intelligenza ed anche la fede. Per il Cavour la filosofia riconosce la necessit� della fede: � talmente necessaria che senza di lei non conosceremmo se Dio esiste o meno. Infatti, le tre tradizionali prove della dimostrazione dell�esistenza di Dio (la fisica, la metafisica e quella morale) dimostrano la possibilit� dell�idea di Dio, ma non riescono a convincere che esso sussista realmente e che costituisca il nostro principio e la nostra felicit�.
Il Cavour recupera la nozione, tipicamente cristiana, di Dio come evento, rivelazione che irrompe nella storia dell�uomo. Per Gustavo di Cavour l�uomo col pensiero non pu� innalzarsi a Dio, senza che Dio attraverso un�azione positiva nei riguardi dell�umanit� non si sia in parte fatto conoscere. Tale azione ha il nome di grazia. Occorre insistere sul fatto che per Cavour l�origine della fede � dono assolutamente gratuito di Dio. Ora, la concezione che traspare dalle pagine dei Fragmens di Dio come evento, e non come mero fatto di ragione, ci permette di capire il significato che Cavour attribuisce alle prove dell�esistenza di Dio. Non vengono svalutate le prove fondate sul principio di causa o la prova ontologica, ma le prove morali, e soprattutto storiche, sono privilegiate. Lo studio dell�ordine dell�universo e della perfezione del mondo ci porta, infatti, alla dimostrazione dell�esistenza di Dio, ma di un Dio, per cos� dire, lontano dalle faccende degli uomini. Anche in questo caso � il cristianesimo a fornirci la soluzione migliore, rivelandoci l�esistenza di un Dio benevolo, onnipotente e sapiente, che nutre un�attenzione particolare per il singolo individuo, ci� che � alla base di ogni moralit� completa e di doveri assoluti. E la rivelazione divina, gi� profetizzata in qualche modo da Platone, lungi dall�essere un�assurdit� per la ragione umana, ne rappresenta un�esigenza costitutiva. L�uomo per� non � in potere di darsi la fede. Tuttavia pu� attirarsela, ossia disporsi a riceverla.
5) La polemica di Gustavo di Cavour con Vincenzo Gioberti
Gustavo di Cavour mostra di occupare una posizione di rilievo nell�ambito del rosminianesimo in occasione della polemica con Gioberti. Come � noto la polemica tra Gioberti e Rosmini non impegn� l�uno contro l�altro i due pensatori, ma Gioberti da una parte e i discepoli di Rosmini (primo fra tutti Michele Tarditi) dall�altra. Quando Gioberti critic� nella Introduzione allo studio della filosofia la dottrina rosminiana dell�ente possibile, Rosmini incoraggi� i suoi discepoli a rompere il silenzio e a rispondere al Gioberti[32]. Allorch� la polemica sembrava ormai essersi spenta, a riaccenderla fu proprio il marchese Gustavo Benso di Cavour che con il fratello si trovava a Parigi per affari. Ora il contatto con la colonia italiana che vi risiedeva influ� notevolmente sull�animo antigiobertiano del Cavour. Infatti Gioberti l�aveva abbandonata con un sentimento di profonda antipatia[33]. Non solo, ma anche il principe Dal Pozzo della Cisterna ed il Castellengo avevano fornito ai Cavour �un tableau peu favorable de la conduite que Gioberti avait tenue pendant son s�jour � Paris�[34]. Insomma il Gioberti, agli occhi dei fratelli Cavour, non aveva lasciato una buona fama di s� a Parigi. E quindi non c�� da stupirsi se proprio a Parigi il rosminiano Gustavo di Cavour trov� esca all�incendio che covava nel suo animo. L�incipit della polemica antigiobertiana di Cavour, fu un articolo pubblicato dal periodico parigino l�Univers il 17 gennaio 1843 dal titolo Les philosophes italiens Rosmini e Gioberti,firmato �un catholique anglais�. L�autore era un diplomatico inglese a Bruxelles, A. Graven, fedelissimo amico di Gioberti. Nell�articolo Rosmini � considerato �un excellent pr�tre, laborieux serviteur dans la vigne du Seigneur, sans �tre parfait philosophe�. Citando Degli errori filosofici di Antonio Rosmini, Graven sostiene che il pensiero filosofico di Rosmini conduce, tra le altre cose, all�ateismo, all�idealismo, al panteismo, al razionalismo teologico ed � anticattolico nei suoi princ�pi e nel suo metodo. Ma soprattutto Graven rimprovera a Rosmini il fatto di non aver mai �jusqu�� pr�sent r�pondu aux accusations dirig�es contre sa philosophie�. Graven, nel suo articolo, polemizzava con Emile de Belisy che sul medesimo giornale, il 19 dicembre del �42, aveva preso le difese del Rosmini dalle accuse di Eusebio cristiano. Ora l�Univers pubblica il 19 gennaio del �43 un articolo in risposta a quello di Graven da parte di Gustavo di Cavour. L�articolo � ricco di invettive contro il Gioberti e non � privo di una certa ironia. Per prima cosa il marchese afferma che Gioberti dimostra di avere un �emportement� e una collera che sono incompatibili con la filosofia. In secondo luogo fa un felice ritratto di Rosmini. Ricorda l�importanza delle Massime di perfezione cristiana e sottolinea che Rosmini � il fondatore dell�Istituto di Carit�, Istituto che ha formato buoni missionari favorendo cos� numerose conversioni, proprio in Inghilterra, la patria di A. Graven. Ricorda che tale Istituto ha avuto il pieno riconoscimento della Chiesa per opera del Pontefice. In terzo luogo afferma che Rosmini � attaccato dal punto di vista teologico, fatto che lo rende inquieto perch� vengono messe in discussione la sua ortodossia e la sua obbedienza alla Chiesa, mentre � talmente esausto degli attacchi di carattere propriamente filosofico rivolti alla sua dottrina al punto da non curarsene affatto. Ma � la conclusione dell�articolo a sollevare l�ira di Gioberti. Questi, infatti, viene rimproverato di aver rinunciato all�esercizio del suo ministero perch� si era trovato coinvolto in un complotto contro il Regno sardo. E per tale motivo sarebbe stato cacciato in esilio. Gioberti, inoltre, � accusato dal Cavour di essere un prete secolarizzato, fatto che spiegherebbe in parte la sua acredine di cui sono testimoni i suoi scritti scientifici e in particolare la sua ultima opera, rivolta contro il Rosmini. La conclusione di Cavour � velenosissima: �Mais cela aussi doit inspirer aux personnes pieuses et aux lecteurs de l�Univers une grande d�fiance contre ses assertions si tranchantes�. All�articolo risponde lo stesso Gioberti sulle pagine dell�Univers il 21 febbraio respingendo con veemenza l�accusa di aver complottato contro il governo, di non considerarsi un esule, e ritiene follia che lo si consideri un prete secolarizzato. Afferma, senza mezzi termini, che quelle del Cavour sono tutte calunnie.
Frattanto l�articolo del 19 gennaio di Gustavo sull�Univers viene letto a Torino il 22 gennaio, suscitando vasta eco. L�indomani Giovanni Baracco manifesta la propria solidariet� a Gioberti. E Claudio Dalmazzo, in una lettera indirizzata a Gioberti il 30 gennaio, scrive : �Tutti che lessero quel calunnioso articolo [�] se ne mostrano sdegnati; gli stessi Corte e Sciolla [�] ne sono molto turbati�[35]. Ancora il Baracco, in un�altra lettera del primo febbraio, si compiace per la risposta all�articolo di Gustavo da parte del Gioberti e riferisce che Paolo Barone nutriva fortemente il desiderio di rispondere al Cavour. Importanti manifestazioni di affetto giungono al Gioberti da Reyneri, Marzano, da Dionigi Pinelli secondo il quale il Cavour avrebbe addirittura violato il codice penale rischiando un anno di galera, e da Cesare Spalla che compone due poesie riguardo alla �Marchesata�. Da una lettera di Giovanni Baracco del 25 febbraio apprendiamo che l�Univers ha rifiutato un articolo del marchese perch� era un �capolavoro di sciocchezza�, (accusava Gioberti di portare la barba) .
Ma gi� il 23 gennaio Gioberti aveva manifestato la sua irritazione per l�articolo di Cavour in una lettera indirizzata al cavaliere Pietro di Santa Rosa (che aveva buoni rapporti coi Cavour e con Gioberti). In questa lettera Gioberti chiede che il cavaliere intervenga in suo favore: �voglio una pronta, espressa e compiuta ritrattazione del marchese stampata nello stesso giornale che divulg� la calunnia [�]�. Le cose andarono diversamente dall�auspicio di Gioberti. Il Cavour, infatti, scrive un nuovo velenosissimo articolo sull�Univers il 16 febbraio in replica all�articolo del Gioberti di due giorni prima, a cui segue una pronta risposta del Gioberti il 18 febbraio. Data lo stesso giorno una seconda missiva di Gioberti al cavaliere Pietro di Santa Rosa. In essa Gioberti sostiene che ormai �ci vuole un miracolo per convincere il marchese del suo enorme torto�. Inoltre torna a chiedere che il marchese faccia �onorevole ammenda� per le sue accuse. Ora il Santa Rosa, volendo far da paciere, si era rivolto al Gustavo gi� il 25 gennaio, nella speranza di convincerlo a porre termine alle accuse contro il Gioberti. Cavour gli rispose insistendo sulle �accuse di apostasia� rivolte al Gioberti. Il 9 febbraio Santa Rosa scrive nuovamente a Gustavo, il quale non risponde. Al Santa Rosa � Camillo a rispondere nella famosa[36] lettera del 13 febbraio, biasimando il fratello, ma nello stesso tempo giustificandolo, riferendo delle accuse di connivenza di Gioberti coi Gesuiti messa in circolo dal principe della Cisterna. Gioberti sarebbe, per Camillo, avidissimo di denaro e venduto ai Gesuiti. Ora, il Santa Rosa scrive al Gioberti una lettera assolutamente confidenziale (voleva addirittura che Gioberti la bruciasse, una volta letta) il 24 febbraio. In questa rivela al Gioberti il contenuto della lettera di Camillo. Per Santa Rosa Cavour � dominato pi� dalla passione che dall�intelletto. Cerca di far da paciere, mettendo in luce i torti di entrambi. Ma quel che � importante � che riferisce delle voci che circolavano nella stessa Torino riguardo alla vicinanza del Gioberti ai Gesuiti. A un certo punto, infatti, scrive: �Di pi� badate, io dico ancora che i Gesuiti lodano Gioberti perch� combatte Rosmini�. E Santa Rosa porta un�altra prova dei presunti contatti del Gioberti con i Gesuiti: �l�Univers fin qui giornale dinastico s�� unito all�Union Catholique, giornale gesuitico. Prima di questa fusione Gioberti non ottenne di vedervi stampata la sua risposta a Cavour quando i Congregantisti dell�Union Catholique dominarono nel Consiglio del Giornale eccola venuta fuori�.
6) I rapporti d�affari tra il Rosmini e il marchese Gustavo di Cavour
Negli anni 1840-42 tra Rosmini e Gustavo di Cavour intercorsero numerosi rapporti d�affari. Rosmini aveva, infatti, ricevuto un ingente capitale dal Principe d�Aremberg per la realizzazione di un Collegio Medico. Ora, il Conte Camillo e il marchese padre, attraverso Gustavo, operarono quali negoziatori in favore di Rosmini. Da Stresa, l�11 aprile, il Rosmini si rivolge all�amicizia del marchese Gustavo, �per un affare non di lettere ma di denari�.Lo prega di interpellare i banchieri Barbaroux e Comp. in Torino e quindi fargli conoscere se questi sono disposti a ricevere il pagamento di una �somma alquanto forte� dovutagli da una persona e di tenerla a sua disposizione nella loro Banca a Torino. In quella citt� il Rosmini non conosceva altra banca se non quella dei Nigra che non conveniva per� all�uopo essendo proprio questa interessata alle operazioni finanziarie del pagamento della somma dovuta dalla persona debitrice. Il 13 aprile Gustavo di Cavour risponde prontamente assicurando il Rosmini del buon esito nell�incarico presso la Banca Barbaroux e Tron, non senza protestare per� la sua disponibilit� �onde risparmiargli ilsolito agio�, senza alcun incomodo, avendo il padre un cassiere particolare. Con questa lettera del 23 aprile, ha inizio una nutrita corrispondenza d�affari tra i due, che concerne il coinvolgimento del marchese e di suoi familiari, nel giro di interessi materiali dell�Istituto di Carit� portati avanti dal Rosmini e sviluppatisi in numerose e grandi Opere di assistenza sociale e di carit� alle quali si dedica concretamente il Rosmini nella sua missione di sacerdote e filosofo.
Il Principe Ernesto d�Aremberg, avendo visto lo stato penoso in cui allora versava la medicina, aveva deciso di dedicare parte dei suoi beni per fondare un Istituto di medici preparati culturalmente e materialmente ad esercitare la professione sociale: un �istituto sociale di soli medici�, come scrisse nel biglietto lasciato nel settembre del 1839 al Calvario di Domodossola, in casa del Rosmini, allo stesso indirizzato (dato che non l�aveva potuto incontrare) ed al quale intendeva affidare la realizzazione. Il Rosmini non ritenne per� attuabile la cosa e propose al Principe �la preparazione di medici secolari ascritti all�Istituto di Carit� che eserciterebbero la medicina per puro amore e nei limiti segnati dalla loro religiosa ubbidienza nelle case dell�istituto stesso� e tent� di incominciare la realizzazione proponendo subito concretamente il mantenimento agli studi di medicina presso l�Universit� di Torino, di quattro giovani d�ingegno: offr� personalmente a tale scopo Lire 300.000. La cosa per� non ebbe esito. In seguito il Principe d�Aremberg, nel 1843, present� a Gregorio XVI il progetto del Collegio, e venne nominata una Congregazione esaminatrice. L�anno appresso Rosmini invi� gli statuti dell�Opera in 12 capitoli. La Congregazione decise di rimandare l�esame della proposta, e cos� per altri due anni, nel timore che le Universit� statali non avessero preparato uomini capaci. Il Rosmini insistette ancora nel 1848 presso Pio IX, ma gli eventi politici non favorevoli ne impedirono la realizzazione. Anche il Principe d�Aremberg, riproposta la cosa, la vedeva impedita nel 1855 da una nuova Congregazione di Cardinali e moriva senza veder compiuto il suo sogno.
Ad ogni modo, anche grazie all�aiuto dei Cavour, Rosmini si dedicher� alla realizzazione di una straordinaria ed importante Opera di carit�: il Collegio di San Raffaele.
Dall�analisi della corrispondenza tra il marchese Gustavo Benso di Cavour ed il Rosmini, possiamo ricavare il concreto aiuto che il marchese prest� al Rosmini nella sua attivit� delle Opere di carit� e, d�altra parte la giusta oculatezza che questo ha posto nella gestione dei fondi che gli venivano donati dai benefattori ed in quelli che personalmente vi rimetteva. Tra le altre cose merita di essere segnalato il prestito che Rosmini aveva fatto al Conte Camillo e di cui Gustavo riferisce in una lettera a Rosmini da Parigi il 19 gennaio del 1843.
7) Rosmini e Gustavo di Cavour di fronte al comunismo
Antonio Rosmini e il marchese Gustavo Benso di Cavour erano particolarmente attenti e dotati di straordinaria sensibilit� intorno ai fenomeni sociali e politici che stavano scuotendo l�Europa e l�Italia. Cerchiamo di vedere l�influenza esercita sul marchese da parte del Roveretano in relazione alle idee politiche.
Nel 1846 apparve presso la Biblioth�que universelle de Gen�ve il saggio di Gustavo di Cavour Des id�es communistes et des moyens d�en combattre le d�veloppement, erroneamente ristampato nel 1855 negli Ouvrages politiques-�conomiques del fratello Camillo. Il marchese Gustavo Benso di Cavour, come intellettuale appartenente al liberalismo italiano, non poteva rimanere estraneo circa la polemica intorno al comunismo, quando essa dilagava in tutto il Continente. Negli anni immediatamente precedenti il �48, infatti, il comunismo e il socialismo costituivano gi� un problema di attualit� politica. Gustavo di Cavour stabilisce con estrema chiarezza il nesso tra movimenti proletari e ideologie socialiste o comuniste, ossia tra la sfera dei fatti e ci� che avviene nella sfera ideale. Cos� propone un�interpretazione dei collegamenti tra la diffusione delle idee del socialismo utopistico avanzate da Saint-Simon, Owen, e Fourier e i contemporanei movimenti di rivolta e di lotta sociale, come il luddismo e il cartismo. Nel ricercare i motivi della diffusione delle idee comuniste, Gustavo di Cavour li riconduce allo stato dello sviluppo intellettuale della societ� europea: in primo luogo nella tendenza a considerare prevalente, a livello collettivo, il diritto naturale alla sopravvivenza rispetto al diritto alla propriet�; in secondo luogo, nella tendenziale identificazione del fatto con il diritto per opera della filosofia idealistica tedesca, e di Hegel in special modo, tale da portare alla legittimazione della forza materiale e della potenza fisica e al prevalere dell�interesse delle masse rispetto ai diritti individuali. Interessa rilevare come Gustavo di Cavour fosse pervenuto ad una visione unitaria di mezzo secolo di storia e di cultura europea che individuava nella critica dell�economia classica inglese, nel socialismo democratico francese e, soprattutto, nella filosofia classica tedesca le origini del socialismo.
Ora, il saggio di Cavour si caratterizza per l�estrema concretezza storica e in questo senso si distingue dal testo di Rosmini, Saggio sul comunismo e sul socialismo, scritto per incarico del cardinal Soglia all�indomani dell�enciclica di Pio IX Qui pluribus, che costituiva la prima condanna ufficiale del comunismo. Cos�, Gustavo di Cavour a differenza di Rosmini, di fronte al dilagare delle idee comuniste, non risponde con un anatema (pur condannando il comunismo), ma con un tentativo teorico volto a risolvere la lotta fra le classi sociali nel quadro della categorie filosofico-giuridiche tradizionali. Cos� respinge l�idea di annientare il comunismo con una feroce repressione. Il comunismo andava combattuto sul piano ideale, morale e culturale, attraverso la diffusione di sani principi, di ordine metafisico ed economico, tra le classi dirigenti e le masse popolari. I conflitti sociali si possono superare attraverso l�esercizio della beneficenza caritatevole da parte delle classi dirigenti. Gustavo di Cavour propone dei rimedi pratici che si riassumono in definitiva nell�appello alla carit�. Le sue conclusioni sono quelle di un liberale assai moderato: progressista in campo economico, ossia sostenitore dello sviluppo capitalistico, cattolico e conservatore nella sfera giuridico-sociale.
8) Chiesa e Stato in Gustavo di Cavour
Nel frattempo inizia e si sviluppa la collaborazione a periodici piemontesi da parte di Rosmini, che cos� ha modo di prendere parte a problematiche politico-culturali che si discutevano nel regno sabaudo. Rosmini scrive a Gustavo nel dicembre del 1847:
�Sto osservando con molta attenzione tutto quello che si fa in Italia, e parmi vedere sotto a tutti i maneggi degli uomini la mano di Dio, onde me ne rallegro. Ho ricevuto, appunto oggi, il programma d�un nuovo foglio intitolato il Risorgimento [�] La prego pertanto di ossequiarmi il Conte Camillo Direttore del giornale e dirgli che sinceramente mi congratulo della nobile impresa [�] gli dica di pi� che le ultime parole del Programma soprattutto, valgono un tesoro; e che se si mantengono quelle promesse, come non dubito, non ci fu mai giornale al mondo n� pi� morale, n� pi� utile di quello che uscir� il Risorgimento, a cui fin d�ora intendo essere associato�[37].
Ora, nel luglio del 1848 il Risorgimento pubblica una serie di articoli di Rosmini. Cos� li presenta il Direttore, Camillo: �L�illustre filosofo Antonio Rosmini, una delle glorie intellettuali d�Italia, penetrato dal dovere che incombe ad ogni buon cittadino che ha consacrato le sue veglie allo studio delle scienze sociali, di discutere dinanzi al tribunale della pubblica opinione i grandi principi politici e sociali, sui quali poggiar deve la nostra Costituzione, dopo avere esposto in un opuscolo stampato a Milano le basi del suo sistema, ha intrapreso di svolgerne ora le varie parti in una serie di articoli che andiamo lieti di poter comunicare ai nostri lettori�.
Pur nella differenza di opinioni sulla rigenerazione politica dell�Italia, Rosmini collabora coi periodici piemontesi grazie all�interessamento e all�amicizia coi fratelli Cavour. Pochi mesi trascorrono prima che giunga la condanna della Sacra Congregazione all�Indice delle Cinque Piaghe e della Costituzione secondo la giustizia sociale. A tal proposito Gustavo scrive a Rosmini:
�Quanta sia stata in me la meraviglia, anzi lo stupore, mai saprei esprimerlo colle parole. Avevo letto e gustato quei libri, ci avevo trovato altissimi sensi, profondissimi pensieri, n� seppi darmi pace per l�accaduto [�] Che il sommo Filosofo dei nostri giorni si sottometta riverente a un giudizio, forse mal motivato ma derivante da una legittima autorit� che vi si sottometta senza indugio e senza proteste, questo � un atto di quella cristiana umilt� che ha veramente dell�eroico, e che non pu� nemmeno essere concepito da chi non ha studiato la vera sapienza al suo pi� puro e legittimo fonte, ai piedi cio� del Crocifisso�[38].
Ma nel tempo i rapporti tra Rosmini e Gustavo Benso di Cavour si incrinarono, anche a motivo dell�elezione a deputato di quest�ultimo. Come deputato, infatti, Gustavo di Cavour perseguiva una propria linea etico-politica sensibile ad un liberalismo moderato. Ma sull�enunciazione dei principi l�accordo con Rosmini non venne meno, tranne, come vedremo, rispetto alla questione del matrimonio civile.
Nel 1848 Gustavo di Cavour prese parte alla fondazione del periodico l�Armonia della religione colla civilt�. Ispirandosi ai principi di un cauto separatismo, si occupa dei problemi relativi alla libert� di coscienza, alla questione del matrimonio civile e alla separazione della Chiesa dallo Stato. L�Armonia pubblica in forma anonima quattro articoli di Gustavo su quest�ultimo tema. Rosmini accolse con favore gli interventi del Cavour, sottolineando �lo spirito del cattolicesimo di cui sono informati�. Ma il separatismo professato da Gustavo di Cavour, in anni cruciali per la politica ecclesiastica piemontese, non piacque, per motivi opposti, n� agli ambienti clericali, che vedevano con sospetto le tesi avanzate dal Cavour, n� ai vari collaboratori dell�Armonia. Lo stesso Rosmini si adoper� per attenuare la portata delle idee di Gustavo, suggerendo di precisare meglio il senso del separatismo, non rifiutabile �in certe condizioni di tempi e di popoli�, ma a condizione che non si tramutasse in separatismo ostile, e che servisse invece a riconoscere alla Chiesa la sua libert� e i suoi diritti:
�Si sarebbe forse potuto determinar meglio in che consista quella separazione della Chiesa dallo Stato, che si accorda all�avversario poter aver luogo in certe condizioni di tempi e di popoli, e poter anche in queste essere utile. E ci� perch� pur troppo si abusa anche di una tale espressione [�] Non mancano financo certi politici i quali per separazione dello Stato dalla Chiesa intendono, che lo Stato possa fare qualunque legge e sopra qualunque materia con tanta indipendenza dalla Chiesa, che questa non possa mai opporsi alla formazione o alla esecuzione delle leggi gi� formate, quantunque le giudichi nocevolissime alle anime e lesive de� suoi diritti; non possa opporsi, dico, coi mezzi suoi proprii, quali sono indubitatamente l�istruzione privata e la pubblica predicazione, e le lettere e decreti vescovili, e la rimozione dei colpevoli dalla partecipazione dei Sacramenti e d�altri beni spirituali, e finalmente l'amputazione de� membri guasti dal corpo di Cristo. Questa � un�opinione strana e apertamente erronea [�] Il governo cristiano, ci sia la separazione o no, dovr� sempre limitarsi in presenza della Chiesa cattolica, e non estendere mai le mani sopra tutto ci� che sta nella sfera dei diritti di essa, o sopra di ci� che tocca la religione, il cui governo � ad essa sola commesso dal divino fondatore. E in questo solo modo ci pu� essere vera libert� di coscienza per i cattolici. Lo Stato � gi� obbligato pel fine della sua istituzione di tutelare tutti i diritti e i beni de� cittadini [�] La separazione dello Stato dunque dalla Chiesa non disobbliga lo Stato dal tutelare i diritti religiosi dei cattolici e la loro libert� d�adempire i religiosi loro doveri in tutta la loro estensione; e non pu� consistere in altro, se non nell�accordare la stessa protezione ad altre confessioni nello Stato esistenti, e nell�astenersi d�aggiungere all�inosservanza delle leggi ecclesiastiche pene temporali, rimettendo alla Chiesa il farle eseguire co� mezzi che sono di sua spettanza"[39] .
Ora, Gustavo di Cavour ritorna sull�argomento sulle pagine dell�Armonia, non solo accogliendo i suggerimenti del Roveretano, ma riproducendo alla lettera alcuni passi della lettera che abbiamo parzialmente riportato:
�Il legislatore, anche incredulo, deve badare, quando fa leggi che vincolano i cattolici, se quelle leggi non si scontrino con quelle che il cattolico religiosamente � tenuto ad osservare. La separazione non priva lo Stato del dovere di tutelare i diritti religiosi dei cattolici. Questa separazione non pu� consistere in altro se non nell�accordare la stessa protezione a tutte le altre confessioni esistenti nello Stato [�]�[40].
Ad ogni modo il cauto separatismo professato da Gustavo si scontrava con l�impronta anticostituzionale ormai assunta dal giornale torinese. Le dimissioni di Gustavo furono perci� inevitabili e cos� furono motivate in una lettera al Rosmini:
�Da varie circostanze che raccolgo mi confermo sempre pi� nella persuasione che ho fatto bene lasciando l�Armonia. Infatti da qualche tempo si � propagata e radicata in una parte del nostro clero l�opinione che costituzionalismo e religione cattolica non possano conciliarsi insieme. Questa erronea e pericolosa dottrina pu� fare molto male; riconosco che le danno pur troppo un valido fondamento gli errori dei nostri liberali e legalisti, ma nondimeno restando giornalista era stretto mio dovere il combatterla. Ora ci� facendo mi sarei tirato addosso la disapprovazione di molte persone che io venero e rispetto, specialmente di vari Vescovi piemontesi [�] Sono gi� in uggia a molti liberali che mi tengono per retrogrado ed assolutista perch� sincero cattolico [�]�[41].
9) Il contrasto sulla questione del matrimonio civile
Tuttavia, l�adesione a valutazioni sempre pi� marcatamente liberali in campo politico-ecclesiastico da parte di Gustavo di Cavour provoc� un certo distacco dal Rosmini. Infatti, il parlamento piemontese, tra la fine del 1850 e il 1852, affront� la spinosa questione del matrimonio civile, alla quale si interessarono sia Rosmini che il Marchese Gustavo Benso di Cavour. Gustavo di Cavour aveva pubblicato, in forma anonima, degli articoli apparsi sull�Armonia in cui, richiamandosi alle leggi Peel dell�ordinamento matrimoniale inglese, ammetteva dei casi in cui il legislatore poteva riconoscere un matrimonio meramente civile. Rosmini, che in un primo tempo ignorava l�identit� dell�autore di quegli articoli, scrisse al Vescovo d�Ivrea, Mons. Moreno e allo stesso Gustavo di Cavour, sostenendo che non conveniva fare cos� gravi concessioni ai fautori del matrimonio civile. Raccolse le sue idee a riguardo in un articolo, Riflessioni sopra un articolo inserito nell�Armonia, pubblicato dallo stesso periodico, anche in questo caso in forma anonima, il 12 febbraio 1851. In esso Rosmini affermava che non si poteva paragonare la situazione inglese, dove predominava la Chiesa anglicana, con quella piemontese. E ci� per una ragione teologica alla quale si aggiungeva la mancata pubblicazione del Concilio di Trento. La Chiesa anglicana, infatti, non riconosceva il matrimonio come sacramento, e quindi non poteva essere offesa dalle leggi Peel, mentre per i cattolici inglesi queste costituivano pur sempre un passo avanti rispetto alla precedente legislazione. Ma a questa ragione se ne aggiungeva un�altra. Rosmini faceva notare come in Inghilterra non era ancora stato pubblicato il Concilio di Trento, per cui i matrimoni celebrati anche solo alla presenza del registratore civile, qualora non avessero impedimenti canonici, risultavano validi anche per la Chiesa cattolica. Lo stesso non poteva accadere in Piemonte e negli altri paesi cattolici.
Ora, su questa materia vi fu un serrato scambio epistolare tra Rosmini e Gustavo di Cavour. Alla fine il marchese vot� in Parlamento contro il disegno di legge, ma non si dimostr� particolarmente convinto sulle ragioni di principio, come si ricava dalla seguente lettera del Rosmini:
�Ricevo con gran piacere l�annunzio della sua prossima venuta a Stresa, dove mi riserbo ance parlarle sulla legge del Matrimonio civile. Non voglio per� tacerle fin d�ora che mi ha racconsolato l�aver inteso ch�Ella diede il voto negativo quando si tratt� dell�approvazione della legge totale. Ma La consiglierei a fare qualche pi� esplicita dichiarazione della sua disapprovazione ai principi irreligiosi e anticattolici, su cui quella legge s�appoggia; giacch� l�emendamento da Lei proposto, e la dissertazione stampata nel Cimento e da Lei favoritami, darebbero a credere che il suo voto negativo riguardasse qualche altro difetto della legge piuttosto che la sua intrinseca acattolicit��[42].
Rosmini, da parte sua, scrisse un�ampia trattazione, in ben ventinove numeri del giornale, Sulle leggi civili che riguardano il matrimonio dei cristiani.
In sintesi, la questione del matrimonio civile costitu� motivo di dissidio tra Rosmini e il Cavour per ben due anni. Vi fu pure un burrascoso incontro a Stresa che per� non super� le difficolt�. Rosmini invitando di nuovo Gustavo a Stresa, cos� gli scriveva:
�Per altro a me sarebbe d�una indicibile consolazione, se in una cosa tanto grave potessimo trovarci perfettamente d�accordo, come ci troviamo tutti e due d�accordo nella massima generale di essere cattolici, e di rendere a Dio tutto l�ossequio e il servigio, e l�amore che per noi si possa coll�ajuto della santa sua grazia. Essendo noi due in questo indubitatamente unanimi, spero che lo diverremo anche nei particolari dell�applicazione [�] Allora con mio sommo gaudio potr�, senz�alcun pericolo per la mia coscienza, ascoltare la sua confessione e impartirle l�assoluzione. Niente altro mi trattenne da ci� per questi due anni passati, che un ragionevole timore di offendere Dio, mancando al mio ministero e danneggiando chi devo amare e amo anche con amore speciale di amicizia [�] La verit� sola � quella che mi conduce: ben inteso che per trovare la verit� non conviene abbandonarsi unicamente ai propri umani raziocinii, ma appigliarsi alla Rivelazione, alle parole di Ges� Cristo, interpretate e spiegate dalla Santa Chiesa Cattolica�[43].
10) Rosmini e i Cavour di fronte alla legge sull�incameramento dei beni degli ordini religiosi
Un ultimo momento particolarmente significativo nel rapporto tra Rosmini e Gustavo Benso di Cavour � costituito dalla discussione intorno alla legge sull'incameramento dei beni degli ordini religiosi. Nel dicembre del 1854 venne presentata e discussa al Parlamento piemontese una proposta di legge per l�incameramento dei beni degli Ordini religiosi. In tale circostanza Rosmini non fece mancare la sua protesta e la sua indignazione, soprattutto nei confronti del primo ministro, il Conte Camillo Benso di Cavour. Ad ogni modo si rivolse al fratello Gustavo:
�� veramente un progetto cinico che estingue tutti i principj religiosi e costituzionali [�] Faccia sentire coraggiosamente la sua voce alla Camera, giacch� questo sar�, in ogni caso, un merito che si far� appresso Dio, ci� che solo importa, e poi anche riscuoter� per soprappi� l�applauso degli amici di Dio in terra ed in cielo�[44].
Ora, il 9 gennaio del 1855 Gustavo di Cavour pronuncer� un discorso contro tale legge. Rosmini lo ringrazia di cuore in una delle sue ultimissime lettere indirizzate al marchese:
�Ieri l�altro abbiamo avuto la prima parte dell�eccellente discorso da Lei tenuto alla Camera, e oggi la fine del medesimo. Ce l�abbiamo letto con grande piacere: e sento il bisogno di congratularmene di cuore con Lei. Ella s�� acquistato un nuovo merito, non dico solo verso la Nazione, ma, quello che pi� importa, davanti a Dio, e un titolo d�onoranze anche in questo mondo, presso tutti quelli che amano Dio e la giustizia. Sia pure che il progetto di legge venga approvato, l�opera buona che Ella ha fatto rimane egualmente, ed acquista un prezzo maggiore, quanto maggor virt� si richiede ad opporsi al torrente�[45].
La posizione di Gustavo nei confronti della legge rimase coerente. Quel che merita rilevare, come ha evidenziato Alfeo Valle, �nel fitto carteggio tra i due amici di questo periodo non ricorrono mai richiami o saluti del Conte Camillo. Un silenzio di riserbo, o forse di imbarazzo, magari di rimprovero da parte di ambedue. Questi nel suo discorso in Parlamento, sostenne la legge ritenendola necessaria e giustificata con ragioni di fatto. Rosmini, prima in rapporti cordiali e di stima col Conte Camillo, da questo momento rompe ogni relazione�[46]. Come � noto la legge venne approvata. Il marchese cos� si rivolse nell�ultima sua lettera al Rosmini: �Mi affligge molto l�infausta e malaugurata legge contro alle Congregazioni religiose; gi� parmi vedere che l�empiet� nutra contro a quei pii sodalizi una speciale antipatia piena di rabbia, perch� appunto l�inferno mira nei medesimi i maggiori suoi nemici. Ho combattuto con tutto il mio potere questo funesto progetto [�]�[47].
Nel frattempo la malattia costrinse il Rosmini a letto. Tra maggio e giugno Gustavo si reca pi� volte a trovare l�amico ed il Maestro. Il 17 giugno il marchese si reca a Stresa per l�ultimo omaggio al grande amico infermo. Rosmini si spegne il 1� luglio. Il Conte Camillo Benso di Cavour ne fece telegrafare la triste notizia a tutte le ambasciate in Italia e in Europa.
[1] Vincenzo Gioberti, Epistolario, III, pp.360-2. Il Gioberti rispondeva ad una lettera del Baracco del 5 febbraio che lo informava sulla �parte rosminiana� di Torino. I Frammenti filosofici furono per Silvio Pellico, come si ricava da una lettera indirizzata da questi al marchese Gustavo di Cavour del 24 giugno 1841, uno dei libri di metafisica �che meglio avesse capito e pi� lo avessero soddisfatto�. Grande successo riscossero anche presso il variegato mondo intellettuale torinese. Infatti nell�ampia recensione ai Fragmens, apparsa sul Propagatore religioso, n XII del �41, il giobertiano P. Barone presenta l�opera del Cavour in questi termini: �[�] se gi� molte cose si vedono pubblicate da italiani scrittori colla divisa della cattolica italiana filosofia, mi piace fra queste annunciare qui specialmente (ch� si merita specialissima indicazione) il libro del ch.mo signor marchese di Cavour [�] delle opere filosofiche che riscossero i maggiori applausi in Francia da mezzo secolo in poi, dite, havvene alcuna pi� precisa, pi� piena, pi� vera, pi� cristiana, pi� profonda che i Frammenti del sig. Gustavo?� p.33. Cos� come apprendiamo dal Berti che l�opera fu presentata al re e �i giornali ne dicono bene�. Cfr. D. Berti, Il conte di Cavour avanti il 1848, a cura di Franco Bolgiani, Milano 1945, p.30.
[2] La madre calvinista si convert� nel 1811 al cattolicesimo grazie all�assistenza religiosa dell�abate giansenista Degola. Cfr. F. Ruffini, I giansenisti piemontesi e la conversione della madre di Cavour, in Atti d. R. Accad. D. Scienze di Torino, LXIII (1928), pp.295 ss.Nella nobile ed austera famiglia dei Cavour era sempre rimasta viva la devozione a San Francesco di Sales, considerato il �santo� della famiglia. Il padre, Michele, sub� l�influenza degli oblati di Pio Brunone Lanteri e del clima religioso del Piemonte della Restaurazione, e considerava �veramente sublime� lo scritto Du Pape di De Maistre.
[3] Rosario Romeo, Vita di Cavour, Laterza, Bari, 1998, p.5.
[4] Ricordiamo che gli usi del tempo volevano che sia i possedimenti di famiglia sia il titolo di marchese andassero al fratello maggiore, cio� a Gustavo. Cos� Camillo dovette costruirsi una carriera e, come era costume, diventare ufficiale dell�esercito frequentando durante tutto il periodo dell�adolescenza (dai nove ai sedici anni) la Regia Accademia.
[5] Nel 1837 Camillo fu due volte a Parigi e una terza nel �38 presso la zia Victoire. Egli pot� cos� entrare nel bel mondo di Parigi: mangiar bene, frequentare i migliori alberghi, abbigliarsi da un sarto costoso e recarsi alle corse a Chantilly.
Al gioco aveva perso a Torino una grossa somma di denaro. Camillo era realmente disperato per questa sua dipendenza dal gioco. Sta di fatto che chiese e ottenne dal pi� benestante fratello Gustavo un prestito per pagare un debito di gioco contratto a Parigi. Tuttavia continu� a frequentare i tavoli del Jockey club, al punto che nel corso di una serata arriv� a puntare una somma di denaro superiore alle sue entrate di un anno di lavoro. Ma Camillo pi� che di denaro era assetato di potere. E ci� ha fortemente caratterizzato la sua personalit�.
[6] Da segnalare la violenta crisi di Camillo nei rapporti coi familiari intorno al 1825-26, a causa del suo rapporto d�amicizia con il barone Severino Cassio che �innest� in Camillo opinioni liberali, riprovate dalla famiglia. A proposito cfr. Rosario Romeo, Vita di Cavour, cit., pp.12-20.
[7] Diversi fattori culturali ed ideologici spinsero Gustavo di Cavour in senso liberale moderato in campo politico, e in senso razionalista nel campo religioso. Tali orientamenti politico-religiosi maturarono tra la fine degli studi universitari e il 1833, grazie ai frequenti viaggi in Francia e in Svizzera, e ai rapporti con i Sellon e De la Rive. Naturalmente ebbero un certo peso nella maturazione culturale del Cavour i suoi studi di economia politica e di filosofia.
[8] Rosario Romeo, Vita di Cavour, Laterza, Bari, 1998, p.19.
[9] Camillo in una lettera allo zio de Sellon del 16 dicembre 1828 afferma: �gr�ce a mon fr�re je re�ois les gazettes et me trouve ainsi au courant de tout ce qui se passe dans le monde politique�. Cfr. F. Ruffini, La giovinezza , I, p.86.
[10] Lettera del 15 settembre 1839.
[11] Dal matrimonio nacquero tre figli: Augusto, Ainardo e Giuseppina. Quest�ultima and� in sposa al marchese Alfieri di Sostegno e il matrimonio fu celebrato dal Rosmini.
[12] In particolare divenne convinto sostenitore delle teorie di Smith, Ricardo e Malhus.
[13] Nel corso del discorso che tenne l�undici di novembre del 1861 alla facolt� di Lettere dell�Universit� di Torino cos� si espresse: � Giovine ancora, fui colpito da una di quelle amarissime disgrazie che sconvolgono il corso della nostra vita e ben sovente imprimono al pensiero individuale una nuova direzione. Una benefica esperienza mi insegn� che a temprare un acerbo dolore altamente giovano le filosofiche considerazioni, le quali distolgono l�animo dal soverchio nutrirsi del pensiero della straziante realt� e l�introducono nelle serene regioni dell�immutabil vero. Quando poi la mente � assuefatta a spaziare nell�ordine ideale, aspirando ad internarsi sempre pi� nella conoscenza di quei tipi ideali di cui Platone cotanto illustr� il concetto, l�uomo che si � messo per questa via prova certi diletti intimi e squisiti, dei quali non ha neanche sentore colui che generalmente attende soltanto agli oggetti dei sensi esterni, ed a questi soli attribuisce valore�. Cfr., Il conte di Cavour avanti il 1848, cit, pp.35-6.
[14] Cfr, Rosario Romeo, Vita di Cavour, cit., p.7.
[15] Lettera di Gustavo di Cavour a Rosmini del 3 giugno 1848. Riguardo al rapporto epistolare di Cavour con Rosmini Cfr. Lettere inedite del marchese Gustavo Benso di Cavour al Rosmini, in �Rivista Rosminiana�, a cura di G. Gaddo (poi A. Valle), XXX (1936) LV (1961), e in particolare la lettera CXXIII, p.66.
[16] Di questi incontri abbiamo la testimonianza del Bonghi. Questi ne ha fatto oggetto di un dialogo, Le stresiane, diviso in quattro parti, di cui l�ultima � dedicata al Cavour. Significativamente il Bonghi, nella sua ricostruzione degli incontri, attribuisce al Cavour prevalentemente interventi a carattere religioso-teologico.
[17] Cfr. il discorso di Gustavo di Cavour alla facolt� di Lettere e Filosofia di Torino dell�11 novembre 1861, in Il conte di Cavour avanti il 1848, cit., p.36.
[18] Tra Camillo e Rosmini vi furono, per il tramite di Gustavo, rapporti d�affari a partire dal �40. Cfr. Lettere inedite del marchese Gustavo Benso di Cavour a Rosmiini, in �Rivista rosminiana�, cit. Da segnalare la lettera dell�8 marzo del �43 di Rosmini alla madre dei Cavour, dove si ha notizia del grado dei rapporti con Camillo: �Non ho gli stessi legami col Conte Camillo quali ho con Gustavo: per altro non mancher� di raccomandarlo indegnamente al Signore, da cui vengono tutte le grazie. Io credo che lo stesso Marchese Gustavo gli potr� essere utile, trattando con lui di frequente, e un po� alla volta, comunicandogli i propri sentimenti, la sua propria piet�.� Cfr. Epistolario Completo, vol. VIII, p.368.
[19] Lettera a Camillo del 10 settembre 1837.
[20] Lettera di Rosmini al marchese Gustavo Benso di Cavour, Domodossola 6 settembre 1837. Cfr. Epistolario Completo, vol.VII, p.417 e ss.
[21] Cfr., D. Berti, Il conte di Cavour, cit., p.39.
[22] Vittorio Cousin era fortemente presente nella cultura piemontese dell�epoca, in quanto espressione di liberalismo moderato. Gustavo di Cavour ne accoglieva, fino a farli propri, i principi eclettici, ma respingeva del suo pensiero il �misticismo� legato alla riduzione dell�idea di sostanza all�idea di assoluto. Per il Cousin i sistemi filosofici sono in parte veri e in parte falsi: veri perch� affermano qualche elemento reale della natura umana, falsi quando negano qualche elemento che ha pur la sua realt�; da ci� la tendenza a favorire i sistemi pi� veri, mettendo insieme le loro affermazioni. Cousin considera l�eclettismo non come sincretismo, bens� in quanto scelta illuminante che elimina da tutte le dottrine ci� che in esse vi � di comune e di vero e mette da parte ci� che vi � di opposto e di falso.
[23] Th�odore Simone Jouffroy attravers� una crisi religiosa che lui stesso narra: �Non potendo sopportare l�incertezza sull�enigma del destino umano, non avendo pi� la luce della fede per risolverlo, non mi rimanevano che i lumi della ragione per provvedervi. Risolsi dunque di consacrare tutto il tempo che sarebbe necessario a questa ricerca; � per questa strada che mi trovai condotto alla filosofia�. Cfr. M�langes Philosophiques, Paris, Joubert, 1842, pp.112-16. Era una crisi che passa ogni giovane spirito un po� colto e riflessivo quando comincia a porsi delle domande avendo la tentazione intellettuale di bastare a se stesso. Condizione esistenziale molto simile a quella di Cavour. Dopo la crisi religiosa continu� a credere nell�immortalit� dell�anima, ma rifiut� la Rivelazione e la divinit� di Cristo. La sua filosofia � puro deismo nutrito di morale evangelica. Tuttavia la sua forma mentis essenzialmente cristiana lo conduce spontaneamente ad aderire nella vita pratica alle verit� religiose che la sua ragione non ammette. La sua vita sar� una perenne tortura per la sua incredulit� e per il rimpianto nostalgico della fede perduta. Per Jouffroy la filosofia ha sostituito il sapere della religione la quale � una semplice tappa nell�evoluzione delle idee e ne costituisce la continuazione. Di qui l�iniziale fiducia di Jouffroy per le scienze. Ma ben presto pervenne ad una nuova e pi� lacerante delusione. Col passare del tempo Jouffroy si rende conto che nessuna credenza pu� sostituire la fede, e al dubbio della religione subentra lo scetticismo filosofico. Per Jouffroy la filosofia � ricerca del destino dell�uomo, ma a questa esigenza non riesce a dar risposta.
[24] Lettera a Camillo del 10 settembre 1837.
[25] Cfr. Giulio Palludi, lettera a Rosmini del 18 novembre 1837, parzialmente pubblicata dalla �Rivista rosminiana� in Lettere inedite del marchese Gustavo Benso di Cavour al Rosmini, a cura di G. A. Gaddo, XXX (1936), p.52.
[26] Lettera di Rosmini al conte Giulio Polidori del 24 novembre 1837, in �Rivista rosminiana� XXX, p.53.
[27] Lettera del marchese Gustavo di Cavour al Rosmini del 12 novembre 1840 da Torino. Cfr. Lettere inedite, cit., p.212.
[28] Gustavo pubblic� nel 1852 sul Cimento due articoli riguardo la questione del fondamento scientifico della morale, non trattando per� l�ardua questione della distinzione tra il bene morale semplicemente onesto e quello rigorosamente obbligatorio.
[29] Si tratta di un dialogo scritto su richiesta di madame Blanche Naville de Ch�teauvieux che aveva chiesto al marchese di spiegarle quale era il punto cardine del dissenso tra le dottrine protestanti e il cattolicesimo. Vengono affrontati: a) la natura dei sacramenti, dove Cavour chiarisce il significato del battesimo per i cattolici, b) il rapporto tra l�autorit� delle Sacre scritture e quello della Chiesa, che appare argomento �valido� per i protestanti per attaccare la Chiesa cattolica, c) la previsione fatta dal Cavour per bocca di Teofilo di una prossima dissoluzione del protestantesimo nel razionalismo. Il dialogo affronta argomenti teologici anche se con metodo filosofico. Da segnalare che Cavour fa dire ad uno dei protagonisti del Dialogo (Jules che rappresenta i teologi protestanti) che � pi� facile accordarsi sulle questioni filosofiche, mentre il terreno religioso � molto pi� �scivoloso�. Importante � ricordare che nella lettera del 5 dicembre del �44 indirizzata al Rosmini, il Cavour rivela che l�Arcivescovo di Parigi voleva nominarlo professore di teologia alla Sorbona. Fatto che � estremamente rilevante se si tiene conto della vivace polemica di Cavour col Gioberti. Infatti Gustavo era stato segnalato all�arcivescovo come propagatore di una filosofia pericolosa e razionalista. Tuttavia il Cavour scrive nella lettera sopra citata: �Monsignore mi scrisse con qualche timore per sapere se ero veramente colpevole. L�ho rassicurato senza fatica provandogli l�ortodossia del Signor Abate Antonio Rosmini, e mi valsi di questa circostanza onde esibirgli una copia del Nuovo Saggio che venne da lui accettata con piacere.� Cfr. Lettere inedite, �Rivista Rosminiana�, p.75.
[30] Cfr. Epistolario completo, vol. VI, p.627.
[31] Traduzione nostra.
[32] Inizialmente il Nuovo saggio era piaciuto a Vincenzo Gioberti, al punto che incoraggi� Sciolla, Tarditi e Corte a leggere Rosmini. Non solo. Gioberti cercava di smuovere le obiezioni di Terenzio Mamiani sollevate contro il Rosmini. Ma quando il Gioberti pubblic� nel 1833 la Teorica del sovrannaturale Rosmini ne diede un giudizio dove � ben delineata la sostanza della polemica dottrinale col Gioberti. Rosmini rileva infatti che son due cose affatto diverse il sostenere che la ragione umana � in grado di dimostrare l�esistenza del sovrannaturale e l�affermare, come fa il Gioberti, che si possa con un primo intuito �conoscere� il sovrannaturale. Infatti l�uomo non � in grado di percepire o conoscere positivamente il sovrannaturale, senza un previo libero e gratuito intervento di Dio stesso. Successivamente in una lettera a Sciolla Rosmini scrisse: �Ho letto qualche pagina dell�opera del teologo Gioberti. Qual confusione di idee! Dica la prego all�egregio Tarditi, che se egli vuol farne qualche articolo, io mi prester� a scioglere qualunque difficolt� potesse incontrare.� Nacquer� cos� Le lettere di un rosminiano a V. Gioberti di Tarditi. In sintesi il Tarditi rimproverava al Gioberti di confondere forma ideale e forma reale dell�essere e in generale contestava la validit� del suo Primo filosofico e il metodo da lui seguito. Prima che fosse completata l�opera giunse la pesante risposta del Gioberti, Degli errori filosofici di Antonio Rosmini. Gioberti nutriva la speranza di coinvolgere direttamente il Rosmini, costringendolo a prendere diretta posizione sulla controversia. Fatto che non avvenne. Gioberti rimproverava a Rosmini di aver fatto dell�essere intuito dall�intelligenza un mero e confuso ente ideale, mentre nella intelligenza sono presenti sia l�ideale che il reale infiniti ed assoluti. Cos� il sistema rosminiano conduceva all�ateismo, al panteismo, al sensismo [�] Rosmini non rispose, ma affid� ai suo discepoli la risposta alle accuse. In estrema sintesi rimproverava a Gioberti di non aver colto il legame e insieme la distinzione tra l�ideale e il reale. E ci� per non aver compreso la legge del sintetismo. A riguardo Cfr. la lettera indirizzata dal Roveretano a Michele Tarditi da Stresa il 18 aprile 1841.La polemica divamp� e coinvolse Pier Dionigi Pinelli, Giuseppe Massari, Pietro Riberi, destinatari delle lettere di Gioberti in cui questi manifestava il proprio pensiero criticando la filosofia di Rosmini. A rispondergli furono Terenzio Mamiani, il gi� menzionato Pinelli. L�anno seguente, fino al mese di ottobre, il Gioberti scrisse al Massari, a Pietro De Rossi di Santa Rosa (amico questi dei fratelli Cavour e nei confronti del quale Gioberti si rivolse perch� cessassero e venissero ritrattati gli attacchi di Gustavo di Cavour dalle pagine dell�Univers), ed al Riberi.
[33] A riguardo Gioberti scriveva il 16 luglio 1840 al Riberi: �Se tu avessi vissuto un anno a Parigi, se tu avessi conosciuta la sapienza e la cortesia degli infraciosati che col� dimorano, se tu avessi ricevute le lettere anonime e non anonime sciocchissime, impertinentissime, che mi furono indirizzate, perch� non sono un apostata e mi mantengo italiano; se tu fossi stato testimonio dei discorsi e dei pettegolezzi che ebbero luogo a mio riguardo, conosceresti che io non potevo parlare altrimenti, senza scapito dell�onor mio, e forse della causa che difendo�.
[34] Cfr. lettera di Camillo al cavaliere Pietro de Rossi di Santa Rosa del 3 febbraio 1843.
[35] Cfr. Nuovi documenti sulla polemica di Vincenzo Gioberti con G. Benso di Cavour, in �Il Risorgimento italiano�, vol.XVIII, aprile-giugno 1925, fasc. II, a cura di G. Balsamo Crivelli, p.291.
[36] Si tratta della lettera in cui Camillo definisce il fratello un �ultra catholique�. Infatti il rosminianesimo di Gustavo appariva ormai, agli occhi di Camillo, proprio in occasione della polemica tra Rosmini e Gioberti, vero e proprio fanatismo religioso. Per Camillo, influenzato dalla lettura del De La Religion di B. Constant, la religione cattolica esprimeva un contenuto etico e nulla pi�. Camillo rifiutava ogni forma di dogmatismo, perch� a differenza del fratello, rifiutava il contenuto teologico della Rivelazione cristiana.
[37] Lettera di Rosmini al marchese Gustavo Benso di Cavour, Stresa, 9 dicembre 1847. Cfr. Epistolario Completo, vol. X, p. 194
[38] Lettera del marchese Gustavo Benso di Cavour al Rosmini, 8 settembre 1849, da Ginevra. Cfr. Lettere inedite, cit., p. 205.
[39] Lettera di Rosmini al marchese Gustavo Benso di Cavour, Stresa, 18 novembre 1850. Cfr. Epistolario Completo, vol. XI, pp. 142-44.
[40] Sulla separazione della Chiesa dallo Stato. Appendice in Armonia, n. 145, 9 dicembre 1850.
[41] Lettera del marchese Gustavo di Cavour al Rosmini del 13 maggio 1851 da Torino. Cfr. Lettere inedite, cit., p. 291.
[42] Lettera di Rosmini al marchese Gustavo Benso di Cavour, Stresa 9 luglio 1852. Cfr. Epistolario Completo, vol. XI, pp. 642-43.
[43] Lettera di Rosmini al marchese Gustavo Benso di Cavour, Stresa 20 ottobre 1854. Cfr. Epistolario Completo., vol. XII pp. 503-04.
[44] Lettera di Rosmini al marchese Gustavo Benso di Cavour, Stresa 2 dicembre 1854, Cfr. Epistolario Completo, vol. XII, pp. 529-530.
[45] Lettera di Rosmini al marchese Gustavo Benso di Cavour, Stresa 13 gennaio 1855. Cfr. Epistolario Completo, vol. XII, pp. 561-62.
[46] A. Valle, Rosmini e i fratelli Cavour, in Rosmini e la cultura del Risorgimento, a cura di U. Muratore, Edizioni rosminiane, Stresa, 1997, p. 144.
[47] Lettera del marchese Gustavo di Cavour al Rosmini del 22 aprile 1855, da Torino. Cfr. Lettere inedite, cit., p. 27.
Liberalismo e tradizione cattolica. Osservazioni critiche su Juan de Mariana (1535-1624)
di P. Zanotto
Intenti e limiti della presente ricognizione
Lo storico del pensiero politico Dalmacio Negro Pav�n ha recentemente sostenuto che la tradizione liberale del �governo limitato� � la quale, a sua volta, si riallaccerebbe direttamente alla �concezione classica greco-latina del governo sottoposto alle leggi� � avrebbe avuto inizio nel corso del Medioevo. Tale idea si vedrebbe strettamente collegata alla convinzione secondo cui il popolo detiene un diritto originario ad esprimere il proprio consenso o dissenso all�azione dei governanti, attraverso i suoi rappresentanti naturali. L�et� media � prosegue Negro Pav�n, sulla scorta di alcuni studi compiuti da Jos� Mar�a Ortega y Gasset (1883-1955)[1] � avrebbe fermamente creduto che la libert�, lungi dal configurarsi come una concessione del governo, fosse previa alla legge, al pubblico, a quello che in et� moderna si � definito �Stato�. Sempre a suo dire, inoltre, tale concezione riposerebbe, fondamentalmente, nell�idea cristiana secondo la quale ogni uomo � libero a causa della sua condizione di essere creato, secondo l�insegnamento biblico contenuto nel Pentateuco, ad �immagine e somiglianza� di Dio[2]; situazione per cui l�essere umano possiederebbe, a differenza della maggior parte delle altre creature viventi, una �libert� naturale�[3].
Secondo alcune ricerche compiute da Jos� Antonio Maravall Casesnoves, il Seicento politico castigliano avrebbe ereditato elementi gi� presenti nel basso Medioevo, adattandoli con i motivi provenienti dai nuovi influssi culturali del periodo[4]. Gli scolastici spagnoli dell�epoca rinascimentale, infatti, rielaborarono a pi� riprese le concezioni tardo-medioevali del �pattismo�, in base al quale erano da ritenersi �leggi fondamentali del regno� (leges imperii) quelle norme di diritto positivo che configuravano il �contratto� fra il monarca ed il popolo, attraverso le quali quest�ultimo riconosceva al primo la sua qualit�.
Da parte sua, lo studioso spagnolo Jes�s Huerta de Soto Ballester si � detto convinto del fatto che si sarebbe avuta, da parte di alcuni pensatori cattolici medioevali e rinascimentali, un�anticipazione proprio delle tematiche relative alla teoria liberale del governo limitato. In proposito, egli ha sottolineato anche come il trionfo della Riforma, con la conseguente ricezione �imperfetta� della �tradizione giusnaturalista� cristiana[5], che si ebbe nel mondo anglosassone attraverso gli �scolastici protestanti�, avrebbe contribuito a sottrarre prestigio ed influenza al ruolo svolto dalla Chiesa cattolica quale limite e contrappeso al potere secolare dei governi, il quale si sarebbe visto, in tal modo, notevolmente potenziato[6]. Di conseguenza, il liberalismo risulterebbe essere l�ideologia politica coerente con il cristianesimo nelle condizioni del mondo moderno e contemporaneo[7]. Non sarebbe, quindi, una mera casualit� che, in alcuni significativi esponenti della tradizione liberale anglosassone, san Tommaso d�Aquino (1225-1274) venga individuato come the first Whig[8].
Allo stesso modo, non rientrerebbe nella fattispecie delle semplici coincidenze neppure il fatto che l�uso politico del termine �liberale� (liberal) abbia avuto origine proprio in una nazione fra le pi� cattoliche che si conoscano: quella spagnola[9]. In particolare, a giudizio di Negro Pav�n, gli scrittori politici d�impronta liberale vissuti in Spagna nel XIX secolo dovettero molto alla figura oggetto del presente studio: il gesuita Juan de Mariana de la Reina (1535-1624)[10]. D�altronde, molti di quegli stessi esponenti storici del liberalismo politico spagnolo � come Antonio Alcal�-Galiano y Villavicencio (1789-1865) � riconoscevano esplicitamente in Mariana un vero e proprio precursore delle loro idee politiche, al punto che, il 27 maggio 1888, alcuni di essi gli vollero dedicare un monumento. Come stanno a dimostrare frasi quali: �� sicuro solo quel potere che impone limiti alle proprie forze�[11], che tanto impressionarono alcuni moderni lettori del gesuita, proprio Mariana avrebbe infatti rappresentato uno degli esponenti pi� intransigenti di tali t�poi dottrinari. La sua conseguente connotazione quale �ultra-liberale� � recentemente sviluppatasi in ambiente libertario euro-americano � appare, in tal modo, logicamente sostenibile.
A contribuire in maniera determinante nel cucire addosso al religioso castigliano i panni del �rivoluzionario� fu, inoltre, la sua strenua difesa del �tirannicidio� e le traversie personali che ne derivarono[12]. Egli sostenne tale teoria nella propria opera del 1599 intitolata De Rege et Regis institutione[13], la quale andava a porsi, in tal modo, come la voce pi� autorevole in quel tempo a sostegno del �diritto di resistenza� in campo cattolico[14]. In linea con quanto gi� verificatosi in ambiente protestante, infatti, anche nelle nazioni non riformate fior� una tale corrente di pensiero, detta dei �monarcomachi�, la quale avrebbe trovato in Mariana il suo rappresentante pi� illustre[15].
Tuttavia, quella di �liberale� non � l�unica etichetta che si � cercato di attribuire retrospettivamente al gesuita spagnolo; altri interpreti hanno creduto di scorgere in lui, di volta in volta, un �socialista�, un �collettivista�, un �costituzionalista�, un �individualista�, un �razionalista�, un propugnatore della �teocrazia�[16]. Quanto di realistico riposi in tali convinzioni �, pertanto, uno degli interrogativi di fondo ai quali il presente lavoro tenter� di fornire una convincente risposta.
Mises e Hayek sui rapporti fra cristianesimo e dottrina liberale: una premessa necessaria
Prima di addentrarsi nel merito del fine ultimo di questa indagine, sembra opportuno evidenziare che l�assunto da cui essa prende le mosse non si configura come un dogma incontestato nell��mbito della stessa tradizione liberale e libertaria contemporanea, bens� risponde alle caratteristiche di un�interpretazione che, da minoritaria, ultimamente sta acquisendo un sempre crescente consenso al suo interno.
Probabilmente, l��effetto detonante� � stato prodotto dall�assimilazione della teoria economica liberale con la filosofia del giusnaturalismo aristotelico-tomista, operata da parte di Murray Newton Rothbard (1926-1995) in antitesi a quella che era stata la tendenza prevalente all�interno della Scuola austriaca fino a quel momento. Tuttavia, precedenti significativi di tale accostamento si erano gi� avuti per tramite di Hayek. Egli, infatti, sebbene dichiaratamente agnostico, durante la relazione di apertura alla conferenza fondativa della Societ� Mont P�l�rin � tenutasi il 1� aprile del 1947 nei pressi dell�omonima localit� svizzera � dopo aver deplorato �l�anticlericalismo militante ed essenzialmente illiberale� che aveva animato tanta parte del liberalismo continentale del XIX secolo, si disse anche convinto del fatto che, se la frattura tra il �vero liberalismo�, da una parte, e le convinzioni religiose, dall�altra, non fosse stata in qualche modo sanata non si sarebbe potuta avere alcuna speranza di rinascita per le forze liberali[17]. D�altra parte, quello espresso da Hayek sembrerebbe piuttosto essere un semplice auspicio per l�avvenire che non l�esito di una ricerca analitica sulla presenza o meno, nelle due distinte tradizioni, degli addentellati necessari ad una loro effettiva compatibilt� o di esempi relativi a conclamati precedenti storico-dottrinari[18].
Occorre, inoltre, tenere in considerazione la posizione che al riguardo aveva precedentemente assunto Ludwig Edler von Mises (1881-1973). Egli infatti � in stridente contrasto con quelle che sarebbero state, poi, le affermazioni hayekiane � individuava chiaramente un �inevitabile� conflitto tra le due sfere in questione e ne imputava senza indugio la reit� esclusivamente alla religione[19]. Attribuendo alle varie Chiese tutto quel genere di accuse che in innumerevoli occasioni, dal �Secolo dei Lumi� in poi, sono state reiteratamente rivolte loro, nel 1927 Mises, nel teorizzare la propria idea di Liberalismus, giungeva alla conclusione per cui �anche se non vengono pi� accesi roghi ad majorem Dei gloriam, � rimasta ancora tanta intolleranza�[20]. D�altra parte, fedele al principio secondo il quale non si doveva essere tolleranti con gli intolleranti, l�economista austriaco aveva anche avuto modo di osservare come, �[s]e siamo convinti che il fine ultimo dello sviluppo sociale � la cooperazione pacifica tra tutti gli uomini, non si pu� ammettere che la pace sia turbata da preti e zeloti�[21]. Altrove, poi, pur riconoscendo che la religione �non pu� esimersi dallo stabilire princ�pi in materia di etica sociale�[22], e ribadendo poco pi� avanti tale concetto, in base al quale �[s]enza un�etica sociale, la religione � cosa morta�[23], tuttavia, Mises non ardiva a trarre le conseguenze logiche delle proprie affermazioni, rasentando il rischio di sfidare lo stesso principio aristotelico della non contraddizione all�asserire che, se il liberalismo �non ha mai travalicato i confini della propria sfera�, non invadendo il terreno della Weltanschauung, si � per� dovuto scontrare con la Chiesa (cattolica), poich� essa avrebbe preteso �non solo di regolare il rapporto dell�uomo con l�aldil�, ma anche di imporre alle cose terrene l�assetto che essa riteneva giusto�[24]. Del resto, riguardo alla questione dei princip� etico-morali, va rilevato come perfino sotto l�aspetto metodologico Mises si sia sempre detto contrario all�utilizzo della dottrina del diritto naturale[25], in favore di un�impostazione strettamente utilitaristica, sebbene di un utilitarismo atipico, solitamente denominato come �teoria della consequenzialit� delle azioni�.
Alla luce di quanto detto sembrerebbe, pertanto, di poter escludere un�influenza diretta della lezione cattolica sull�austro-liberalismo[26] o, comunque, un richiamo consapevole dei suoi massimi esponenti all�opera dei teologi cristiani del periodo medioevale e rinascimentale, d�altronde mai evocati apertamente dai rappresentanti storici della Scuola austriaca come propr� precursori o punti di riferimento[27]; sebbene giovi, a tale proposito, rammentare l�isolato � ma significativo � caso di Carl Menger (1840-1921)[28].
Tuttavia, gli influssi ideali spesso travalicano le volont� particolari per trascendere gli stessi eventi della storia. Inoltre, si � detto come, da un certo momento in avanti, tale influsso sia stato invece rivendicato esplicitamente da taluni liberali �classici�, Libertarians ed economisti �austriaci�. Si �, cos�, virtualmente instaurato un contraddittorio fra chi accoglie questa tesi e chi tende, per contro, a ridimensionarla. Quello che segue vuol essere un piccolo contributo a tale controversia.
Salmanticenses e Conimbricenses
Sulla scia di quanto gi� verificatosi in precedenza sul territorio italico, nel corso del Cinquecento si sarebbe avviato, in tutta l�area latino-mediterranea, un recupero del pensiero scolastico; esso trov� un terreno particolarmente fertile nella penisola iberica. Gli esponenti di questa Seconda Scolastica erano ecclesiastici e docenti universitari cattolici largamente pervasi ed influenzati da quell�humus culturale dal quale era germogliata la corrente di pensiero umanistica. Il fine ultimo che essi si prefissero coincise, appunto, con la produzione di una sorta di sintesi del corpo dottrinale che era proprio della tradizione tomista, da affiancarsi alle nuove prospettive che, nel frattempo, aveva dischiuso il movimento umanista[29]. Conseguentemente, in questa Nuova Scolastica (prevalentemente spagnola) si prest� una grande attenzione ai problemi d�attualit�, applicando i princip� generali della teologia, della morale cristiana e del diritto naturale alle pi� importanti questioni del momento[30].
� d�uopo, nondimeno, operare una netta distinzione fra due successive correnti di pensiero, connesse ad altrettanti istituti religiosi: l�Ordine dei Frati Predicatori (Ordo Praedicatorum), fondato alla fine del 1215 da Domingo de Guzm�n (1170-1221), e la Compagnia di Ges� (Societas Jesu), costituita nel 1534 dal basco I�igo L�pez de Recalde, poi noto come Ignacio de Loyola (1491-1556). La prima di tali correnti, forse proprio perch� vicina ai padri domenicani, si caratterizz� come pi� marcatamente fedele alla lezione dell�illustre correligionario e caposcuola san Tommaso[31]. Il nucleo di teologi che la componeva sarebbe, grosso modo, riconducibile ai cattedratici di quell�Universitas Studii Salamantini che Alfonso IX (1171-1230), il quale era divenuto re del Le�n nel 1188, fond� l�anno 1218 nel rinomato centro della Vecchia Castiglia. Con l�espressione �Scuola di Salamanca� (1526-1617), infatti, si suole identificare, in senso stretto, proprio tale gruppo di studiosi[32]. Il periodo nel quale los Salmanticenses produssero le opere pi� significative coincise, essenzialmente, con la prima met� del secolo XVI. La grande tematica che suscit� un�attenta e profonda riflessione da parte di tali pensatori coincise con le complesse questioni scaturite dalla scoperta del continente americano (el hecho americano), connesse alla conseguente opera di evangelizzazione che essa comport�[33]. In quel particolare frangente, le figure di riferimento furono incarnate da Francisco de Vitoria (ca. 1485-1546) e da Domingo de Soto (1494-1560).
La dottrina tomista, infatti, era rimasta minoritaria all�interno della stessa Chiesa cattolica finch�, nel secolo XVI, la propag� padre Vitoria, in coincidenza con l�apice della monarchia castigliano-aragonese[34]. Secondo quanto sostenuto da Jos� Mar�a Artola nell�introduzione ad una recente edizione bilingue dell�opera di Tommaso De aeternitate mundi contra murmurantes (ca. 1270), ci� si sarebbe dovuto al fatto che �la sua prospettiva filosofica e teologica non era facile da intendere, e di fatto sappiamo che non venne compresa n� durante la sua vita n� tantomeno dopo da parte di un buon numero di pensatori dell�epoca�[35]. Nonostante tale complessit� e pur essendosi formato sulle dottrine nominaliste � il cui studio approfondito era stato introdotto a Salamanca per opera del frate agostiniano Alonso de C�rdoba (� 1541) � Vitoria apprese la lezione tomista all�Universit� di Parigi, importandola poi in Spagna. Per comprendere la portata della corrente di pensiero cui egli dette origine, occorre tenere presente che a quell�epoca l�Europa era dominata dalle dispute fra i trattatisti tradizionali del diritto privato (mos italicus) e gli esponenti del puro studio del diritto romano, che intendevano restaurare nella propria totalit� ed integrit�, in quanto lo ritenevano alterato dai compilatori di Giustiniano e dai giuristi medioevali[36].
Il secondo movimento, come ricordato, s�identific� con l�ordine dei gesuiti. Essi impersonarono, in un certo qual senso, l��avanguardia intellettuale� della Controriforma cattolica. Come rappresentanti di detta corrente si possono ricordare Luis de Molina (1535-1600), Francisco Su�rez (1548-1617) e Gabriel V�zquez de Belmonte (1551-1604). Questi ultimi furono chiamati los Conimbricenses, giacch� la maggior parte di essi insegn� in Portogallo, presso l�Universit� di Coimbra. Ora, sebbene vi sia stata indubbiamente un�evoluzione cronologica fra la preponderanza dell�influenza domenicana e di quella gesuitica[37], � pur vero che la relazione fra la corrente legata a Salamanca e quella riconducibile a Coimbra non fu di successione, n� di evoluzione, bens� sembra piuttosto corretto dire che los Conimbricenses abbiano sviluppato una filosofia propria, la quale, pur adagiandosi sempre nell�alveo della corrente neoscolastica, su molte questioni fondamentali si discostava in maniera decisa rispetto all�impostazione assunta dai tomisti della Scuola di Salamanca[38].
Un ulteriore nucleo di intellettuali spagnoli vicini alla Chiesa romana fu poi rappresentato da alcuni giuristi e filosofi del diritto appartenenti a vari ordini religiosi, che si sarebbero a loro volta resi responsabili di una fioritura del pensiero giuridico ed economico di tipo giusnaturalistico tradizionale e proto-liberale[39]. Il pensiero �proto-liberale� di alcuni fra questi autori � stato analizzato nel citato saggio di Francisco Carpintero Ben�tez; in particolare, � da segnalarsi in proposito l�esposizione delle teorie relative al concetto di �propriet�� negli scolastici spagnoli, in cui l�autore si sofferma ad indagare anche pensatori spesso trascurati o (a torto) considerati �minori�, come Leonardo Lessius (1554-1623) e Gaspar Hurtado (1575-1646)[40].
� forse superfluo precisare che i summenzionati pensatori insegnarono in varie universit� della penisola iberica � pubblicando le proprie opere a cavallo tra la fine del XVI e l�inizio del XVII secolo � e che, conseguentemente, l�articolazione fra Salmanticenses e Conimbricenses non va interpretata in maniera rigida. Se, difatti, qualcuno ha potuto addirittura sostenere che Su�rez sarebbe stato colui attraverso il quale la dottrina scoto-occamista venne trasmessa all�et� moderna[41], va detto che gli stessi salmantini non ebbero uno spirito cos� nettamente medioevale come, altrimenti, si potrebbe supporre; il loro stesso Tomismo, infatti, era in parte spurio, somigliando piuttosto ad una sorta di �rivisitazione� della filosofia elaborata dall�Aquinate che non, semplicemente, ad una sua fedele riproposizione. All�interno delle due correnti, pertanto, erano presenti posizioni differenti e sfumature variegate, di modo tale che si � potuto individuare nel frate agostiniano Pedro de Arag�n (ca. 1546-1592) il pensatore probabilmente pi� prossimo a quella ipotetica linea di demarcazione che idealmente le separa[42].
Le �Tre Vie� della Nuova Scolastica
Avendo cercato, sin qui, di esporre succintamente quali fossero gli elementi di autonomia e di specificit� che le contraddistinsero, conviene, adesso, porre in evidenza quali siano i principali punti di contatto che sussistono fra le pur distinte correnti neoscolastiche che presero corpo nella penisola iberica durante il periodo in questione. La formazione umanistica di detti autori, la loro interiorizzazione della cultura rinascimentale, defin� l�impostazione con la quale essi si accostarono alle problematiche teologiche e, per conseguenza, anche a quelle politiche. Il riferimento � a ci� che si potrebbe denominare come una sorta di �ottimismo antropologico�, coincidente con una sostanziale fiducia nelle potenzialit� intrinseche alla natura umana.
Dal �settarismo� che � stando alla ricostruzione di Belda Plans � affliggeva le scuole tardo-medioevali, il quale obbligava ad una ferrea ortodossia rispetto alla lectio del maestro, sorsero Tres V�as: Tomismo, Scotismo ed Occamismo. La corrente domenicana, tutta presa nella propria opera di ripristino della tradizione tomista, rappresentava l�espressione pi� conservatrice di quel movimento bifronte che era denominato Via Antiqua o Realista, di cui l�altro volto era quello scotista. Da quest�ultima dottrina, tuttavia, essa sarebbe stata indotta a distanziarsi, cos� come dal Nominalismo occamista, che in quell�epoca costituiva la linea di pensiero prevalente all�interno della stessa Scolastica europea: la cosiddetta Via Nova o Moderna[43]. Essa, dunque, sottoline� il momento �intellettivo� come quello essenzialmente pi� importante nella legge. Di contro, i gesuiti tesero a mettere in risalto, con maggior aderenza alle posizioni nominaliste, il momento �volitivo�: la legge consisteva per essi in un comandamento, un mandato, una decisione di volont�. Ci�, senza dubbio, forn� loro prospettive e strumenti pi� duttili, rispetto a quelli di cui disponevano i salmantini, al fine di accostarsi alle questioni politiche del periodo[44].
In ogni caso tutti i suddetti autori furono, sebbene per ragioni e con motivazioni assai differenti l�uno dall�altro, decisamente monarchici. Ad esempio, per Vitoria � che, in proposito, si limitava ad accogliere la lezione tomista � la miglior forma di governo era da individuarsi in una �monarchia moderata�, in quanto pi� fedele e idonea realizzazione del �regime misto�. Anche secondo Mariana la monarchia avrebbe dovuto essere moderata, in quanto si presentava come l�organo esecutivo di una societ� strutturata gerarchicamente. Essa aveva come missione quella di far realizzare i princip� e i diritti di ordine trascendente: doveva essere cosciente dei suoi compromessi con la comunit�, avendo assunto i propri poteri attraverso il patto che si perpetuava e ratificava con ogni monarca attraverso i rappresentanti (Cortes), mediante un giuramento mutuo di lealt� e rispetto delle leggi. Nel decimo capitolo del suo Discorso sui mali della Compagnia, Mariana dichiarava apertamente di sospettare che le radici da dove procedevano tanti errori nel governo fossero attribuibili al fatto che non sarebbe stata �ben temperata questa monarchia�. Pertanto, egli consigliava di coinvolgere nel governo anche la classe aristocratica, al fine di riequilibrare il potere del re. Ma, come si accennava poc�anzi, sembrerebbe addirittura che Mariana, anzich� verso una monarchia pura, individuasse il vero �porto della felicit�� in una sorta di governo misto, risultante dal connubio fra monarchia ed aristocrazia, nel tentativo di un reciproco bilanciamento dei poteri istituzionali[45]. Per tale motivo, agli scolastici si pose, innanzi tutto, il problema di come giustificare la fuoriuscita da una societ� naturale fondamentalmente democratica nella propria sostanza, al fine di legittimare un regime monarchico nel proprio funzionamento.
In contrapposizione all�affermazione proposta dai conciliaristi, in base alla quale il re sarebbe stato singulis major, universis minor, i tardoscolastici spagnoli sostennero con convinzione la visione per cui la fondazione di una societ� politica implicava anche la creazione di un potere (imperium, potestas) che si poneva al di sopra di tutti gli altri: quello del corpo[46]. Il potere, che a loro giudizio costituiva una realt� naturale, non era una semplice somma delle singole volont�, bens� una realt� sociale la quale formava parte di quell�unit� organica indirizzata ai propri fini che era la societ�. Ci� avrebbe rappresentato il genere di autorit� che, secondo i filosofi e i giuristi cattolici della Spagna rinascimentale, assumeva il monarca con il consenso degli associati.
Intercorreva, del resto, un�ulteriore differenza cruciale tra la posizione fatta propria dai domenicani e quella che, per contro, avrebbero assunto gli esponenti della Compagnia di Ges�. I primi, infatti, consideravano il potere come inerente alla societ�; per essi non era, cio�, neppure ipotizzabile una societ� senza potere. Al contrario, i chierici gesuiti attribuivano una maggior importanza all�elemento volitivo nella sua costituzione; di conseguenza, da ci� discendeva la possibile teorizzazione di una societ� naturale primitiva di tipo sostanzialmente �anarchico�[47]. Per quanto, a rigore, padre Mariana non appartenesse n� alla Scuola di Salamanca n� a quella di Coimbra, tuttavia, la sua opera prese corpo e si svilupp� in tale contesto[48].
La �Nuova Teologia� di Alcal�
Come accennato, durante la prima met� del XVI secolo, in Spagna si produsse quello che � stato definito come il �trionfo del Tomismo�[49]. Una manifestazione rilevante di tale situazione fu l�introduzione della �teologia aperta�, rappresentata dal metodo d�insegnamento integrato delle Tres V�as (Tomismo, Scotismo e Nominalismo) che si adott� � come simbolo di un�apertura totale alla verit� � nell�Universit� di Alcal�, dove avrebbe finito per imporsi l�opera di san Tommaso, a partire dal 1542[50].
Fondato il 26 luglio 1508, durante la festa di sant�Anna, l�ateneo di Alcal� si configur� come uno dei pi� attivi ed innovatori del periodo. Con grande aderenza alla congiuntura storica del momento, esso venne aperto a tutti, religiosi osservanti ed umanisti laici, cosicch� vi confluirono varie influenze di scienza teologica, riforma spirituale e cultura umanistica (soprattutto erasmiana). L�impulso fondamentale per l�organizzazione di questa Universit� e, in particolar modo, della sua Facolt� di Teologia, venne dato dal cardinale francescano Francisco Gonzalo Jim�nez de Cisneros (1436-1517), il quale era intenzionato a creare una Nueva Teolog�a, nella quale confluissero Scolastica ed Umanesimo, teologia speculativa e teologia biblica. Nel suo intento Alcal� avrebbe dovuto essere un centro teologico di prim�ordine improntato alle moderne problematiche trattate dagli eruditi umanisti, piuttosto che alle dottrine �decadenti� della bassa et� media; auspicio peraltro avveratosi, tanto che vi si afferm� il metodo positivo nello studio della teologia, superando definitivamente il metodo dialettico che era stato proprio della Scolastica medioevale[51]. Come si sa, le incalzanti manifestazioni critiche degli umanisti possono essere sintetizzate in alcune petizioni specifiche: a) sostituire al barbarismo medioevale la chiarezza e l�eleganza formale degli autori antichi; b) preferire, all�utilizzo della glossa, l�investigazione critica delle fonti; c) rimpiazzare il predominio dell�autorit� con il diritto all�opinione personale; d) introdurre, in luogo del procedimento logico-dialettico, una metodologia critica improntata al rigore storico-filologico[52].
� opinione diffusa, fra gli studiosi, che Alcal� abbia rappresentato il Rinascimento, mentre Salamanca rimaneva saldamente ancorata alla Tradizione; che Alcal� abbia assorbito il nascente Umanesimo, mentre Salamanca si limitava a riproporre una Scolastica rinnovata; che Alcal� abbia incarnato l�innovazione e Salamanca lo spirito conservatore[53]. Nonostante tali articolazioni abbiano un fondo di attendibilit�, si pu� affermare che la linea di demarcazione fra i due centri di cultura era tutt�altro che nitida, tanto che in entrambi i luoghi era possibile rintracciare elementi di modernit� al fianco di retaggi tradizionali. Giova, inoltre, precisare come l�insidia costante � per quanto scarsamente efficace � dell�eresia protestante sul territorio spagnolo e le dispute teologiche interne, le quali portarono alla ristrutturazione che la Chiesa si sarebbe data dopo il Concilio di Trento (1563), abbiano influito sull�assetto che le attivissime universit� iberiche avevano assunto. Cos�, rispetto all�impostazione dell�ateneo salmantino, alla fine del Cinquecento si avvicend� una nuova corrente di studiosi, la quale devi�, in parte, dai precetti e dallo spirito originario, precedentemente impresso da Vitoria[54]. Tanto che, a rigore, si dovrebbe parlare di una Prima Scuola di Salamanca nettamente distinta, rispetto ad alcune importanti questioni, da una Seconda Scuola[55]. Rimane pur sempre vero, comunque, che Alcal� si configur� come un�Universit� maggiormente dinamica e giovanile, mentre Salamanca rimase senza dubbio pi� fedele alla propria impostazione riflessiva e trascendente[56]. Inoltre, nell�Universit� di Alcal� s�intraprese uno studio scientifico della Sacra Scrittura, il quale sarebbe sfociato nella pubblicazione della prima Bibbia Poliglotta che si realizz� al mondo, per opera di un gruppo di specialisti composto da filologi classici (ellenisti e latinisti) ed ebraisti (giudei convertiti)[57].
La sovranit� delle leggi
In tale ambiente culturale ed intellettuale studi� e si form� Mariana. Nel 1547, infatti, egli s�iscrisse alla Facolt� di Filosofia e Teologia dell�Universit� di Alcal�. Fu in quello stesso ateneo che venne ammesso � il 1� gennaio 1554, all�et� di appena 18 anni � nell�ordine della Compagnia di Ges�[58].
Negli anni seguenti, il giovane Juan svolse il proprio noviziato a Simancas, sotto la direzione spirituale di Francisco de Borja (1510-1572), per fare quindi, alcuni anni dopo, ritorno ad Alcal� al fine di proseguire i corsi all�Universit� nella quale poi divenne, poco pi� che ventenne, lettore di sacra teologia, essendo in tal modo il primo gesuita ad occupare una cattedra in quell�ateneo.
Per ci� che concerne l�impostazione di Mariana in materia di questioni politiche �, forse, superfluo dilungarsi ad illustrare la sua celeberrima difesa del tirannicidio, proprio perch� tale. In molti casi, addirittura, il contributo del gesuita alla teoria politica � stato lamentevolmente circoscritto a quelle poche (soprattutto se confrontate con la totalit� della sua opera) righe in cui egli si dedicava ad enucleare tale concetto. Ma l�extrema ratio del �diritto di resistenza� ravvisava la propria causa e giustificazione in alcuni precetti ben precisi, che merita ricordare.
Secondo il religioso spagnolo, infatti, se intendeva esigere la virt� dai pi�, il re avrebbe dovuto dare, per primo, il buon esempio. Perch� la superbia non si impossessasse di lui, portandolo a tenere in dispregio i propri sudditi, occorreva che egli apprendesse a vivere probamente con gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, senza arrogarsi alcun privilegio per la propria autorit�, bens� riconoscendo �alle leggi quella stessa obbedienza che esige dai suoi sudditi�[59]. Tanto pi� che, osservava Mariana,
�molte leggi {plures leges} non sono state date dai Principi, ma stabilite dalla volont� di tutta la repubblica {universae reipublicae voluntate constitutae}, la cui autorit� {maior auctoritas} e il cui potere di comandare {maius imperium} come di proibire sono superiori a quelli del Principe {quam Principis} [�]. Non solo il Principe deve obbedire a tali leggi, ma non gli � consentito mutarle senza il consenso e il parere dell�assemblea: tra queste rientrano quelle della successione reale, dei tributi e della forma di religione�[60].
La virt� per eccellenza dei governanti veniva identificata con la prudenza; essa era vista come una sorta di dono divino che non si poteva sviluppare unicamente per mezzo dell�insegnamento, cosicch�, se fosse scarseggiata nel principe, gli sforzi dei precettori, per quanto decisi e numerosi, sarebbero ugualmente risultati vani[61]. Tuttavia, anche l�esperienza personale, che si accumulava soltanto con il passare degli anni, costituiva uno degli elementi fondamentali di cui si componeva la prudenza necessaria ad un buon re[62].
Insomma, la figura del monarca era speculare a quella del tiranno che, pertanto, se ne collocava agli antipodi. Quest�ultimo era descritto come un vero e proprio mostro, affetto da ogni vizio: avarizia, lussuria, crudelt�. Il tiranno avrebbe attentato perfino alla libert� di espressione, che era una delle caratteristiche pi� genuine delle persone[63].
Il monarca che aveva in mente Mariana, per contro, non era un sovrano assoluto (Princeps non est solutus legibus)[64], bens� un re sottoposto alle leggi. Egli, infatti, doveva prestare obbedienza ad esse, dando il buon esempio ai cittadini, poich� gli uomini, secondo il talaverano[65], avrebbero creduto pi� nel concreto esempio umano che nella vuota legislazione. Se, infatti, il rispettare le leggi poteva essere visto come un tratto proprio delle anime deboli, tuttavia, il disprezzarle si configurava quale caratteristica comune degli uomini depravati e ribelli[66]. Il monarca in persona, dunque, avrebbe dovuto ritenersi vincolato da quelle stesse leggi per le quali esigeva rispetto ed obbedienza dai propri sudditi[67]. Non doveva esistere alcun potere superiore a quello delle leggi, anche se � precisava �
�non siamo cos� insensati da degradare i Re, collocati sulla sommit� dello Stato, o da confonderli con la moltitudine. Non � nostra intenzione assoggettare il Principe a tutte le leggi senza distinzione alcuna, ma soltanto a quelle che siano istituite senza ignominia della maest� e non intralcino la funzione regale�[68].
Quelle leggi che, secondo Mariana, non oltraggiavano la dignit� del principe n� gli impedivano in qualche modo di espletare la propria funzione, ostacolandolo nelle sue azioni di governo, potevano essere chiaramente individuate. Ve ne erano alcune, ad esempio, che riguardavano i doveri generali dei cittadini, come quelle promulgate riguardo al �dolo, la forza, l�adulterio, la moderazione dei costumi�, nelle quali il principe in nulla risultava diverso dal popolo[69]. Cosicch�, ribadiva il gesuita,
�credo che il Principe debba osservare quelle leggi sanzionate dallo Stato, il cui potere abbiamo detto essere superiore a quello del Re {cuius maiorem esse potestatem quam Principis diximus} e che, se necessario, possa essere anche castigato. Sarebbe, infatti, concesso esautorarlo dal potere e, qualora lo esigano le circostanze, punirlo con la morte {morte plectere rebus exigentibus superius est datum}�[70].
Fedele alla propria caratterizzazione del tiranno come colui che sovvertiva arbitrariamente le norme di diritto, anzich� limitarsi ad interpretare ed applicare la legge, rispettando le consuetudini e le istituzioni nazionali che erano il frutto della volont� dell�intera comunit� (universitas), Mariana finiva per riaffermare, cos�, quell�esigenza �costituzionalistica� in base alla quale si intendeva vincolare il monarca non tanto alle leggi da lui stesso emanate quanto, piuttosto, al diritto consuetudinario e tradizionale in vigore[71]. Del resto, anche gli scolastici a lui successivi non avrebbero mai disconosciuto il fatto che, per dirla con Su�rez, �ci� che riguarda tutti, da tutti deve essere approvato�[72].
Secondo la stessa concezione del gesuita, nella quale peraltro risaltavano distintamente echi di definizioni classiche, la legge era �ragione imperturbabile� (Est enim lex ratio omni perturbatione vacua), in quanto attinta alla mente divina, che avrebbe avuto origine proprio dal sopraggiunto sospetto del popolo in merito all�equit� e all�imparzialit� del principe[73]. D�altronde, a quell�epoca l�arte del governo era ancora interpretata come sinonimo dell��amministrare la giustizia� e, perch� ci� avvenisse, non si doveva dare alcun potere superiore a quello delle leggi[74]. Rispetto al tiranno, che s�imponeva attraverso la paura ed il castigo, il buon principe si reggeva, cos�, per mezzo del premio e della speranza.
Embrioni di una moderna filosofia politica libertaria, o reminiscenze di una consuetudine tradizionale?
Nel De Rege si trovava, inoltre, un passo di particolare importanza, in cui si accennava ad una questione fondamentale che sarebbe stata, poi, ripresa ed approfondita in seguito: il disarmo della societ� civile. �, questo, un tema assai attuale e particolarmente caro alla pubblicistica d�impronta libertaria; tale problematica si vede legata alla moderna concezione di sovranit�, la cui espressione pi� compiuta conduce verso l�assolutismo di hobbesiana memoria[75]. Da questo punto di vista Mariana, dapprima, notava come un re che governa bene non ravvisi alcuna necessit�
�di portare via ai cittadini {civibus} armi e cavalli {arma equosque}, lasciandoli marcire nell�ozio e nella pigrizia, come fanno i tiranni {quod faciunt tyranni}, che usano fiaccare la tempra del popolo costringendolo ad attivit� sedentarie, la tempra dei magnati offrendo loro in abbondanza piaceri, lenocini, vino; avr� cura al contrario che i cittadini si esercitino alla lotta {lucta}, al combattimento {pugna}, al salto, alla corsa a cavallo o a piedi, inermi ed armati, considerando il loro valore {virtute} un presidio ben pi� valido che non le male arti e la frode. Sembrerebbe forse giusto togliere le armi ai figli in pericolo per darle in mano ai servi? {An aequum sit filijs in periculo arma detrahere, dare servis?}�[76].
L�argomento tornava all�attenzione in maniera ancor pi� decisa nel corso del quinto capitolo del terzo libro, che aveva come oggetto specifico proprio �l�arte militare� (De re militari). La salvezza di una nazione era preservata attraverso il conferimento di responsabilit� alla popolazione: destava sospetti un governo che temeva i propri cittadini e non intendeva concedere loro fiducia. La comunit� era legata da un vincolo di appartenenza che costituiva l�unico argine efficace contro la violenza e l�aggressione sistematica nei confronti degli individui che la componevano; il pericolo serio veniva dall�esterno e, contro quella minaccia, il popolo doveva essere messo in condizioni di reagire per difendere la propria patria. Mariana era esplicito in ci�, senza perifrasi alcuna esprimeva la propria convinzione secondo cui non ci sarebbe stato miglior defensor pacis del comune cittadino[77]. Contro la �smilitarizzazione della societ� civile�, Mariana insisteva in maniera decisa e con tono fermo: a suo avviso occorreva, infatti,
�dare le armi ai sudditi {arma provincialibus dentur} piuttosto che agli stranieri {externis}, ottenendo maggiori vantaggi con minori spese. Le forze proprie sono le pi� sicure. Con questo mezzo, Alessandro il Macedone prima, i Romani poi, imposero il loro giogo a numerose popolazioni. Tenere infatti il regno disarmato per non fidarsi dei sudditi e comprare con oro un esercito straniero {aliunde exercitum}, � proprio di un tiranno non di un re legittimo {id est, tyrannum agere non legitimum Regem}. Ma per non procedere su questo cammino, credo che i nostri ragionamenti debbano rifarsi alle massime degli antichi: si deve fare in modo che ai nobili ed al popolo sia restituito il vigore degli animi, concedendo loro l�uso delle armi {curandumque ut proceribus & populo vigor animorum revocetur, armorum usu concesso}�[78].
Sull�amor di patria e sulla destrezza degli stessi cittadini, dunque, anzich� sui soldati mercenari o su aiuti in qualunque modo assoldati avrebbe dovuto appoggiarsi il principe per la difesa della propria dignit� e la conservazione del �bene comune�. � pacifico, d�altra parte, che egli non pensasse affatto alla soppressione di un esercito regolare, cui affidare il compito precipuo di difendere i confini nazionali. Secondo il gesuita, tuttavia, esso avrebbe dovuto essere composto di uomini validi e fidati ed inoltre si sarebbe dovuti ricorrere anche ad antiche tradizioni, cadute ormai in disuso, come la ricostituzione dell�ordine militare della �Banda�, al fine di smuovere la virt� dei cittadini[79].
Mariana, primo economista �austriaco�: un�interpretazione
Ma la fortuna e l�attenzione di cui il pensiero e la figura di Mariana hanno goduto negli ultimi anni � che, in ambiente liberale, hanno decretato anche il risveglio di una conseguente passione per il giusnaturalismo tomista, in antitesi al pensiero utilitarista � sono strettamente connesse, in particolar modo, con la rilettura in chiave libertaria della sua politica economica[80].
Negli anni cinquanta e sessanta del Novecento, infatti, Marjorie Grice-Hutchinson comp� alcune ricerche sulla Scuola di Salamanca[81]. Pi� o meno nel medesimo periodo di tempo, anche Raymond de Roover (1904-1972) condusse alcune indagini sullo stesso filone[82], nelle quali segnal� la dipendenza del pensiero economico del frate francescano san Bernardino da Siena (1380-1444) e di quello del suo allievo sant�Antonino da Firenze (1389-1459) dall�opera del monaco francese fra� Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298)[83]. Ricerche che, probabilmente, non passarono inosservate agli occhi dello stesso Schumpeter, se questi attribu�, come detto, una considerevole importanza al pensiero scolastico nella sua monumentale History of Economic Analysis, del 1954.
Prendendo le mosse da tali studi, alcuni economisti seguaci della moderna Scuola austriaca hanno recentemente creduto di scorgere nel gesuita spagnolo un campione di �liberalismo economico� ante litteram, nonch� un precursore di talune idee che avrebbero, poi, contraddistinto la corrente soggettivista del filone legato alla cosiddetta �rivoluzione marginalista� del pensiero economico, andando a caratterizzare, in special modo, la propria corrente[84]. Tale convinzione troverebbe il proprio nucleo teorico in una tradizione storiografica mirante a valorizzare sia la continuit� fra la dottrina tomistica della legge naturale e la tradizione lockeiana dei natural rights, sia l�affinit� tra il concetto di �valore economico� enucleato dalla Seconda Scolastica spagnola e quello degli esponenti della Scuola austriaca.
Dunque, � stato posto in risalto da alcuni studiosi come la teoria su cui si fonda la moderna economia di mercato sarebbe sorta nella penisola iberica e, segnatamente, in Spagna[85]. Secondo le investigazioni sulla teoria monetaria condotte da Huerta de Soto, ad esempio, l�opposizione fra quella che in seguito sarebbe stata definita �scuola bancaria� (banking school) e quella poi denominata �monetaria� (currency school) troverebbe la propria origine non gi� nell�Inghilterra del XIX secolo, bens� quasi trecento anni prima, proprio per mano dei teologi tardo-scolastici spagnoli[86].
Gli scolastici salmantini, inoltre, avrebbero osservato con grande attenzione anche gli effetti di oscillazione prodotti sul livello generale dei prezzi dall�immissione nei mercati europei dell�oro che giungeva dalle Americhe, arrivando a formulare una vera e propria �teoria quantitativa del denaro�, prima dello stesso Jean Bodin (1530-1596)[87]. Importanti furono anche i contributi degli Scolastici spagnoli alla teoria bancaria[88]. In base alla posizione che essi assumevano riguardo a tale tematica, l�utilizzo a proprio beneficio, mediante la concessione di prestiti a terzi, del denaro depositato a vista presso i banchieri era da ritenersi illegittima e supponeva un grave peccato. Tale dottrina coincideva pienamente con quella gi� stabilita dagli autori classici del diritto romano; quest�ultima, a sua volta, sorgeva naturalmente dall�essenza giuridica del contratto di deposito irregolare di denaro, in base al quale si criticava l�esercizio bancario con �riserva frazionaria�. Gli scolastici spagnoli, insomma, anche se implicitamente, ritenevano che la banca dovesse applicare un �coefficiente di cassa del cento per cento�; proposta che sarebbe divenuta uno dei punti di forza dell�analisi austriaca relativa alla teoria del credito e dei cicli economici[89]. Per quanto si tratti solamente di una suggestione storico-dinastica e non di una concreta dimostrazione teoretica, al fine di comprendere l�influenza che gli scolastici spagnoli avrebbero potuto effettivamente giuocare sulla posteriore evoluzione compiuta dalla Scuola economica austriaca �, inoltre, opportuno tenere presente come, nel XVI secolo, l�imperatore Carlo V (1500-1558) � il quale deteneva anche la corona spagnola � abbia inviato suo fratello Ferdinando I a ricoprire il ruolo di re dell�Austria. In effetti, etimologicamente �Austria� non significherebbe altro che �parte orientale� dell�Impero[90].
In particolare, padre Mariana scrisse un Discurso sobre las enfermedades de la Compa��a, opera che usc� per la prima volta a Bordeaux nel 1625, anche se pare fosse stata scritta nel 1605 nell�originale spagnolo, rimasto a lungo inedito e pubblicato postumo soltanto nella seconda met� del secolo successivo. In tale operetta il gesuita avrebbe anticipato argomentazioni propriamente �austriache� quando sosteneva l�impossibilit�, per mancanza di informazione, da parte di un governo di organizzare la societ� civile in base a mandati coattivi. Egli, riferendosi al governo, sosteneva che �� un grosso sbaglio che il cieco pretenda di guidare colui che vede�, aggiungendo che i governanti �non conoscono le persone, n� i fatti, con le circostanze ad essi legate, da cui dipende il risultato. � consequenziale che si cada in numerosi e gravi errori, che pertanto la gente si disgusti e che disprezzi un governo cos� cieco�. Mariana concludeva dicendo che quando �le leggi sono in eccesso, dal momento che non tutte si possono osservare, n� tanto meno conoscere, si perde il rispetto di tutte�[91].
In base a tale interpretazione, i teologi spagnoli del XVI e XVII secolo avrebbero anticipato almeno una decina di questioni fondamentali, poi accolte nella lezione economica contemporanea: la teoria soggettiva del valore (Diego de Covarrubias y Leyva); la scoperta della corretta relazione sussistente fra prezzi e costi (Luis Saravia de la Calle); la natura dinamica del mercato con la conseguente impossibilit� di raggiungere il modello di equilibrio (Juan de Lugo e Juan de Salas); il concetto dinamico di competizione, intesa come processo di rivalit� fra i venditori (Castillo de Bovadilla, Luis de Molina); il recupero del principio della preferenza temporale (Mart�n de Azpilcueta); il carattere profondamente distorcente che l�inflazione produce sull�economia reale (Juan de Mariana, Diego de Covarrubias e Mart�n de Azpilcueta); l�analisi critica nei confronti della banca gestita attraverso la riserva frazionaria (Luis Saravia de la Calle e Mart�n de Azpilcueta); la scoperta che i depositi bancari formano parte dell�offerta monetaria (Luis de Molina e Juan de Lugo); l�impossibilit� di organizzare la societ� per mezzo di comandi coercitivi, a causa della mancanza di informazione necessaria allo scopo di fornire un contenuto di coordinazione ai medesimi (Juan de Mariana); la tradizione �giusnaturalistico-liberale�, secondo la quale ogni intervento ingiustificato sul mercato costituirebbe una violazione del diritto naturale (Juan de Mariana)[92].
A questo punto, risulta pertanto chiaro che, se si considera la particolare situazione storica che si � appena illustrato e, allo stesso tempo, si accolgono le osservazioni sopra esposte sulla prefigurazione da parte di alcuni scolastici spagnoli di fondamentali nozioni di economia �austriaca�, sussistono svariati argomenti a supporto della tesi in base alla quale � quantomeno nelle proprie fondamenta teoriche � la Scuola austriaca sarebbe, in realt�, da considerarsi come una �Scuola spagnola�[93]. Per quanto un tale sillogismo appaia tutt�altro che apodittico agli occhi di taluni osservatori, i quali preferiscono rimarcare il carattere di semplice �anticipazione parziale� delle teorie successive da parte dei teologi salmantini[94], � pur sempre opportuno tenere in considerazione come, anche in seguito, uno dei primi studiosi ad enunciare in maniera compiuta la legge dell�utilit� marginale sarebbe stato il gi� citato Balmes, che nel corso della sua breve vita divenne il filosofo tomista spagnolo pi� in vista del proprio tempo. Con ventisette anni di anticipo rispetto a quando lo stesso Menger avrebbe consegnato alle stampe la prima edizione dei suoi Grunds�tze der Volkswirtschaftslehre (1871) infatti egli, seguendo la tradizione soggettivista inaugurata dagli scolastici dei secoli XVI e XVII, sarebbe giunto non soltanto a risolvere il cosiddetto �paradosso del valore� degli economisti classici inglesi, ma addirittura avrebbe esposto, in tutti i suoi dettagli, la teoria soggettiva del valore basata sull�utilit� marginale nel proprio articolo, pubblicato il 7 di settembre del 1844, intitolato Veritiera idea del valore o riflessioni sull�origine, la natura e la variet� dei prezzi[95].
� quindi facile intuire come, in una tale prospettiva, rispetto ai lavori degli umanisti cattolici, la successiva strutturazione �scientifica� della disciplina economica da parte della Scuola classica anglosassone � cos� incentrata sulla teoria oggettiva del valore-lavoro e sull�analisi dell�equilibrio � possa a ragione venire interpretata pi� come una vera e propria �regressione�, anzich� come uno sviluppo, nella storia delle dottrine economiche. Tale involuzione troverebbe la propria causa e ragion d�essere in un �deviazionismo di origine protestante di fronte alla tradizione tomista continentale�; quest�ultima linea di pensiero, infatti, si sarebbe mostrata assai pi� sensibile alle esigenze particolari dell�essere umano ed inoltre non appariva �ossessionata dai dogmi della predestinazione e della redenzione attraverso il lavoro�, come per contro sarebbero stati i moralisti scozzesi del XVIII secolo[96].
Contro la �tosatura� della moneta
Sebbene in un contesto pi� ampio, volto all�esposizione della Late Scholastic Economics in generale[97], alcuni consistenti accenni agli aspetti basilari del pensiero economico elaborato dal Mariana sono stati fatti dal ricercatore argentino Alejandro Antonio Chafuen Rismondo nei suoi studi Christians for Freedom[98] e Faith and Liberty[99]. Nonostante le idee del gesuita spagnolo in materia di economia non fossero sistematiche, la qual cosa pu� essere attribuita al fatto che nella sua epoca tali dottrine non formavano ancora un corpo scientifico a s� stante, tuttavia esse apparivano lo stesso assai chiare e, in molti casi, avrebbero precorso le posizioni pi� avanzate della futura scienza economica. Osserva, ad esempio, Chafuen che, in base a quanto affermato nel De Rege dallo stesso Mariana, nel suo pensiero sembrerebbe possibile applicare la �teoria dell�utilit� soggettiva� all�analisi dei sistemi politici[100].
Il talaverano, nondimeno, dedic� un intero trattato allo studio dei problemi monetari, che non si riduceva ad una futile disquisizione numismatica, n� si perdeva in una esclusiva riproposizione di dati sterili; esso presentava, al contrario, un�intenzione elevata che permetteva all�autore di evitare tali pericoli per dimostrare i suoi postulati fondamentali, i quali possono concretizzarsi in due punti essenziali: 1) illegalit� della coniazione di moneta di bassa lega; 2) fatali conseguenze di tale misura. In tale trattato del 1609, intitolato De monetae mutatione, poi riproposto in traduzione castigliana dello stesso autore con il titolo Tratado y discurso sobre la moneda de vell�n que al presente se labra en Castilla y de algunos des�rdenes y abusos[101], Mariana analizzava il caso di una moneta spagnola dell�epoca che originariamente era composta in lega di argento, quindi in �mistura� (vell�n) gradualmente sempre pi� impoverita, fino a giungere ad avere una moneta completamente in rame. La �discrasia� nel composto metallico aveva dato origine ad un patente contrasto fra il valore nominale e quello reale di dette monete; gi� lo stesso Mariana, infatti, notava come una moneta detenesse due distinti tipi di valore: l�uno �intrinseco naturale�, il quale sarebbe stato determinato in base alla qualit� del metallo ed al peso, a cui tuttavia andava aggiunta la stima del costo sostenuto per il conio, �ch� vale ancora qualcosa il lavoro che si mette per forgiarla�. Il secondo valore si poteva denominare �legale od estrinseco�; esso era costituito da quello che gli apponeva tramite una sua legge il principe, �il quale pu� tassare quello della moneta come quello delle altre mercanzie�[102]. Concludeva il nostro autore che
�[i]l vero uso della moneta e quello che nelle repubbliche ben ordinate si � sempre preteso e praticato � che questi valori vadano di pari passo, perch� come sarebbe ingiusto nelle altre mercanzie che quello che vale cento si tassasse per dieci, cos� � nella moneta�[103].
Dunque, Mariana riconosceva che non era giusto far coniare moneta al principe a sue spese, poich�, tramite il conio, si recava un valore aggiunto a quello naturale della moneta ed il costo che quest�operazione comportava andava riconosciuto al monarca, come del resto disponeva anche la legge promulgata a Madrid nel 1556, in relazione al conio dei cuartillos[104]. Le specifiche misure adottate dai ministri della casa reale, tuttavia, comportarono una svalutazione della moneta spagnola rispetto ai mercati internazionali che provoc� una profonda crisi economico-finanziaria, la quale, come di norma, si ripercosse profondamente anche sulla popolazione. Di qui la ferma condanna e la conseguente denuncia del padre gesuita, che contestava al potere politico la facolt� di gestire a proprio piacimento il denaro pubblico, modificandone proditoriamente il contrassegno e la forma in assenza di gravi casi di necessit� ed in maniera permanente. Il talaverano giudicava il trasferimento di ricchezza per mezzo della svalutazione monetaria un �infame latrocinio�, paragonandolo all�azione di coloro i quali si recavano in granai privati per rubare porzioni del raccolto ivi immagazzinato[105].
Mariana combatt� l�alterazione della moneta dal punto di vista economico tanto quanto, o addirittura pi�, che sul piano politico. Essa, infatti, avrebbe condotto a quell�effetto, attualmente definito �inflazione�, che il gesuita avversava fieramente, poich� non soltanto avrebbe impoverito de facto la popolazione, che si ritrovava in tasca un valore inferiore a quello che le sarebbe spettato, ma anche perch� egli lo riteneva nocivo per il commercio estero. Quest�ultimo sarebbe divenuto in breve tempo impossibile, se i mercati nazionali non si fossero risolti per soffrire un indebolimento paritetico al deprezzamento della moneta; inoltre, poich� le cose detengono un valore in s�, al contrario della moneta che varia, agli occhi del religioso spagnolo non appariva lecito pagare con una moneta di bassa lega i debiti che si erano contratti al tempo in cui la moneta era buona[106].
Mariana attribuiva un�elevata importanza alla moneta solida; il denaro, infatti, assieme alle altre unit� di peso e misurazione, a suo giudizio costituiva le fondamenta dell�arte mercantile e dei contratti. Precisamente per tale ragione risultava opportuno che i pesi, le misure e la moneta non venissero modificati, se s�intendeva evitare �confusione ed oscillazioni del commercio�. Nel decimo capitolo del suo trattato sull�alterazione della moneta, Mariana elencava i gravi inconvenienti che derivavano da un processo di aumento artificioso della massa monetaria nel mercato. Richiamandosi espressamente all�Antico Testamento[107], il religioso spagnolo sosteneva addirittura che �la purezza ed il giusto prezzo� della moneta andassero custoditi e preservati all�interno del tempio. Il �siclo�[108] conservato nel tempio avrebbe dovuto rappresentare l�unit� di misura del valore (omnis aestimatio siclo sanctuari ponderatur). Inoltre, citando anche san Tommaso[109], il gesuita consigliava caldamente al principe di non alterare la valuta a proprio piacimento, biasimando la svalutazione del denaro in quanto pratica �barbara� sostenibile soltanto da parte di chi incarnava una �piaga della repubblica� ed, in quanto balzello indiretto per il popolo, assimilabile ad una sorta di rapina dai risvolti devastanti tanto nell�arena politica quanto in quella economica[110].
Nel mondo occidentale, il controllo da parte dell��autorit� spirituale� sulla moneta si era perpetuato ufficialmente e legittimamente fin verso la fine del Medioevo. Lo stesso Mariana ricordava il caso del re di Francia Philippe IV le Bel, il quale, per aver operato � mosso da �cupidigia� � una svalutazione del denaro, venne bollato da Dante Alighieri (1265-1321) come �falsificatore di moneta�[111]. Anche il giurista luterano Samuel von Pufendorf (1632-1694), peraltro menzionando esplicitamente lo stesso Mariana, avrebbe impiegato argomentazioni similari al fine di esecrare le politiche di svalutazione monetaria[112]. Chafuen, inoltre, rileva come nel De Rege Mariana si fosse espresso in favore del �mutuo scambio� di beni � insostituibile collante sociale � quale unica attivit� realmente efficace per superare la �scarsit�� a favore del �vantaggio personale�, vero motore dell�azione umana[113].
Il problema dei tributi: una visione �liberale�?
Mariana era consapevole che la base su cui occorreva sviluppare un�azione di governo, che dovesse mantenere un�organizzazione e dei funzionari, era quella delle �rendite pubbliche� ottenute, fondamentalmente, con il denaro degli stessi cittadini. Il gesuita fu tra i primi a dedurre una legge logica sull�efficacia e l�opportunit� delle imposte, le quali dovevano avere, innanzitutto, la possibilit� di essere coperte dai contribuenti.
Riguardo all�introduzione dei tributi, tuttavia, Mariana lasciava intravedere il suo criterio favorevole ai vantaggi di una certa autonomia amministrativa, pur sotto la direzione e tutela dello Stato. L�imposizione fiscale, inoltre, avrebbe dovuto essere moderata e si dovevano generare nuovi tributi solo quando fossero stati giustificati da casi eccezionali; anche perch�, se la causa era buona, secondo il gesuita, tutti vi avrebbero aderito volontariamente. Non si dovevano imporre altri tributi in aggiunta a quelli che lo stesso popolo aveva ratificato in base agli accordi delle Cortes che erano stati stipulati a Madrid nel 1329, al tempo di Alfonso XI (1312-1350), con la �petizione 68�[114]. Era, inoltre, da escludersi categoricamente che il re imponesse nuovi tributi senza l�approvazione popolare, giacch� in tal caso, cos� come per quanto riguardava l�abrogazione di leggi esistenti e la modificazione della procedura per la successione al trono, l�autorit� del sovrano si mostrava decisamente inferiore a quella della comunit�[115].
Egli parlava anche delle cariche improduttive di rendita, come l�esercito e la marina, le quali dovevano essere mantenute ad ogni costo, anche in tempo di pace[116]. Per�, per soddisfare queste necessit� si doveva eliminare ogni genere di arbitrio, fatta eccezione per il pignoramento delle rendite pubbliche, giacch� esse costituivano delle vere �prime eredit��, inalienabili secondo la stessa dottrina di Aristotele.
Nondimeno, la coattivit� dell�esazione fiscale rivestiva un tema centrale nel pensiero di Mariana, che si trovava sviscerato in vari suoi scritti. Secondo la visione del religioso spagnolo, in proposito perfettamente in linea con quella di Bodin, un limite inderogabile al potere sovrano era costituito da quelle leggi che regolavano i rapporti privati fra i sudditi, in primis i rapporti di propriet�. Per il talaverano il re non rappresentava il padrone della propriet� privata. Al contrario, il sovrano aveva dominio sulle tasse e le propriet� reali, ma non su altri beni[117]. L�agire diversamente � concludeva il gesuita � sarebbe stato un atteggiamento da considerarsi tirannico e coercitivo, per il quale, in base alla bolla papale In Coena Domini, si avrebbe meritato la scomunica[118].
Nel De Rege, il gesuita si occupava in maniera specifica anche del problema dei �tributi� (De vectigalibus)[119]. Nel settimo capitolo del terzo libro, infatti, egli enumerava con precisione i vari generi di tributo che era possibile individuare:
�Le entrate reali sono di tre tipi {regius census trisariam divisus est}: alcune rendite {pecunia} derivano dai beni patrimoniali del Sovrano, percepiti in denaro o in natura dalle locazioni, e sono destinate al sostentamento della famiglia reale e alla conservazione di tutta la corte e il palazzo. In secondo luogo vi sono i tributi ordinari {vectigalia ordinaria}: qualunque sia il motivo della loro esistenza e gli oggetti su cui grava, sono destinati all�amministrazione regolare della repubblica in tempo di pace {republica in pace regenda destinata sint}: servono al pagamento dei funzionari pubblici {publicis ministris}, al rafforzamento delle citt�, all�edificazione di fortezze, costruzione di strade pubbliche, riparazione di ponti, e al sostentamento delle truppe di guarnigione. Oltre a queste due risorse vi sono, in particolari circostanze, dei tributi straordinari {pecuniae extraordinariae} imposti alla popolazione, al cui aiuto si deve ricorrere o per difendersi nel caso di una guerra o per invadere i confini nemici�[120].
Gi� nelle pagine precedenti Mariana aveva osservato che i re giusti non avevano necessit� di ingenti prelievi. Storicamente, infatti, si intrapresero molte guerre importanti con tributi assai scarsi. Inoltre, secondo la visione del gesuita, se per tali ragioni non sembrava necessario imporre alla popolazione tributi smisurati e straordinari, tuttavia, qualora se ne fosse presentato il bisogno per l�erario, in seguito a calamit� o guerre inattese, il principe senz�altro li avrebbe ottenuti ugualmente con il consenso dei cittadini, se avesse saputo parlare loro con franchezza e non con il terrore, la frode e le minacce[121].
In ogni caso, era bene che la tassazione dei cittadini fosse moderata, soprattutto laddove le condizioni del territorio apparivano gi� depresse per cause naturali. Un valido criterio di giustizia avrebbe potuto essere quello di una qualche proporzionalit� nel prelievo[122].
Tutti questi accorgimenti stanno a dimostrare che la concezione del re che aveva in testa Mariana era una concezione nella quale il sovrano rappresentava semplicemente il popolo, ma non ne era il padrone. Egli, pertanto, doveva governare bene e nell�interesse dei governati:
�Non deve mai credersi padrone della repubblica n� dei suoi sudditi {Neque enim se Princeps reipublicae & singulorum dominum arbitrabitur}, sebbene gli adulatori dicano questo alle sue orecchie, ma capo dello Stato con un certo contributo stabilito dagli stessi cittadini: questa paga non tenter� mai di aumentare senza il volere di questi stessi {sed rectorem mercede a civibus designata: quam augere nisi ipsis volentibus nefas existimabit}. E, ci� nonostante, riuscir� ad accumulare tesori e ad arricchire l�erario pubblico {publicum aerarium} senza strappare un solo gemito ai suoi sudditi. [�] In questo modo il re Enrico III di Castiglia colm� la scarsezza delle casse dell�erario, esauste dalle calamit� dei tempi e, alla sua morte, pot� lasciare al figlio grandi tesori, raccolti senza frode, senza strappare un gemito o un lamento dai sudditi. Furono sue quelle parole: �Temo pi� l�esasperazione del popolo, che le armi dei nemici� {Populi se execrationes amplius quam hostium arma formidare}�[123].
Un punto significativo, al riguardo, � quello in cui Mariana si scagliava con veemenza contro i cortigiani, rei di traviare il principe indulgendo alle sue perversioni e, anzi, fomentandole per proprio tornaconto[124]. Una volta cacciati via gli adulatori, tuttavia, egli avrebbe dovuto circondarsi di uomini probi, ai quali spettava di svolgere l�arduo compito di impersonare �gli occhi e le orecchie� del re.
Questione sociale e tassazione indiretta
In tema di tributi, Mariana coglieva l�occasione per mettere in guardia anche contro gli effetti catastrofici che avrebbe potuto provocare un debito pubblico incontrollato. A tal fine il monarca avrebbe dovuto razionalizzare le uscite, sopprimendo le erogazioni in esubero, per meglio calibrare la tassazione. L�obiettivo dichiarato consisteva nel perseguire un equilibrio fra quanto lo Stato era in grado di incamerare e quanto, per contro, si aveva intenzione di spendere, al fine di non essere costretti a richiedere un prestito, intaccando cos� le risorse imperiali nell�intento di coprire gli interessi[125].
Il religioso spagnolo affermava con decisione che la spesa regale doveva essere ridotta. Infatti, egli sosteneva di aver preso visione di una certa documentazione, redatta al tempo in cui regnava il monarca Juan el Segundo (1458-1479) e riferita all�anno 1429[126], quando le spese regali ammontavano, approssimativamente, ad otto cuentos de maraved�s[127], mentre nel 1564, sotto l�imperatore Felipe II, esse erano cresciute fino a raggiungere i diciotto milioni di maravedini[128]. Nessuna giustificazione avrebbe potuto spiegare un cos� sproporzionato aumento nella spesa della casa reale, ammoniva il gesuita; ed aggiungeva sdegnato:
�si dice che da pochi anni a questa parte non ci sia un solo impiego o posizione che i ministri non vendano in cambio di regalie e baciamani, etc., perfino i tribunali e i vescovadi; non sar� vero, per� � abbastanza vergognoso che si dica. Vediamo ministri usciti dalla polvere della terra in un momento caricati di migliaia di ducati di rendita; di dove � uscito questo, se non dal sangue dei poveri, dalle viscere di negozianti e pretendenti?�[129].
La figura dell�esattore delle tasse era particolarmente presa di mira dal Mariana, il quale la giudicava uno dei pi� grandi mali per la repubblica. Questa figura era deprecata anche per la confusione che generava il suo ruolo ibrido. L�esattore, infatti, riscuoteva i tributi per conto dello Stato, ma rimaneva pur sempre un privato cittadino, che riceveva questa funzione in appalto. Storicamente, d�altra parte, non mancavano gli esempi, come quello di Verre nella Trinacria romana, che avvalorassero la tesi sostenuta dal gesuita; e questo Mariana dimostrava di saperlo assai bene[130]. Pertanto, egli invitava espressamente a non privarsi di questa fondamentale funzione[131]. Ben lontano dai precetti moderni, l�influsso dell�etica cristiana si faceva sentire ancora poderoso nelle parole del gesuita, che chiamava in causa lo stesso Aristotele al fine di regolamentare il prestito ad interesse:
�Credo che si debba ordinare al principe, ed osservare egli stesso, la legge che, come ricorda Aristotele, si osservava anticamente in molte citt�, secondo la quale a nessuno era consentito vendere la prima eredit� dietro corresponsione di denaro {nemini licere primariam haereditatem pecunia vendere}. Si ricordi anche di un�altra legge, molto famosa, attribuita a quanto dicono ad Oxe: �A nessuno � consentito ricevere denaro ad interessi, dando in ipoteca la sua propriet� o parte di essa� {faenori pecuniam dari fundo aut fundi partae oppignerata nemini liceto}�[132].
Tuttavia, ci� che sembra stesse a cuore a Mariana sopra ogni altra cosa era la �questione sociale�. Uno Stato che non tenesse in dispregio l�etica non poteva gravare con imposte e dazi di ogni sorta i propri cittadini, soprattutto quelli pi� poveri. Mariana, infatti, condivideva il concetto aristotelico secondo cui una societ� equilibrata doveva reggersi sulla classe media, che andava, pertanto, privilegiata ed incrementata.
Ma come sarebbe stato possibile incamerare il necessario sostentamento finanziario, senza incidere negativamente sulle risorse private dei cittadini meno abbienti? Mariana suggeriva che attraverso la �tassazione indiretta�, ossia sui consumi, si sarebbe potuti riuscire a calibrare la portata del prelievo fiscale nel senso di una maggior equit�, alleviando cos� la miseria dei cittadini[133].
In tale ottica, i cosiddetti �beni di lusso� ed, in generale, i beni voluttuari, erano, per definizione, da ritenersi superflui; conseguentemente, per Mariana essi potevano essere gravati da pesanti imposte, giacch� questo non avrebbe compromesso la libert� individuale: colui il quale poteva permettersi di acquistarli, infatti, non avrebbe subito un danno eccessivo a causa della tassazione, anche perch� restava pur sempre libero nel decidere di non comperarli; qualora, per contro, avesse deciso di farlo ugualmente, non gli sarebbe stato in alcun modo impedito ma, almeno, con la sua ostinatezza per le cose futili avrebbe recato un beneficio all�intera comunit�[134].
Inoltre, nel trattato De monetae mutatione si affrontava la questione di quell�altra tassazione indiretta che era rappresentata dal fenomeno inflazionistico. Tale problematica risultava nevralgica. Secondo Mariana, ogniqualvolta si vociferava che il tesoro pubblico era stato esaurito i contribuenti, giustamente, si sdegnavano. Di conseguenza, l�atterrito principe avrebbe ansiosamente ricercato un qualunque escamotage per far fronte ai propri debiti. In queste posizioni di Mariana, oltre che un chiaro riferimento ad Aristotele, sembrerebbero quasi riecheggiare anche le parole utilizzate dal giurista imperiale Julius Paulus (ca. 160-224) nel Digesto[135]. Cosicch� il concetto di publica ac perpetua aestimatio risulta essere un cardine del pensiero economico del gesuita derivato, oltre che dalla teoria cristiana del �giusto prezzo�[136], dall�idea di un prezzo stabile e fissato dalle autorit�, che era una tematica gi� propria della riflessione antica. Dunque, per Mariana costituiva un grave abuso alterare la moneta sine populi consensu, tanto che egli asseriva: �nessuna cosa che sia in pregiudizio del popolo � consentito fare al principe senza il consenso del popolo (dicesi pregiudizio prendersi qualunque parte delle sue finanze)�[137].
Importante � anche sottolineare come, in quanto forma indiretta di tributo, in linea di principio Mariana considerasse immorali gli stessi monopoli di Stato. Tuttavia, quando questi fossero stati istituiti per un maggior beneficio nella distribuzione ed abbassamento dei prezzi, avrebbero senza alcun dubbio rappresentato la pi� indovinata gestione di governo possibile[138].
Quanto deve essere libero il mercato?
Invocare un intervento governativo in termini di tassazione per riequilibrare l�assetto sociale � un espediente che risulta poco assimilabile alla tradizione liberale classica. La tassazione indiretta, poi, che va ad incidere sui consumi � una misura di politica economica la quale, per cos� dire, influisce direttamente sul mercato, condizionando, in una certa misura, le scelte degli acquirenti. Di conseguenza, i fautori pi� intransigenti ed integralisti del �libero mercato� rifiutano nettamente tale tipo di soluzione redistributiva. Mariana, per contro, subiva l�influsso aristotelico della mediazione, espresso nel concetto di �polit�a�, che puntava a stemperare le diseguaglianze economiche nel tessuto sociale, favorendo il ceto medio quale massima garanzia di stabilit� politica.
Ma numerosi altri dogmi caratterizzarono il movimento liberoscambista del XIX secolo, di cui il principale era l�annullamento di qualunque sorta di imposta doganale; ogni forma di politica �protezionistica� andava soppressa in nome della libert� di commercio. Mariana sembra accogliesse certe istanze legate al libero commercio; tuttavia, le sue posizioni si ponevano all�insegna della moderazione e rifuggivano qualunque dogmatismo per essere calibrate e modulate di volta in volta, a seconda delle situazioni specifiche. Cos�, egli sostenne il ceto mercantile invocando sgravi fiscali per tale categoria. Quella che svolgevano i mercanti, infatti, era da ritenersi un�attivit� vitale per lo Stato e, pertanto, occorreva facilitare, da un punto di vista politico, il loro compito:
�Conviene inoltre favorire il commercio con le altre nazioni, con modici tributi piuttosto che impedirlo con gravose imposte {Praeterea commercia cum alijs regionibus iuvanda potius moderatis vectigalibus sunt, quam impedienda tributorum gravitate}. Infatti, sebbene il venditore {venditor} copre con il ricavato della vendita ci� che ha speso nel tributo, tuttavia, quanto minore sar� il numero dei compratori, per il prezzo alto, tanto pi� difficile sar� lo scambio dei prodotti {commercij}. Occorre facilitare, sia per mare che per terra, l�importazione e l�esportazione {invectiones evectionesque} degli articoli necessari. Accadr� in tal modo di poter scambiare ci� che in alcune nazioni abbonda con ci� che in altre manca, e viceversa: vero oggetto e scopo del commercio, a cui questa arte deve tendere {qui est verus mercaturae usus & finis, quo tota ea ars referri debet}. Avidi mercanti {avidi mercatores}, invece, aumentano il prezzo degli oggetti, valendosi di cattive arti e vendendo una cosa pi� volte in uno stesso punto: tutto questo deve essere proibito da una legge, affinch� non siano aumentati i prezzi, a causa della loro cupidigia {lege prohibendum est, ne ex eorum aviditate pretia rerum augeantur}. Al di l� di questi casi sono del parere che occorre proteggere gli interessi dei mercanti, e sostenere con le leggi e il diritto quest�arte che tanto giova alla salute dello Stato {Alioqui mercatorum commodis consulendum arbitror iure & legibus adiuvanda ars imprimis reipublicae salutaris}�[139].
Parimenti, tuttavia, secondo Mariana andavano combattute le distorsioni che singoli soggetti operanti all�interno del mercato avrebbero potuto porre in essere. Giacch�, non essendo il mercato un�entit� pensante e con vita autonoma, bens� consistendo esso in uno dei tanti collectiva che, semplicemente, tenterebbe di esprimere sinteticamente la sommatoria dei singoli individui che al suo interno operano, poteva darsi che alcuni di essi provassero ingiustamente ad approfittare della propria posizione aumentando indebitamente i prezzi delle merci per avidit�. Contro tali eventualit� avrebbe dovuto erigersi un argine in base alle norme di diritto, cosa alla quale spingeva anche la semplice constatazione per cui
�[I]l mercante che, per poter trarre maggiore profitto, inganna {mercator qui specie utilitatis decipit} non pu� conservare ci� che ingiustamente {iniuste} ha ottenuto con la frode {per fraudem} e rompe con le relazioni commerciali�[140].
La riaffermazione della legalit� giuridica nei confronti degli abusi, tuttavia, rappresentava soltanto una faccia della medaglia dell�intervento governativo nel mercato che, secondo Mariana, avrebbe dovuto compiersi anche in forma positiva per mezzo di aiuti concreti all�arte mercantile da parte dello Stato.
Inoltre, l�elemento nazionalista, evidente e scontato in un�opera indirizzata al sovrano dell�impero spagnolo, imponeva a Mariana di escogitare o recepire misure idonee a preservare l�economia iberica, preoccupandosi anche della �questione demografica�. Egli, pertanto, affianc� ai propri elogi del libero commercio anche severi ammonimenti di chiara marca �protezionistica�. Cos�, ad esempio, il gesuita dichiarava di desiderare che il medesimo criterio venisse osservato anche per quegli articoli i quali provenivano dalle altre province,
�sopra i quali credo si debba imporre un alto tributo {magno imposito vectigali vendantur}; in tal modo uscir� meno denaro dal regno {Sic pecuniae minus deferetur ad exteros} e, con la speranza di guadagnare, verranno in Spagna artigiani, accrescendo la popolazione, di cui nulla � pi� vantaggioso per aumentare le ricchezze tanto del re quanto del regno�[141].
D�altronde, anche in tema di produzione agricola Mariana si diceva convinto che questa dovesse incrementarsi grazie all�intervento dello Stato; per tale motivo, egli teorizz� l�istituzione di premi al miglior coltivatore e propose l�espropriazione per causa di utilit� pubblica con indennizzazione soltanto di una parte del valore dell�espropriato a quegli agricoltori che si fossero mostrati negligenti.
Degno di attenzione, inoltre, appare il suo criterio di tassazione del prezzo dei prodotti, relazionato con le riserve metalliche, per evitare il deprezzamento della moneta ed il corrompersi del mercato; regolamentazione che sarebbe andata a favorire, principalmente, il piccolo proprietario.
L�impostazione di Mariana in materia di economia, in conclusione, sembrerebbe essere stata improntata, come quella politica, ad un avveduto e ragionevole senso pragmatico, che rifuggiva qualunque genere di �assolutismo�, coniugando felicemente istanze di diversa matrice nell�intento di elaborare ricette in grado di risolvere le complesse esigenze del momento. L�utilit� delle varie misure, tuttavia, andava conciliata con gli imperativi etici che raccomandava la morale cristiana. Al dogma era necessario ricorrere in tema di religione, sembra aver voluto dire il gesuita; per le cose terrene sarebbe stato sufficiente osservare la realt� con occhi vigili e disincantati ma col cuore aperto, senza il bisogno di nessuna �rivelazione� n� di alcun �atto di fede�. In questo mondo la verit� e la felicit� assoluta restavano un�utopia: occorreva accontentarsi di soluzioni parziali, suggerite dal buon senso e sostenute dall�integrit� dell�animo umano virtuoso.
Epilogo: Juan de Mariana, un pensatore eclettico
Com�� noto, il trattato De monetae mutatione al Mariana procur� un anno di reclusione; e ci� ha contribuito a procurargli quella fama di ribelle libertario a cui si � gi� accennato. Tuttavia, va detto che, in fondo, le sue parole erano state in gran parte equivocate o, quantomeno, se non proprio travisate nel loro significato, certamente misinterpretate nel proprio bersaglio. Infatti, quando egli ammoniva: �[i]o confesso la verit�, che mi meraviglio che coloro i quali siedono al governo non abbiano conosciuto questi esempi�[142], feriva profondamente la sensibilit� del duca di Lerma e dei suoi ausiliari, i quali scorsero in tali parole un�allusione a se stessi; equivocandole, tuttavia, giacch� Mariana intendeva riferirsi ad Alonso Ram�rez de Prado e Pedro Franqueza, gi� da tempo castigati per i loro abusi quando apparve il trattato sulla moneda de vell�n[143]. In esso si ponevano di manifesto i vizi della burocrazia dell�epoca, della quale si esponevano gli inconvenienti sostenendo a chiare lettere che, se non lo facevano in maniera adeguata, coloro che governavano avrebbero ricevuto, meritatamente, l�odio del popolo. Tutto ci� assieme alla dichiarazione iniziale, nella quale Mariana sosteneva di apprestarsi a dire quello che nessun�altro si era mai azzardato a proclamare prima, resero oltremodo sospettoso il suo trattato agli occhi del governo in carica. Di certo, l�opera di Mariana si pose, al fianco di quella di Juan Luis Vives (1492-1540) e, soprattutto, di Pedro de Valencia (1552-1620), con il suo Discurso acerca de la moneda de vell�n del 1605, come parte di una trilogia che, unica, si oppose al potere del re sulla coniazione della moneta.
� possibile che a taluni Mariana sia sembrato un uomo �avanti con i tempi� semplicemente perch�, invece, era �indietro� ma, allo stesso tempo, profondamente consapevole dell�epoca in cui viveva[144]. La moneta spagnola, infatti, essendo un circolante internazionale, aveva degli aspetti metallistici che la rendevano simile ad una �merce-campione�. La sua stabilit� costituiva la garanzia anche della stabilit� dei prezzi e, quindi, dell�ordine rispetto alla sussistenza ed agli scambi. Ma tale garanzia di stabilit� era assicurata, innanzi tutto, dall�atteggiamento del re. Se questi, infatti, mosso da avidit�, avesse modificato la moneta, avrebbe generato crisi, guerre, miseria. Tutto sembrerebbe risiedesse, per Mariana, nell�eticit� del comportamento regale: perfino tasse e monopoli � sebbene, per principio, non auspicabili � potevano risultare accettabili, purch� finalizzati al �bene comune� (bonum commune).
A questo proposito, in merito alle interpretazioni rigidamente individualistiche e libertarie della filosofia politica di Mariana, cos� come di quella dello stesso Aquinate, � opportuno, forse, riportare il commento di un tomista convinto come monsignor Francesco Olgiati (1886-1962), il quale riteneva che
�[n]ulla � pi� in contrasto con la concezione di S. Tommaso della teoria individualistica, propria del liberalismo e tante volte condannata nei documenti pontifici [�]. Quando l�individualista crede di avere S. Tommaso come alleato nella difesa della dignit� della persona, trascura che la �persona� della filosofia dell�essere (e della religione cristiana) non deve calpestare le leggi dell�etica�[145].
In sostanza, il sospetto che emerge da una lettura approfondita e scevra da pregiudizi dell�opera scritta dal gesuita spagnolo � che, spesso, si sia voluto stravolgere il suo pensiero con etichettature che tendevano ad evidenziarne soltanto una minima parte. Di fronte ad un Mariana �socialista� e ad uno �individualista�, verrebbe da osservare che, pi� opportunamente, egli avrebbe potuto essere definito semplicemente come un cattolico eclettico. � nota, infatti, l�attenzione secolare della Chiesa nei confronti delle tematiche politico-sociali e, se al suo interno � possibile rilevare una miriade di posizioni differenti, � pur vero che, spesso, si pu� anche intravedere fra di esse un �minimo comun denominatore� che le unisce e le distingue dalle teorie laico-secolarizzate, quali restano pur sempre sia il socialismo che l�individualismo. Mariana mostrava di essere incline ad accogliere varie posizioni, senza lasciarsi irretire in alcuna corrente specifica; egli, infatti, riteneva di leggere distintamente la realt� in quanto la giudicava �dall�alto�, da uomo, cio�, che si collocava nel mondo, ma misurando le cose sul metro della parola divina e, ovviamente, senza il bisogno di �interpretarla liberamente�.
Non v�� dubbio che a Mariana stessero a cuore le questioni individuali; ma, allo stesso tempo, il valore attribuito alla funzione dell�etica personale, assieme all�attenzione per i problemi della dignit� umana, ponevano un argine poderoso verso le estremizzazioni in un senso o nell�altro; argine che contribuiva a demarcare nettamente gli ambiti in cui tale libert� individuale poteva svilupparsi e prosperare. Insomma, se � indiscutibile il fatto che egli anticip� alcuni nodi fondamentali del soggettivismo economico �austriaco� e che la sua attenzione per la persona umana lo pose in una prospettiva che, per certi versi, potrebbe essere assimilabile all��individualismo metodologico�, tuttavia, appare altrettanto evidente la sua distanza intellettuale dall��individualismo filosofico�, che in epoche successive ha condotto all�elaborazione di dottrine solipsistiche ed anarcoidi, in molte delle quali, pi� che la libert� dei singoli, si pretendeva di rivendicare la supposta legittimit� della loro licenza. Degno di nota appare il fatto che le soluzioni di due correnti di pensiero idealmente tanto distanti, come indubbiamente sono il liberalismo economico contemporaneo e l�etica sociale dei teologi rinascimentali, sovente convergano in maniera cos� chiara e decisa. Di conseguenza, per quanto il definire Mariana come un precedente storico di �libertario� o come �il primo economista austriaco� possa comprensibilmente apparire un anacronismo di fronte al quale per lo storico delle dottrine � legittimo storcere il naso, tuttavia, ci� conserva nella sostanza una sua dose di ragionevolezza qualora si indossino gli occhiali dell�economista, del politologo o dello studioso di filosofia politica. Difatti, gli anatemi ecclesiastici contro il �liberalismo� sono circoscrivibili alla sua versione utilitaristica, impregnata di tematiche tipicamente ottocentesche, come il nazionalismo, il relativismo, l�agnosticismo. Pertanto, � evidente come quei libertari che pongono al centro dei propri interessi le questioni deontologiche risultino in larga parte immuni da tali rilievi. Conseguentemente, per�, i problemi che si presentano allo studioso che intenda tracciare una sorta di parallelo fra le due distinte e articolate teorie economico-politiche della Neoscolastica spagnola e del libertarismo contemporaneo si possono ridurre, essenzialmente, a due. Innanzi tutto, verificare se all�interno del variegato arcipelago libertarian siano o meno riscontrabili posizioni che richiamano quelle del �nichilismo morale� o dell��edonismo narcisistico�, che accomuna liberalismo �milliano� ed egoismo �stirneriano�; idee le quali rappresentano efficacemente quegli esempi utilitaristici, atomistici, solipsistici ed anarcoidi reiteratamente condannati dalla Chiesa e, certamente, assai distanti dalla lezione tomista. In secondo luogo, domandarsi se sia filologicamente pi� corretto e teoricamente pi� proficuo sostenere che le posizioni libertarie trovano dei parziali antecedenti storici nelle teorie enucleate da alcuni teologi cattolici di epoca rinascimentale, o piuttosto concedere che, semplicemente, sono taluni Libertarians che intenderebbero coniugare, in maniera deliberata, tradizioni di pensiero le quali, altrimenti, a parte qualche aspetto marginale, poco avrebbero a che spartire fra di loro; tutto ci� nell�intento precipuo di formulare, in tal modo, una nuova filosofia politica in grado di superare i presunti limiti di entrambe.
Qualche parola va spesa in relazione al supposto �razionalismo� di Mariana, pi� volte rilevato da taluni commentatori. Egli era senza dubbio assai lontano dalla critica aspra e totale all�utilizzo delle forze della mente umana per cogliere ed assimilare le verit� d�ordine naturale; posizione con la quale, all�opposto, s�identificava quel filone (poi raccolto da un certo �tradizionalismo�, anche cattolico) che negava ogni validit� alla ragione. Ci� sarebbe equivalso a negare le fondamenta della tradizione tomista, verso cui, per contro, tutta la Neoscolastica spagnola, pur nella sua variet�, rimaneva profonda debitrice. Tradizione che, peraltro, appariva come il pi� sublime tentativo di sintesi tra fede e ragione che la storia abbia conosciuto, giacch� restava fedele alla convinzione secondo cui il Sommo Autore ordin� la ragione alla verit� e non, certamente, all�errore. Essa si rifaceva all�insegnamento di Aristotele, che aveva tradotto la sapienza tramandata in una dialettica ontologica. L�accostamento di Mariana al moderno razionalismo �, dunque, comprensibile; specialmente se si accetta l�interpretazione per cui gi� la Scolastica del tardo Medioevo avrebbe risolto la sintesi della filosofia �accademica� e di quella �peripatetica� in favore di una concezione pi� rigorosa di quest�ultima, preparando in qualche modo la sua stessa fine e la vittoria del razionalismo. D�altra parte, Mariana sembrerebbe aver compiuto un passo ulteriore verso la modernit� con la ratifica del trapasso � all�epoca ancora in fieri � dallo �scientismo cabalistico�, proprio dell�empirismo �magico� di radice aristotelica, a quello �puro� o moderno, secondo cui il calcolo di ogni genere avrebbe dovuto essere �verificato dall�osservazione� (con tutte le conseguenti implicazioni politiche di matrice �democratica� implicitamente connesse con la fede dichiarata nell��esperienza di prima mano�)[146]. Tale propensione resta consegnata in affermazioni del tenore di quella secondo cui �[n]essuna vita, per lunga che possa essere, � sufficiente ad ottenere anche una sola scienza, se non fa tesoro delle osservazioni di molti e dei risultati forniti da una lunga esperienza�[147]. Nondimeno, va chiarito come, in realt�, la �ragione� di cui egli si avvaleva non fosse ancora quella dei razionalisti moderni, bens� come essa, pi� semplicemente, s�identificasse con il nobile impiego dell�intelletto umano per il discernimento dei problemi: da ci� a riconoscere la superiorit� della ragione sull�anima, evidentemente, rimaneva pur sempre un abisso. Occorreva, infatti, non dimenticare mai che �temeraria sarebbe ogni indagine sugli arcani divini posti al di l� della comprensione umana�[148]. La qual cosa, peraltro, appare indubbiamente significativa alla luce di quella critica radicale che, pur da una prospettiva completamente diversa, avrebbe sferrato alla hybris del moderno razionalismo �costruttivistico� proprio uno dei pi� insigni teorici dell��austro-liberalismo� contemporaneo[149].
Appare importante non disconoscere il mondo spirituale all�interno del quale il gesuita si muoveva che, in gran parte, rimaneva ancora il mondo della tradizione cattolica[150]. Occorre, pertanto, non perdere di vista che il talaverano persegu�, fra le altre cose, combattere la Riforma, attaccandola nel pi� profondo della sua rivoluzione, con uno spirito riformista che cercava la restaurazione di tutta la grandezza del passato, fustigando tutto il male del presente. Ci� di per se stesso non significa cedere all��oscurantismo�; egli, infatti, ammetteva gli umani appetiti di gloria e fama, cos� come l�amore per la scienza e per lo studio, ma sempre che non fossero contaminati dal peccato, n� dalla vanit�.
Secondo un�ottica tipicamente cristiana, per Mariana l�etica non era avulsa dalla sfera politica e la memoria storica avrebbe decretato il verdetto definitivo, attribuendo osanna o condanne senza appello. Nel Trattato contro i giochi pubblici[151], per esempio, ad ogni pie� sospinto Mariana esercitava il proprio intento moralizzatore e, alla minima occasione che gli si presentasse opportuna, parlando dei giochi nei quali conveniva che si esercitasse il principe, sosteneva che questi non dovevano possedere nulla di crudele che contraddicesse i costumi e la piet� cristiana[152]. Inoltre, in varie occasioni egli censurava con crudezza i vizi dell�epoca, senza per questo scadere in toni stucchevolmente moralistici. I suoi strali non risparmiavano nessuno: dai nobili cortigiani, accusati reiteratamente di essere effeminati, adulatori infidi e ladri, fino ai magistrati, ai vescovi e a certi stessi pontefici, passando per gli esattori delle tasse, tarme delle rendite reali, e i giureconsulti, sulle cui arguzie ironizzava acutamente, nonch� gli stessi sovrani i quali, sotto la qualifica di �tiranni�, non si salvavano dalle bacchettate del gesuita[153].
La posizione di Mariana di fronte alla Chiesa, che riteneva degna di stare sopra a tutte le cose terrene, in quanto rappresentante dei poteri celestiali, ammetteva la separazione di questa dallo Stato, per maggiore forza di entrambi. Tuttavia, il talaverano indicava come conveniente che i religiosi prendessero parte attiva all�organizzazione civile e che, a loro volta, si onorassero con dignit� ecclesiastiche quei cittadini che lo avessero meritato, in maniera tale che il clima di cordiale collaborazione presiedesse ai lavori della Chiesa e dello Stato[154]. �, anzi, opportuno rilevare come Mariana abbia difeso una partecipazione del clero alla politica in quanto vedeva in esso, soprattutto, un potere moderatore di quel monarca legibus solutus che, nell�Europa del Rinascimento, difendevano i teorici della monarchia assoluta. Per Mariana la Chiesa rappresentava un�istituzione dalla quale non si poteva prescindere, la cui funzione essenziale veniva perseguita anche grazie alla sua potenza temporale[155].
Appare dunque evidente che uno Stato cos� concepito, quasi teocraticamente strutturato, dovesse necessariamente configurarsi come confessionale e cattolico, in linea con il sistema �ierocratico� propugnato in quel tempo dall�autorit� ecclesiastica. Ci� traspariva chiaramente dalle parole di Mariana, il quale, nel sedicesimo capitolo del terzo libro del De Rege sentenziava come �[n]on � vero che in un solo regno possano esserci molte religioni�[156]. Inoltre, nelle varie occasioni in cui parlava della missione che doveva portare a termine l�impero spagnolo nel mondo, egli poneva come funzione principale, indispensabile per la sua espansione, la predicazione e diffusione della religione cristiana.
In un tale Stato su base religiosa � logico pensare che ogni ingiustizia sociale dovesse sembrare intollerabile. Nel concetto statale di Mariana, difatti, si presentava tanto perentorio questo senso di uguaglianza che per il gesuita risiedeva nella stessa natura dell�uomo, il quale poteva ascendere per la scala degli onori, come gi� in passato alcuni fecero dando origine all�aristocrazia; assumendo, cos�, una posizione che apriva decisamente la via alla concezione sociale che avrebbe poi contraddistinto la modernit� occidentale. Tale convinzione si legava strettamente al concetto che di �aristocrazia� Mariana aveva in mente, il quale rispondeva a criteri piuttosto complessi e sembrava non tenere in grande considerazione la stratificazione sociale in base a distinzioni di sangue. Una classe nobiliare avulsa da responsabilit� di governo rischiava di adagiarsi unicamente sugli allori dell�autocompiacimento, attribuendo la propria condizione ad arcane questioni ancestrali e giungendo perfino a disprezzare le altre componenti del popolo che, invece, occorreva coinvolgere[157].
Per comprendere l�ordinamento logico di Mariana, occorre non perdere di vista il metodo �induttivo� da lui utilizzato. Dapprima, egli affrontava la trattazione dell�istituto monarchico e della conseguente autorit�; in un secondo tempo, si concentrava sull�autorit� popolare come superiore a quella del monarca; infine, veniva decretata la superiorit� dell�autorit� ecclesiastica su qualunque altra. Da una tale prospettiva di valutazione sul valore politico dell�opera di Mariana, emerge in tutta chiarezza l�intento religioso e, in special modo, �gesuitico� dell�autore, che coincideva con l�affermazione del potere temporale della Chiesa rispetto a quello laico. Lo spagnolo, infatti, sosteneva che, qualora il principe avesse mostrato disprezzo per la religione, avrebbe dovuto abdicare od essere destituito[158]. In proposito, � stato osservato come la vastit� d�interpretazione a cui si presta il concetto di �disprezzo della religione� offrisse a Mariana gli strumenti pi� adeguati per tentare d�imbrigliare in qualche modo il potere laico: probabilmente, fine recondito dell�intera sua opera[159].
In conclusione, occorre rilevare come le tematiche analizzate da Mariana non costituissero, certamente, argomenti originali di per s�. Al contrario, anche le sue tesi pi� polemiche, come ad esempio la superiore autorit� del regno su quella del monarca e, di conseguenza, la sottomissione del re alle leggi � che il gesuita si compiaceva di sottolineare � o persino la stessa teoria del tirannicidio erano gi�, in una certa misura, dottrina comune di quella che � stata definita �scuola spagnola del XVI secolo� o �Scuola di Salamanca� e, pi� in generale, temi europei[160]. L�originalit� consistette, pertanto, nella maniera in cui egli si accost� a certi argomenti, nel suo personale modo di esporli.
�, dunque, opportuno ricollocare ogni manifestazione del pensiero di Mariana all�interno del microcosmo nel quale era stata partorita. In una tale logica, lo stesso rilievo attribuito alla dignit� della persona umana, che era certamente presente nell�ideario del padre gesuita, pur distinta nettamente dall�arbitrio individualistico idolatrato nelle epoche successive da certe dottrine di stampo �atomista�, parrebbe anzi rappresentare uno dei tratti salienti e peculiari della sua filosofia, nonch�, allo stesso tempo, l�effetto di una visione del mondo ancora di tipo sostanzialmente tradizionale. Ecco che, in base ad essa, la personalit� umana sembrerebbe aver rappresentato � secondo una tipica versione dell�Hispanidad � una �monade spirituale�, od anima ordinata alla vita perpetua, in grado di incarnare lo strumento di valori assoluti e di esprimere, essa stessa, un valore assoluto in s�. Da qui, la giustificazione di un rispetto fondamentale per la dignit� dello spirito umano, per l�integrit� e la libert� della persona: una libert� di natura profonda e legittimata superiormente, che non si sarebbe mai potuta tradurre nella facolt� di infrangere arbitrariamente la convivenza civile o di minarne le fondamenta.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI
Alejo Montes, Javier, (1990) La reforma de la Universidad de Salamanca a finales del siglo XVI. Los estatutos de 1594, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.
�lvarez de Morales, Antonio, (1991) La reforma de la ense�anza en Espa�a y Portugal en los siglos XVI-XVII, in Universidade(s). Hist�ria. Mem�ria. Perspectivas. Actas do Congreso �Historia da Universidade� (7� Centen�rio da sua Funda��o. 5 a 7 de Mar�o de 1990), 3, Coimbra, Gr�fica Ediliber.
Andr�s Mart�n, Melquiades, (1976-1977) La Teolog�a Espa�ola en el siglo XVI (2 voll.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
Antiseri, Dario, (1995) Cattolici a difesa del mercato, Torino, Societ� Editrice Internazionale.
Aquino, Tommaso di, (1266) De Rege et Regno ad Regem Cypri [fino al Lib. II, cap. 4 inclusi; il resto � di Tolomeo da Lucca], trad. it. La Politica dei Principi Cristiani (De Regimine Principum), Siena, Edizioni Cantagalli, 1981.
Artola, Jos� Mar�a, (2002) Introducci�n a Tom�s de Aquino, Sobre la eternidad del mundo, Edici�n biling�e de Jos� Mar�a Artola, O. P., Madrid, Ediciones Encuentro.
Avil�s Fern�ndez, Miguel, (1987) Historia de la ex�gesis b�blica espa�ola (1546-1700), in Melquiades Andr�s Mart�n (dir.), Historia de la Teolog�a Espa�ola (2 voll.), Madrid, Fundaci�n Universitaria Espa�ola, 1983-1987.
Ballesteros Gaibrois, Manuel, (1939) P. Mariana, pensador y pol�tico. Antolog�a, Madrid, Ediciones Fe.
� (1944) El Padre Juan de Mariana. La vida de un sabio, Barcelona, Editorial Amaltea.
Balmes Urpi�, Jaume Luciano, (1842) Mariana, in �La Civilizaci�n�, 1� quincena, noviembre, in Id., Obras completas (8 voll.), tomo VIII, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, de la Editorial Cat�lica, 1949.
� (1842-1844) El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la Civilizaci�n Europea (4 voll.), Barcelona, Imprenta de Antonio Brusi, trad. it. Il protestantesimo comparato col cattolicesimo nelle sue relazioni con la civilt� europea (2 tomi), Parma, Tipografia Ducale, 1886.
� (1844) Verdadera idea del valor o reflexiones sobre el origen, naturaleza y variedad de los precios, in Id., Obras completas cit., tomo V, pp. 615-624.
Barrientos Garc�a, Jos�, (1984) Moral econ�mica en el �De Iustitia et Iure� de Pedro de Arag�n, in �Cuadernos Salmantinos de Filosof�a�, 11, pp. 461-480.
� (1985) Un siglo de moral econ�mica en Salamanca (1526-1629). Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.
Bastit, Michel, (1990) Naissance de la loi moderne. La pens�e de la loi de Saint Thomas � Su�rez, Paris, Presses Universitaires de France.
Belda Plans, Juan, (1984) Teolog�a y humanismo en la Escuela de Salamanca del siglo XVI, in Confrontaci�n de la teolog�a y la cultura: actas del III Simposio de teolog�a hist�rica (7-9 mayo 1984), Valencia, Facultad de Teolog�a San Vicente Ferrer, pp. 169-174.
� (2000) La Escuela de Salamanca y la renovaci�n de la teolog�a en el siglo XVI, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
Beltr�n de Heredia, Vicente, (1915) La ense�anza de Santo Tom�s en la Compa��a de Jes�s durante el primer siglo de su existencia, in �Miscel�nea�, Vol. 2, pp. 309-342.
Beltr�n Fl�rez, Lucas, (1987a) Sobre los or�genes hisp�nicos de la Econom�a de Mercado, in �Cuadernos del Pensamiento Liberal�, A�o I, n. 10, pp. 5-38, riproposto in Id., Ensayos de Econom�a Pol�tica, Madrid, Uni�n Editorial, 1996, pp. 234-254.
� (1987b) Estudio Introductorio a Juan de Mariana, Tratado y discurso sobre la moneda de vell�n que al presente se labra en Castilla y de algunos des�rdenes y abusos, Madrid, edici�n del Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Econom�a y Hacienda, pp. 7-24, riprodotto con il titolo El Padre Juan de Mariana in Lucas Beltr�n Fl�rez, Ensayos de Econom�a Pol�tica cit., pp. 255-266.
� (1989) Historia de las Doctrinas Econ�micas, Barcelona, Editorial Teide.
Bosi, Roberto [a cura di], (1992-1997) Gli ordini religiosi. Storia e spiritualit� (4 voll.), Firenze, Nardini Editore {1992 (I vol.), 1995 (II vol.), 1997 (III e IV vol.)}.
Brett, Annabel S., (1997) Liberty, right and nature: Individual rights in later scholastic thought, Cambridge, Cambridge University Press.
Brufau Prats, Jaime, (1989) La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo, Salamanca, Editorial San Esteban.
Cardini, Antonio � Pulitini, Francesco [a cura di], (2000) Cattolicesimo e liberalismo, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Carpintero Ben�tez, Francisco, (2002) Los escol�sticos espa�oles en los inicios del liberalismo, in �La Ilustraci�n liberal. Revista espa�ola y americana�, Vol. IV, n. 12 (octubre), pp. 39-70.
Carro, Venancio D., (1951) La teolog�a y los te�logos juristas espa�oles ante la conquista de Am�rica, Salamanca, Editorial San Esteban.
Chafuen Rismondo, Alejandro Antonio, (1986) Christians for Freedom: Late Scholastic Economics, San Francisco, Ignatius Press, trad. it. Cristiani per la libert�. Radici cattoliche dell�economia di mercato, con una �Introduzione� di Dario Antiseri ed un �Prologo� di Michael Novak, Macerata, Liberilibri, 1999.
� (2003) Faith and Liberty: The Economic Thought of the Late Scholastics, Lexington, Lexington Books.
Clavero, Bartolom�, (1991) Antidora. Antropolog�a cat�lica de la econom�a moderna, Milano, Dott. A. Giuffr� Editore.
Costa, Giacomo, (1999) L�economia di mercato ha radici cattoliche?, in �Studi e note di economia�, n. 3, pp. 151-159.
Costa y Mart�nez, Joaqu�n, (1898) Colectivismo agrario en Espa�a; doctrinas y hechos, Madrid, Imprenta de San Francisco de Sales.
Costello, Frank Bartholomew, (1974) The Political Philosophy of Luis de Molina, Spokane, Gonzaga University Press.
Cubeddu, Raimondo, (2001) Diritti naturali e scelte collettive, in �Teoria�, anno XXI, n. 2, (Nuova serie XI/2), pp. 17-41.
Fava, Bruno, (1953) Le teorie dei monarcomachi e il pensiero politico di Juan de Mariana. (Contributo allo studio della teorica della resistenza nel sec. XVI), Reggio Emilia, Editrice Age.
Fern�ndez-Santamar�a, Jos� A., (1997) Juan de Mariana y el Constitucionalismo, in Id., La formaci�n de la sociedad y el or�gen del Estado. Ensayos sobre el pensamiento pol�tico espa�ol del siglo de oro, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
Ferraro, Domenico, (1989) Tradizione e ragione in Juan de Mariana, Milano, Franco Angeli
Finnis, John Mitchell, (1980) Natural Law and Natural Rights, Oxford, Oxford University Press [VII� edizione, 1992], trad. it. Legge naturale e diritti naturali, a cura di Francesco Viola, Torino, G. Giappichelli Editore, 1996.
� (1998) Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford, Oxford University Press.
� (2002) Aquinas on jus and Hart on Rights: A Response to Tierney, in �The Review of Politics�, Vol. 64, No. 3, Summer, pp. 407-410, trad. it. in ��lites�, anno VII, n. 2 (aprile-giugno 2003), pp. 19-21
Garc�a de Paso, Jos� I., (1999) La econom�a monetaria del Padre Juan de Mariana, in �Moneda y Cr�dito�, n. 209, pp. 13-44.
Grabmann, Martin, (1933) Die Geschichte der katholischen Theologie seit dem Ausgang der V�terzeit, Freiburg i. B., trad. esp. Historia de la Teolog�a Cat�lica, Madrid, Editorial Espasa Calpe, 1940.
Grice-Hutchinson, Marjorie, (1952) The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory, 1544-1605, Oxford, Clarendon Press.
� (1975) Early Economic Thought in Spain, 1177-1740, London, Allen & Unwin.
� (1989) The Concept of the School of Salamanca: Its Origins and Development, cap. 2 di Id., Economic Thought in Spain: Selected Essays of Marjorie Grice-Hutchinson, edited by Laurence S. Moss and Christopher K. Ryan, Aldershot, Edward Elgar, 1993.
Haydn, Hiram, (1950) The Counter-Renaissance, New York, Charles Scribner�s Sons, trad. it. Il Controrinascimento, Bologna, Societ� editrice il Mulino, 1967.
Hayek, Friedrich August von, (1952) The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason, Glencoe, The Free Press, trad. it. L�abuso della ragione. Studi sulla controrivoluzione della scienza, Roma, Edizioni SEAM, 1997.
� (1967) Studies in Philosophy, Politics and Economics, London, Routledge & Kegan Paul, trad. it. Studi di filosofia, politica ed economia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998.
� (1973) Liberalism, in Id., New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, London, Routledge & Kegan Paul, 1978, trad. it. Nuovi studi di filosofia, politica, economia e storia delle idee, Roma, Armando Editore, 1988.
Huerga, �lvaro, (1974) La Teolog�a en la Universidad de Alcal� (1508-1515), in Augustin Fliche � Victor Martin (dirs.), Histoire de l��glise depuis les origines jusqu�� nos jours (24 voll.), Paris, �ditions Bloud et Gay, 1941-1954, trad. esp. Historia de la Iglesia (33 voll.), Valencia, Edicep, 1974-1993, Vol. XVII: El Renacimiento.
Huerta de Soto, Jes�s, (1994) Estudios de Econom�a Pol�tica, Madrid, Uni�n Editorial.
� (1998) Dinero, cr�dito bancario y ciclos econ�micos, Madrid, Uni�n Editorial.
� (2001) La Escuela Austr�aca: mercado y creatividad empresarial, Madrid, Editorial S�ntesis, trad. it. La Scuola Austriaca. Mercato e creativit� imprenditoriale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.
� (2002) Nuevos estudios de Econom�a Pol�tica, Madrid, Uni�n Editorial.
Joannes Paulus PP. II {Wojtyla, Karol}, (1982) Discurso a los te�logos espa�oles en Salamanca (1 de noviembre de 1982), AAS 75 (1983), in Mensaje de Juan Pablo II a Espa�a, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
Laures, John, (1928) The Political Economy of Juan de Mariana, New York, Fordham University Press.
Lewy, Guenter, (1960) Constitutionalism and Statecraft during the Golden Age of Spain: a Study of the Political Philosophy of Juan De Mariana, S. J., G�n�ve, Droz
Maravall Casesnoves, Jos� Antonio, (1944) Teor�a del Estado en Espa�a en el siglo XVII, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
� (1972) La oposici�n pol�tica bajo los Austrias, Barcelona, Editorial Ariel.
� (1975) La cultura del Barroco, Barcelona, Editorial Ariel.
� (1982) Utopia y reformismo en la Espa�a de los Austrias, Madrid, Siglo XXI de Espa�a Editores.
Mariana, Juan de, (1599) De Rege et Regis institutione Libri III. Ad Philippum III. Hispaniae Regem Catholicum, Cum privilegio, Toleti, Apud Petrum Rodericum typo. Regium, trad. it. Il Re e la sua educazione, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996.
� (1609a) Tratado contra los juegos p�blicos, in Id., Obras del Padre Juan de Mariana (1854), 2 tomos, colecci�n Don Manuel Rivadeneira dispuesta y revisada, con un discurso preliminar, por Don Francisco Pi y Margall, Madrid, Biblioteca de Autores Espa�oles de la Real Academia Espa�ola, voll. XXX-XXXI, 1950, pp. 413-462.
� (1609b) De monetae mutatione, in Id., Tractatus Septem, Coloniae, Antonius Hierat, cap. IV, trad. esp. Tratado y discurso sobre la moneda de vell�n que al presente se labra en Castilla y de algunos des�rdenes y abusos, in Obras del Padre Juan de Mariana cit., pp. 577-593.
� (1609c) De morte et immortalitate, in Id., Tractatus Septem cit., cap. VII.
� (1625) Discursus de erroribus, qui in forma gubernationis Societatis Iesu occurrunt, trad esp. Discurso de las enfermedades de la Compa��a, Madrid, Imprenta de Don Gabriel Mellizo-Ram�rez, 1768.
Mart�nez de la Rosa, Francisco de Paula, (1836) Esp�ritu del siglo, Madrid, Biblioteca de Autores Espa�oles de la Real Academia Espa�ola, 1962.
Mateo del Peral, Diego Ignacio, (1977) El tratado �De monetae mutatione� del Padre Juan de Mariana, in Aa. Vv., Dinero y cr�dito, Madrid, Editorial Moneda y Cr�dito.
Menger, Carl, (1871) Grunds�tze der Volkswirtschaftslehre, Wien, Wilhelm Braum�ller, trad. it. Princip� fondamentali di economia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001.
Mises, Ludwig Edler von, (1922) Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen �ber den Sozialismus, Jena, Gustav Fischer, ediz. ingl. Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis, Liberty Fund, 1981, trad. it. Socialismo. Analisi economica e sociologica, Milano, Rusconi, 1989.
� (1927) Liberalismus, Jena, Gustav Fischer, trad. it. Liberalismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997.
� (1949) Human Action: A Treatise on Economics, The Scholar�s Edition, Auburn, Ludwig von Mises Institute, 1998.
Molina, Luis de, (1593-1609) De iustitia et iure tomi sex, Cuenca 1593 (tomo I); Cuenca 1597 (tomo II); Cuenca 1600 (tomo III); Venezia 1601 (tomo II); Venezia 1602 (tomo I); Magonza 1602 (tt. I e II); Magonza 1603 (t. III, pars prior); Anversa 1609 (t. III, pars posterior); Anversa 1609 (tt. IV, V e VI).
Negro Pav�n, Dalmacio, (1988) El Liberalismo en Espa�a. Una antolog�a, Madrid, Uni�n Editorial.
Nicoletti, Gioacchino, (1943) Mariana e il suo �de rege�, in Aa. Vv., Studi in memoria di Francesco Ferrara, Milano, Dott. A. Giuffr� Editore, pp. 575-612.
Noonan, John T., (1957) The Scholastic Analysis of Usury, Cambridge, Harvard University Press.
Novak, Michael, (1993a) The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, New York, The Free Press-Macmillan International, trad. it. L�etica cattolica e lo spirito del Capitalismo, Milano, Edizioni di Comunit�, 1994.
� (1993b) Two Moral Ideas for Business (The Hayek Memorial Lecture, 22 June 1992, London, England), in �Economic Affairs�, September-October.
Olgiati, Francesco, (1943) Il concetto di giuridicit� in San Tommaso d�Aquino, Milano, Societ� editrice Vita e Pensiero [IV� ristampa, 1955].
Ortega y Gasset, Jos� Mar�a, (1926) Notas del vago est�o, in Id., Obras completas (12 voll.), Madrid, Alianza Editorial-Ediciones �Revista de Occidente�, 1983, tomo II, pp. 413-449, V. Ideas de los castillos: liberalismo y democracia.
Pasa, Arturo, (1935) La dottrina di Giovanni Mariana intorno all�origine dello Stato, in �Sophia�, Annus III, Fasciculus n. 3-4, Luglio-Dicembre, pp. 440-462.
� (1939) Un grande teorico della Politica nella Spagna del Secolo XVI: il gesuita Giovanni Mariana, Napoli, Casa Editrice Rondinella Alfredo.
P�rez Lu�o, Antonio-Enrique, (1992) La pol�mica sobre el Nuevo Mundo. Los cl�sicos espa�oles de la Filosof�a del Derecho, Madrid, Editorial Trotta
Pi y Margall, Francisco, (1854) Discurso preliminar alle Obras del Padre Juan de Mariana (2 tomos), Madrid, Colecci�n Don Manuel Rivadeneira.
Popescu, Oreste, (1987) Estudios en la historia del pensamiento econ�mico latinoamericano, Buenos Aires, Plaza y Jan�s
Popper, Karl Raimund, (1992) La lezione di questo secolo. Intervista di Giancarlo Bosetti, Venezia, Marsilio Editori.
Prieto, Fernando, (1993) Historia de las Ideas y de las Formas Pol�ticas: III. Edad Moderna (1. Renacimiento y Barroco), Madrid, Uni�n Editorial.
Pufendorf, Samuel von, (1672) De jure naturae ac gentium libri octo, New York, Oceana, 1934.
Roover, Raymond de, (1955) Scholastic Economics: Survival and Lasting Influence from the Sixteenth Century to Adam Smith, in �Quarterly Journal of Economics�, No. 69, May, pp. 161-190.
� (1958) The Concept of the Just Price: Theory and Economic policy, in �Journal of Economic History�, No. 18, December, pp. 418-434.
� (1971) La pens�e �conomique des scolastiques. Doctrines et m�thodes, Montr�al-Paris, Institute d��tudes M�di�vales-Librairie J. Vrin.
Rothbard, Murray Newton, (1976) New Light on the Prehistory of the Austrian School, in Id., The Logic of Action (2 voll.), Vol. I, Method, Money, and the Austrian School, pp. 173-194, Glos, Edward Elgar, 1997.
� (1995) Economic Thought before Adam Smith, Vol. I di Id., An Austrian Perspective on the History of Economic Thought (2 voll.), Cheltenham, Edward Elgar.
S�iz Est�variz, Cipriano, (1955) Doctrinas econ�micas del P. Juan de Mariana, SJ. Sus ideas sobre una pol�tica agraria y ganadera, in �Bolet�n de Estudios Economicos�, X (35), mayo, pp. 37-44.
Salmon, John Hearsey McMillan, (1991) Catholic resistance theory: ultramontanism, and the royalist response, 1580-1620, cap. 8 di The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700, Edited by James Henderson Burns, with the assistance of Mark Goldie, Cambridge, Cambridge University Press.
S�nchez Agesta, Luis, (1981) El Padre Juan de Mariana, un humanista precursor del constitucionalismo, studio preliminare a Juan de Mariana, La dignidad real y la educaci�n del Rey, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
Schumpeter, Joseph Alois, (1954) History of Economic Analysis, New York, Oxford University Press.
Su�rez, Francisco, (1612) Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem libros distributus, Conimbricae.
Termes, Rafael, (1991) Presentaci�n a Alejandro A. Chafuen, Econom�a y �tica. Ra�ces cristianas de la econom�a de libre mercado, Madrid, Ediciones Rialp, pp. 9-15.
Tierney, Brian, (1986) Hierarchy, Consent, and the �Western Tradition�, in �Political Theory�, Vol. 15, No. 4, November, pp. 646-652.
� (1997) The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law, 1150-1625, Atlanta, Scholars Press, trad. it. L�idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico: 1150-1625, Bologna, Societ� editrice il Mulino, 2002.
� (2002) Natural Law and Natural Rights: Old Problems and Recent Approaches, in �The Review of Politics�, Vol. 64, No. 3, Summer, pp. 389-406; e Id., Author�s Rejoinder, pp. 416-420, trad. it. Legge naturale e diritti naturali: vecchi problemi e nuovi approcci, in ��lites�, anno VII, n. 2 (aprile-giugno 2003), pp. 9-19 e 24-30.
Todeschini, Giacomo, (2002) I mercanti e il tempio. La societ� cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra medioevo ed et� moderna, Bologna, Societ� editrice il Mulino.
Tosato, Angelo, (1994) Economia di mercato e cristianesimo, Roma, Edizioni Borla.
Tuck, Richard, (1979) Natural Rights Theories. Their Origin and Development, Cambridge, Cambridge University Press.
Villey, Michel, (1975) La formation de la pense� juridique moderne, Paris, �ditions Montchrestien, trad. it. La formazione del pensiero giuridico moderno, Milano, Jaca Book, 1986.
[1] Conviene circostanziare come le riflessioni di Ortega s�incentrassero su quella che, a suo modo di vedere, si configurava quale un�esecrabile confusione odierna fra i due ben distinti concetti di �liberalismo� e �democrazia�. In alcuni celebri paragrafi, il madrile�o poneva in evidenza come, per contro, tali �tendenze� non soltanto risultassero originariamente differenti l�una dall�altra ma, addirittura, fossero da considerarsi �di significato antagonista�. Esse, infatti, atterrebbero a due questioni di diritto pubblico assolutamente diverse: la democrazia si occuperebbe del problema di chi debba esercitare il potere politico, ravvisando la soluzione pi� adeguata nella �collettivit� dei cittadini�; il liberalismo, invece, si preoccuperebbe di individuare quali siano i limiti invalicabili da apporre a tale potere, indipendentemente da chi si trovi ad esercitarlo: cfr. Ortega y Gasset (1926: 425).
[2] Si tenga presente come alcuni scolastici si mostrassero inclini ad individuare proprio in tale passo del Genesi (1, 26) il fondamento ultimo del dominium; cfr. ad esempio Molina (1593-1609: Tract. II, disp. 18, coll. 83-84). Sulla filosofia politica di Molina si veda, in particolare, lo studio di Costello (1974).
[3] Cfr. Negro Pav�n (1988: 12).
[4] Cfr. Maravall Casesnoves (1944), (1972), (1975) e (1982).
[5] Per una trattazione delle tematiche relative a �legge naturale�/�diritti naturali�, �diritto di natura�/�diritto naturale�, etc. si rinvia agli studi di Villey (1975), Tuck (1979), Finnis (1980), Brett (1997), Tierney (1986), (1997) e (2002), nonch� Cubeddu (2001). In particolare, negli scritti di Villey e Tierney si fronteggiano due tesi contrapposte. Il primo, infatti, ha individuato una stretta interconnessione fra il volontarismo teologico e quello giuridico. Per contro, il secondo � stato indotto a collocare l�origine dei diritti soggettivi all�interno della riflessione sviluppata dai canonisti di epoca medioevale, enfatizzando il nesso che unirebbe al �diritto naturale� la dottrina dei �diritti individuali�, interpretata come il �prodotto caratteristico� di quella �giurisprudenza creativa�, la quale avrebbe posto, nel corso dei secoli XII e XIII, le fondamenta della �tradizione giuridica occidentale�.
[6] Cfr. Huerta de Soto (2002: 157).
[7] Le discusse e controverse interconnessioni tra fede e morale cattolica, da un lato, ed economia di mercato e organizzazione politica di stampo liberale della societ�, dall�altro, sono state dibattute in un incontro sul tema, svoltosi alla Certosa di Pontignano, presso l�Universit� degli Studi di Siena, il 16 e 17 ottobre del 1998; gli atti di tale convegno sono stati pubblicati nel volume collettaneo a cura di Cardini e Pulitini (2000). Un�analisi di tali questioni da una prospettiva di storia del pensiero giuridico � disponibile nello studio di Clavero (1991). Sulle medesime tematiche si vedano, inoltre, i contributi di Tosato (1994) ed Antiseri (1995).
[8] La suddetta tesi interpretativa � che in ambiente libertarian � divenuta, ormai, canonica � si colloca nel solco tracciato da una cospicua parte della tradizione liberale classica dell�Otto e Novecento che, da Lord John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834-1902), giunge sino a Friedrich August von Hayek (1899-1992); essa sembrerebbe concorde nel considerare san Tommaso, appunto, come �il primo liberale�: cfr. per tutti Novak (1993a: 45, trad. it.).
[9] Secondo quanto sostenuto dal liberale granadino Francisco de Paula Mart�nez de la Rosa (1787-1862), il decreto napoleonico apparso sulla �Gaceta extraordinaria de Madrid� l�11 dicembre del 1808 avrebbe rappresentato, assai probabilmente, la prima volta che si us� in Spagna l�aggettivo liberal (in riferimento alla �Constituci�n de Bayona�) con l�accezione che ha poi assunto in seguito: cfr. Mart�nez de la Rosa (1836: CLIII [V] I, IX, cap. XXVI, VII). Del resto, anche l�applicazione della voce �liberale� a gruppi di individui politicamente organizzati, avrebbe avuto un�origine spagnola, iniziando ad essere usata a Cadice nel 1811 dal movimento che l�anno seguente si costitu� come il partito dei liberales: cfr. Hayek (1973: 136, trad. it.) e Negro Pav�n (1988: 12, nota 4). Si rammenter�, d�altra parte, il differente impiego gi� fattone da Edmund Burke (1729-1797), il quale, nelle sue celebri Reflections on the Revolution in France, pubblicate a Londra nel 1790, trattando dei primi rivoluzionari di quel paese, asseriva che �their liberty is not liberal�: cfr. Negro Pav�n (1988: 218, nota).
[10] Cfr. Negro Pav�n (1988: 23).
[11] �[E]am demum tutam esse potentiam, quae viribus modum imponit�: Mariana (1599: 95).
[12] In proposito, avrebbe commentato il sacerdote catalano Jaume Luciano Balmes Urpi� (1810-1848), annoverato come uno fra i pi� significativi esponenti del cattolicesimo liberale vissuti nella penisola iberica durante il XIX secolo: �Che penseremo di Mariana? La risposta non � difficile; vi sono epoche di vertigine che frastornano le menti e quella lo era [�]. � deprecabile, di certo, che Mariana non abbia trattato la questione con maggior senno e che abbia tratto conseguenze tanto formidabili dai suoi princip� sul potere; senza la dottrina del tirannicidio il suo libro sarebbe stato in verit� molto democratico�; cfr. Balmes Urpi� (1842: 53).
[13] Di seguito, nel presente lavoro, per le citazioni in italiano dei passi dal De Rege riportati fra virgolette ci si � avvalsi dell�unica traduzione finora disponibile, a cura di Natascia Villani, con alcune modifiche od integrazioni effettuate � senza darne ogni volta menzione � sulla base del testo originale in latino, tratto dall�editio princeps del 1599 (di cui esiste una riproduzione anastatica pubblicata ad Aalen, Scientia Verlag, 1969); i rimandi puntuali alle pagine sono, invece, riferiti alla medesima edizione latina. Tutte le altre citazioni in italiano di opere di Mariana o di altri autori stranieri sono tradotte da chi scrive.
[14] Su cui si veda Salmon (1991).
[15] Secondo alcuni interpreti, addirittura, l�unico a cui possa correttamente applicarsi tale qualificazione in �mbito cattolico; cfr. Fava (1953: 67). Sulla figura di Mariana si possono consultare gli studi di Pasa (1935) e (1939), nonch� il contributo di Nicoletti (1943).
[16] Alcuni esempi sono costituiti dagli scritti di Costa y Mart�nez (1898), Fern�ndez-Santamar�a (1997), Lewy (1960), Pi y Margall (1854) e S�nchez Agesta (1981).
[17] Cfr. Hayek (1967: 286, trad. it.).
[18] � pur sempre doveroso, del resto, non perdere di vista come, anche in assenza di ricerche autonome, Hayek considerasse attendibili ed estremamente importanti quelle svolte da altri studiosi in tale direzione. Al riguardo si rivela una testimonianza di notevole interesse la lettera inedita, datata 20 gennaio 1979, spedita a Huerta de Soto, in cui il futuro premio Nobel sosteneva che in tali studi si dimostrava come �i princip� basilari della teoria del mercato concorrenziale {competitive market} vennero elaborati dagli scolastici spagnoli del 16� secolo e che il liberalismo economico non fu disegnato dai calvinisti, ma dai gesuiti spagnoli�: cfr. Huerta de Soto (2002: 250, nota 4).
[19] Mises (1927: 93, trad. it.).
[20] Ibidem.
[21] Ibidem.
[22] Mises (1922: 453, trad. it.).
[23] Mises (1922: 454, trad. it.).
[24] Mises (1927: 93, trad. it., corsivo mio).
[25] Cfr. Mises (1949: Part Six, chap. XXVII, � 3, pp. 715-719).
[26] A giudicare dagli inequivocabili segni di un influsso del pensiero hayekiano sull�Enciclica papale Centesimus annus (01/05/1991) � dovuti, come noto, all�estesa conversazione che l�economista austriaco intrattenne con il Santo Padre poco prima di morire, per cui si veda Novak (1993b: 7) � sembrerebbe vero, piuttosto, il contrario.
[27] Gli stessi richiami che Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) fece ai dottori scolastici nella sua Storia dell�analisi economica, infatti, non erano comunque diretti a sostenere una qualche loro continuit� ideale con la Scuola austriaca in particolare: cfr. Schumpeter (1954: 100 ss.). D�altra parte, anche un critico quale Giacomo Costa, dopo aver giudicato con scetticismo larga parte delle ricerche effettuate in tale direzione, tuttavia, non sembra avere dubbi all�asserire che �[l]a Scuola Economica Austriaca ha dato un fondamentale contributo alla conoscenza e all�apprezzamento della Tardoscolastica, di cui pu� essere considerata, in qualche misura, la continuatrice e l�erede. I membri della Scuola Austriaca erano laici, e per di pi� certamente non tutti cattolici di nascita. Tuttavia cattolicizzante la loro Scuola lo �, e non solo per la sorridente condiscendenza con cui Schumpeter, o Mises, o Hayek, considerano le posizioni del positivismo e del laicismo tardo-ottocentesco. Non sorprendentemente per dei membri dell��lite intellettuale di un impero multinazionale ormai vicino alla disgregazione, apprezzano profondamente l�universalismo e il razionalismo della tradizione ecclesiastica medievale�: Costa (1999: 158, corsivo mio).
[28] La citazione fatta da Menger del trattato intitolato Veterum collatio numismatum, che Diego de Covarrubias y Leyva (colui che avrebbe enunciato per primo la teoria soggettiva del valore) aveva scritto nel 1560 sul maraved� castigliano, � contenuta nei Princip� fondamentali di economia, dove si legge che �[l]a letteratura straordinariamente ricca che hanno prodotto il medioevo e il sedicesimo secolo in materia di monete e di misure [�] <consta di> molte notevoli pubblicazioni [�]. Esse si occupano per lo pi� di questioni pratiche della moneta, in particolare della questione, divenuta importante per i numerosi abusi delle pubbliche amministrazioni, dell�essenza e dei limiti del diritto dei pr�ncipi di alterare le monete, e delle conseguenze giuridico-patrimoniali di tali alterazioni. Alcune prendono spunto da ci� per trattare anche la questione dell�origine del denaro, e si liberano del problema sulla base delle ricerche dell�antichit�, richiamandosi sempre ad Aristotele. Cos� [�] Didacus Couarouvia, Veter. numm. collat. (intorno al 1560), edit. Bud., p. 468�: Menger (1871: 343-344, nota 79, trad. it.).
[29] Cfr. Grabmann (1933: 181-182, trad. esp.).
[30] Cfr. Prieto (1993: 277).
[31] Sul differente Tomismo professato dai gesuiti, invece, si veda lo studio di Beltr�n de Heredia (1915).
[32] Su tale movimento dottrinale si vedano gli studi di Belda Plans (1984) e (2000). Lo stesso Giovanni Paolo II esprimeva parole di apprezzamento verso l�operato dei salmantini, durante un discorso ai teologi spagnoli, tenuto nel 1982: �Per incontrarmi con voialtri ho scelto questa celebre e suggestiva citt� di Salamanca, che con la sua antica Universit� fu centro e simbolo del periodo aureo della teologia in Spagna, e che da qui irradi� la sua luce nel Concilio di Trento, contribuendo poderosamente al rinnovamento di tutta la Teologia Cattolica [�]. In quei tempi tanto difficili per la cristianit�, questi grandi teologi si distinsero per la loro fedelt� e creativit�. Fedelt� alla Chiesa di Cristo e compromesso radicale per la sua unit� sotto il primato del Romano Pontefice. Creativit� nel metodo e nella problematica. Insieme con il ritorno alle fonti � la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione �, realizzarono l�apertura alla nuova cultura che stava nascendo in Europa. La dignit� inviolabile di ogni uomo e la dimensione etica come normativa delle nuove strutture socioeconomiche entrarono pienamente nel compito della teologia e ricevettero da essa la luce della Rivelazione cristiana. Per questo, nei tempi nuovi e difficili che stiamo vivendo, i teologi di quell�epoca continuano ad essere vostri maestri, nell�intento di raggiungere un rinnovamento tanto creativo quanto fedele, che risponda alle direttive del Vaticano II, alle esigenze della cultura moderna e ai problemi pi� profondi dell�attuale umanit��: Joannes Paulus II (1982: 259-260).
[33] Su questo argomento si rimanda agli studi di Carro (1951), Brufau Prats (1989) e P�rez Lu�o (1992).
[34] Cfr. Carpintero Ben�tez (2002: 40). Sulla fortuna del Tomismo in Spagna prima dell�opera del Vitoria, si consulti Belda Plans (2000: 63-73).
[35] Cfr. Artola (2002: 5).
[36] Cfr. Carpintero Ben�tez (2002: 41).
[37] Se non altro perch�, come detto, la Compa��a de Jes�s non venne fondata prima del 1534 e ricevette ufficiale approvazione da Paolo III con la bolla papale Regimini militantis Ecclesiae soltanto nel 1540: cfr. Bosi (1992-1997: I, 118-119).
[38] Cfr. Carpintero Ben�tez (2002: 41).
[39] Fra di essi sono da segnalarsi il gesuita Juan de Medina (1490-1546) ed il francescano Alfonso de Castro (1495-1558). Inoltre, spiccano i nomi del domenicano Bartolom� de Medina (1497-1585) e del Doctor Navarrus, al secolo Mart�n de Azpilcueta y Jaureguizar (1493-1586). Occorre, d�altronde, rammentare anche i domenicani Tom�s de Mercado (ca. 1500-1575) e Melchor Cano (1509-1560); Fernando V�zquez de Menchaca (1509-1566) e il gi� citato Diego de Covarrubias y Leyva (1512-1577), detto el B�rtolo espa�ol; figure di prim�ordine fra gli scolastici dell�epoca furono, poi, il gesuita Juan de Matienzo (1520-1579), il domenicano Domingo de B��ez (ca. 1528-1604), il vescovo agostiniano Miguel B. Sal�n (1538-1620), i gesuiti Juan de Salas (1553-1612), Gregorio de Valencia (1549-1603), Pedro de O�ate (1567-1646), il cardinale Juan de Lugo (1583-1660), nonch� Antonio Escobar y Mendoza (1589-1669). Bisogna, infine, almeno menzionare Luis Saravia de la Calle e Francisco Garc�a, che svilupp� la teoria economica del valore dei beni basata sull�utilit� soggettiva nel suo Tratado util�simo, pubblicato a Valencia nel 1583.
[40] Parlare di �proto-liberalismo� in riferimento agli esponenti del movimento che teorizz� e mise in atto la Controriforma pu� apparire eccessivo, secondo i luoghi comuni che hanno tramandato una leyenda negra in base alla quale la Spagna cattolica viene spesso dipinta come il regno incontrastato dell�assolutismo monarchico sostenuto da un�Inquisizione intollerante e persecutoria. Non s�intende, in questa sede, discutere l�attendibilit� di tali interpretazioni. Poich�, tuttavia, del Tribunale della Santa Inquisizione fecero parte anche figure di primo piano nel processo controriformatore messo in atto dalla Chiesa romana nella seconda met� del Cinquecento, come il cardinale gesuita Roberto Bellarmino (1542-1621) � peraltro discepolo di Mariana negli anni in cui questi insegn� presso il Collegio Romano � giova riportare un episodio significativo. Racconta Balmes che, durante un sermone pronunciato di fronte all�allora regnante Filippo II, un predicatore dichiar�, lasciandosi trasportare da spirito di piaggeria e servilismo, che �i re hanno un potere assoluto sulla persona e sulla roba dei loro vassalli�. L�Inquisizione intervenne prontamente, senza alcun ostruzionismo da parte del potente sovrano, istruendo un processo in cui condann� il religioso eccessivamente zelante a ritrattare quanto detto, imponendogli inoltre di leggere pubblicamente una formula che recitava come �non hanno i re sui loro vassalli pi� potere di quello che loro si permette dal diritto Divino ed umano e non gi� di loro libera e assoluta volont��: cfr. Balmes urpi� (1842-1844: II, 368-369, trad. it.).
[41] Cfr. Bastit (1990: 314).
[42] Cfr. Carpintero Ben�tez (2002: 44).
[43] Cfr. Belda Plans (2000: 22). Le divisioni suaccennate sono da riconnettersi con le diverse scuole teologiche nelle quali era articolato il panorama scolastico del tempo, su cui si veda lo stesso Belda Plans (2000: 13-14).
[44] Cfr. Prieto (1993: 279).
[45] �In realt�, riteniamo che si debba preferire il comando di uno solo {unius principatum} se raduna in consiglio i migliori cittadini {optimos cives} e, una volta convocato il senato, amministri gli affari pubblici e privati {respublicas & privatas} basandosi sulla opinione di questo; in tal modo si preverr� ogni abuso {imprudentiae} ed eccesso personale {privatis affectibus}. Cos� quando il potere regio {regia maiestate} sar� congiunto con quello degli ottimati {optimates}, che gli antichi chiamavano aristocrazia {Aristocratiam}, e la citt� o la nazione avranno il loro giusto cammino, si giunger� all�agognato porto della felicit� {sic civitate universa aut provincia cursum tenente, optatum felicitatis portum occupabit}�: Mariana (1599: 33-34).
[46] Cfr. Prieto (1993: 279).
[47] Cfr. Prieto (1993: 279-280).
[48] Egli si form�, infatti, presso l�Universit� di Alcal� de Henares (nella provincia di Madrid) e poi, dopo aver viaggiato per Italia e Francia, si ristabil� in Spagna, nella citt� di Toledo, nei pressi della quale era nato e cresciuto. Proprio per tale ragione, probabilmente, Diego Mateo del Peral lo collocava a capo di una �Scuola di Toledo�, tacciata di �anticonformismo intellettuale e politico�, dai contorni invero un po� fumosi.
[49] Cfr. Belda Plans (2000: 63).
[50] Ibidem.
[51] Cfr. Huerga (1974: 585-616).
[52] Cfr. Belda Plans (2000: 76-77).
[53] Cfr. Belda Plans (2000: 141).
[54] Su tale questione, si vedano Alejo Montes (1990) ed �lvarez de Morales (1991).
[55] Cfr. Belda Plans (2000: 178).
[56] Cfr. Belda Plans (2000: 141).
[57] La Biblia Pol�glota Complutense, la cui realizzazione fu voluta e coordinata personalmente da Cisneros, rappresent� il frutto di una moderna concezione degli studi biblici, ispirata alle rivendicazioni umaniste, testimoniando lo sforzo dell�ateneo madrile�o volto all�innovazione teologica. Si tratt� di un vero e proprio lavoro di gruppo al quale parteciparono, fra gli altri umanisti, anche Erasmo da Rotterdam (1466-1536) ed, in qualit� di latinista, Elio Antonio de Nebrija (1442-1522). L�opera prosegu� a ritmo serrato per una quindicina di anni, dal 1502 al 1517 (l�ultimo volume venne infatti stampato il 10 luglio del 1517), precedendo le innovazioni dovute all�influsso luterano ed affiancando, per contro, l�opera gi� intrapresa da Erasmo: cfr. Belda Plans (2000: 102). Sull�esegesi biblica nel XVI secolo si consultino gli studi di Andr�s Mart�n (1976-1977: II, 63 ss. e 629 ss.) e quelli di Avil�s Fern�ndez (1987: 75-160).
[58] Loyola � pur risiedendo a Roma � era venuto a conoscenza della fama di cui godeva il Mariana a causa della sua precocit� intellettuale e, pertanto, apprese con enorme soddisfazione la notizia della sua affiliazione, inviandogli la propria benedizione.
[59] �[Q]uam a subditis obedientiam exigit, legibus ipse exhibeat�: Mariana (1599: 103).
[60] �[�] Atque ijs legibus non modo obedire Princeps debet, sed neque eas mutare licebit, nisi universitatis consensu certaque sententia: quales sunt leges de successione inter Principes, de vectigalibus, de religionis forma�: Mariana (1599: 102, corsivi miei).
[61] Cfr. Mariana (1599: 387-406).
[62] Cfr. Mariana (1599: 389).
[63] �Sic cives congregari in unum, in conventus & collegia coire vetat, & omnino de republica loqui per inquisitiones occultas adempta loquendi libere, audiendique facultate, quod supremum in servitute est ne gemitum quidem in tantis malis liberum esse permittit�: Mariana (1599: 64).
[64] Cfr. Mariana (1599: 99).
[65] Come � spesso chiamato Mariana dal suo luogo di nascita, la cittadina Talavera de la Reina in provincia di Toledo.
[66] Cfr. Mariana (1599: 107).
[67] Cfr. Mariana (1599: 103).
[68] �[N]eque ita amentes sumus, ut Reges in fastigio collocatos de gradu deijcere, in turbamque mittere conemur. Non ea nostra mens est legibus omnibus sine discrimine Principem esse subiectum, sed quae sine maiestatis sugillatione serventur, neque functionem Principis impediant�: Mariana (1599: 105).
[69] Cfr. Mariana (1599: 105-106).
[70] Mariana (1599: 106-107).
[71] �[N]on si impongono tributi, n� si fanno nuove leggi, senza il consenso del popolo {sed populis tamen volentibus tributa nova imperantur, leges constituuntur}; e ci� che ancor pi� significativo occorre il giuramento del popolo perch� al successore siano confermati i suoi diritti al potere supremo, nonostante l�abbia ricevuto per successione ereditaria {& quod est amplius, populi sacramento, iura imperandi quamvis haereditaria successori confirmantur}�: Mariana (1599: 73).
[72] �Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari�: Su�rez (1612: Lib. V, cap. 15, � 2).
[73] Cfr. Mariana (1599: 23).
[74] Cfr. Mariana (1599: 103).
[75] Da questa prospettiva pu� risultare interessante notare, en passant, come con il moderno concetto di sovranit� sia stata sovvertita tutta la precedente struttura di diritto tradizionale, fondato sulla �natura� (cosa dalla quale sarebbe derivata, fra l�altro, la stessa teoria cesaropapista). � da segnalarsi come, di conseguenza, contrariamente a quanto comunemente accettato, sia possibile ricavare che gli elementi garanti di tolleranza e libert� politica non abbiano coinciso con le funzioni storiche svolte dalla borghesia e dal laicismo illuminista, bens� con quelle dell�aristocrazia e della Chiesa cattolica: cfr. Negro Pav�n (1988: 15-17).
[76] Mariana (1599: 58).
[77] �Credo [�] che si debba concedere ai sudditi {provincialibus}, e persino comandare, qualora questi si rifiutassero, di mantenere ciascuno armi e cavalli in base al loro censo e alla loro rendita {unumquemque pro censu & re familiari equos & arma habere}�: Mariana (1599: 304).
[78] Mariana (1599: 310).
[79] Cfr. Mariana (1599: 306).
[80] Occorre ricordare che sulle analisi di politica monetaria effettuate da Mariana, negli anni sessanta del Novecento svolse alcune ricerche Jaime Lluis y Navas Brusi. Sull�introduzione del concetto dinamico della competizione da parte degli scolastici spagnoli, si vedano le osservazioni fatte da Popescu (1987: 141-159), nonch� gli studi sulla politica economica e monetaria di Mariana svolti, fra gli altri, da Laures (1928), S�iz Est�variz (1955) e Garc�a de Paso (1999).
[81] Cfr. Grice-Hutchinson (1952), (1975) e (1989). Alla Scuola di Salamanca e, in particolare, agli studi della Grice-Hutchinson sono state dedicate ampie sezioni della rivista spagnola e latinoamericana �La Ilustraci�n liberal� nel n. 11 (Junio 2002), n. 12 (Octubre 2002) e n. 16 (Agosto 2003).
[82] Cfr. Roover (1955) e (1971).
[83] L�intreccio che ha unito teologia morale ed economia produttiva, cos� come etica della carit� e logica degli scambi commerciali, dando origine a quelle categorie concettuali che hanno reso possibile elaborare la �razionalit�� economica nell�Occidente cristiano fin dall�epoca medioevale, � stato recentemente approfondito da Todeschini (2002).
[84] Cfr. Rothbard (1976) e (1995: I, 97-133 e 135-175).
[85] Cfr. Beltr�n Fl�rez (1987a).
[86] Cfr. Huerta de Soto (2002: 249-261, in particolare pp. 257-258).
[87] Cfr. Termes (1991: 11).
[88] Cfr. Huerta de Soto (2002: 73-99).
[89] Cfr. Huerta de Soto (1998: 23-34, 66-80 e 468-490).
[90] Cfr. Huerta de Soto (2002: 259).
[91] Mariana (1625: 151-155 e 216).
[92] Cfr. Huerta de Soto (2001: 59) [trad. it. pp. 73-74].
[93] Huerta de Soto (2002: 260).
[94] In proposito, si tenga presente l�osservazione del Costa che, in merito alla tesi secondo cui gli scolastici sarebbero stati fra i precursori di quegli economisti che �scoprirono� la teoria soggettiva del valore, commenta: �Precursori e non di pi�, penserei, perch� [�] � difficile trovare traccia dell�importanza delle valutazioni marginali dei beni <nei loro scritti pi� citati>�; cfr. Costa (1999: 154).
[95] Cfr. Balmes urpi� (1844). Su questo punto, si confronti anche quanto riportato in Beltr�n Fl�rez (1989: 230-236), nonch� in Huerta de Soto (1994: 22, nota 8) e (2002: 261 e 361, nota 91).
[96] Cfr. Huerta de Soto (2002: 407).
[97] Su cui, peraltro, si vedano anche gli studi compiuti da Noonan (1957), nonch� quelli svolti da Barrientos Garc�a (1984) e (1985).
[98] Chafuen Rismondo (1986). Secondo il giudizio espresso da Juan Belda Plans, fatto salvo l�indubbio interesse di quest�opera dal punto di vista della Storia del pensiero economico, essa presenti, tuttavia, deficienze in tema di conoscenza del contesto storico-teologico dell�epoca; �per citare solo qualche esempio: <a p. 9 della trad. it.> fa domenicano Mart�n de Azpilcueta, e francescano Juan de Medina (?)�. Cfr. Belda Plans (2000: 51, nota 125).
[99] Chafuen Rismondo (2003).
[100] �[S]i pu� dimostrare che il potere reale non � da preferire a quello democratico o, per lo meno, che in quel tempo non si adattava sufficientemente alle usanze di quel popolo. Questo accade in ogni cosa, dal vestiario, all�abitazione, alle scarpe, che per quanto sono belle ed eleganti non � detto che piacciano a tutti; e ritengo che possa accadere lo stesso nelle forme di Stato, in quanto non perch� una supera tutte le altre significa che debba essere accettata da popoli di usanze ed istituzioni diverse {idem in reipublicae forma contingere arbitror, ut quae praestantissima sit, eam non omnium populorum mores & instituta recipiant}�: Mariana (1599: 31).
[101] Su tale scritto si consultino gli studi di Mateo del Peral (1977) e Beltr�n Fl�rez (1987b).
[102] Cfr. Mariana (1609b: 580).
[103] Ibidem.
[104] Ibidem.
[105] Cfr. Mariana (1609b: 586-587).
[106] Cfr. Mariana (1609b: 586-588).
[107] �Tutte le tue stime si faranno in sicli del santuario; il siclo � di venti ghera�: Lv, 27, 25.
[108] Con tale espressione, derivata dalla voce di origine ebraica sheqel, s�individuavano sia un�antica unit� di misura del peso (ca. 15 g), in uso presso Babilonesi ed Ebrei, sia una moneta d�argento ebraica.
[109] Cfr. Aquino (1266: Lib. 11, cap. 14).
[110] Cfr. Chafuen Rismondo (1986: 74-76, trad. it.).
[111] Cfr. Mariana (1609b: 588, il corsivo si trova nel testo originale).
[112] Cfr. Pufendorf (1672: 694).
[113] Cfr. Chafuen Rismondo (1986: 36-37, trad. it.).
[114] Cfr. Mariana (1609b: 579).
[115] �Certe tributis imperandis, abrogandisve legibus, ac praesertim quae de successione in regno sunt, mutandis, resistente multitudine impar unius Principis auctoritas sit, & si quae alia gentis moribus universitati reservata haudquaquam Principis in arbitrio posita sunt�: Mariana (1599: 92).
[116] Cfr. Mariana (1599: 301-311).
[117] �[�] comune opinione fra i giuristi [�] che i re senza il consenso del popolo non possono fare alcuna cosa che lo danneggi, vale a dire, espropriargli tutti i suoi averi o parte di essi. [�] se il re non � il padrone dei beni particolari, non li potr� prendere tutti n� in parte se non con il consenso dei proprietari�: Mariana (1609b: 578-579).
[118] Mariana (1609b: 579).
[119] Cfr. Mariana (1599: 321-330).
[120] Mariana (1599: 323).
[121] Mariana (1599: 58-59).
[122] �Pertanto la nostra principale e maggiore preoccupazione deve essere, come abbiamo detto poco fa, di proporzionare le spese alle ricchezze e potenzialit� dei singoli e che i tributi si relazionino alla necessit� delle spese {ut sumptius singuli facultati & copiae sint exaequati, ratio vectigalium & erogandi necessitas inter se congruant}, affinch� lo Stato non si trovi coinvolto in mali maggiori, se eccede la misura�: Mariana (1599: 323).
[123] Mariana (1599: 59-60).
[124] �Il re dovr�, quindi, cacciare dalla reggia gli adulatori, perniciosa razza {genus hominum pestilentissimum}, i quali, spiando astutamente i gusti del principe, lodano sempre ci� che dovrebbero biasimare, e riprendono ci� che, al contrario, � lodevole, volgendosi rapidamente l� dove vedono volgersi e inclinare il capriccio del sovrano; arte infame {pessima ars} questa, che ha preso uno sviluppo smisurato per il successo da molti ottenuto�: Mariana (1599: 60).
[125] �Per questo il principe cercher� prima di tutto che, eliminate tutte le spese superflue, siano regolati i tributi {ut supervacaneis sumptibus detractis, modus vectigalibus sit}; egli deve comportarsi come farebbero gli uomini sobri {frugales homines}, che pensano con attenzione a conservare il loro patrimonio, affinch� le spese pubbliche {expesae publicae}, se non minori, almeno non siano maggiori delle entrate reali {regio censu}; altrimenti sarebbe costretto a chiedere un prestito {versuram}, e a consumare le risorse dell�impero {opes imperij} nel pagare interessi {fenore} che crescono di giorno in giorno [�]. Se le spese regie saranno a lungo molto maggiori delle entrate {vectigalibus}, il male che ne deriver� sar� inevitabile: per la necessit� di imporre ogni giorno nuovi tributi, si renderanno sordi i cittadini e si esaspereranno gli animi {nova indies tributa imperandi necessitate, obsurdescent aures provincialium, axacerbabuntur animi}�: Mariana (1599: 322-323).
[126] Al tempo, cio�, in cui governava ancora il re Alfonso V (1416-1458).
[127] Trentaquattro maraved�s componevano un real che, a sua volta, rappresentava la sessantasettesima parte di un marco d�argento (otto once). Cuento significava �un milione�.
[128] Cfr. Mariana (1609b: 591).
[129] Cfr. Mariana (1609b: 592).
[130] �Molto servir� che i tributi reali {regia vectigalia}, da qualunque luogo provengano, siano curati con attenzione affinch� non diminuiscano per la malvagit� di alcuni uomini che conoscono tutti i mezzi per fare denaro e che non si astengono da ogni tipo di inganno per ottenerlo, siano questi pubblicani o coloro ai quali � affidata la riscossione delle imposte regie {sive publicani ij sint, sive quibus cura regiorum vectigalium credita est}. Questa � la peste pi� terribile che si possa immaginare {qua peste vix ulla magis tetra excogitari potest}. [�] Si dovrebbe esigere che essi rendano esattamente conto delle proprie ricchezze, sottraendo loro quelle di cui non possono dare una chiara giustificazione�: Mariana (1599: 323-324).
[131] �Consideri come cosa dannosa, da evitare ad ogni costo, di vendere dietro pagamento i tributi annuali, aggiudicandoli a ricchi capitalisti {Vendere etiam pretio annua vectigalia, copiosisque hominibus addicere noxium est}�: Mariana (1599: 322).
[132] Mariana (1599: 322-323).
[133] �Si possono imporre modici tributi {modico vectigali imposito vendantur} su quei beni di prima necessit� {merces quibus ad vitam sustentandam populus opus habet}, come il vino, il grano, la carne, i vestiti di lana e di lino, specialmente su quelli non troppo eleganti�: Mariana (1599: 327).
[134] �[Q]uanto � stato sottratto da questi beni venga caricato sulle merci ricercate {quod ex ijs rebus detractum fuerit, ex curiosis mercibus suppleatur}, come gli aromi � di cui la Spagna � sprovvista � lo zucchero, la seta, il vino buono, la selvaggina, e molte altre merci che, oltre a non essere necessarie per la vita, hanno molta influenza per indebolire i corpi e corrompere gli animi. In tal modo saranno favoriti i poveri, in gran numero, si porr� un freno allo smodato lusso dei ricchi {sic enim & inopibus consuletur, quorum est magnus numerus, & luxui hominum potentium modus erit}, affinch� non dissipino facilmente i loro tesori nei piaceri della tavola. E se non volessero essere sanati, sar� giusto almeno ottenere, dalla loro insensatezza, un vantaggio per la repubblica {quod si sanari noluerint, ex eorum amentia fructum aliquem ad rempublicam redire aequum erit}. Nello stesso tempo accadr� che n� i poveri saranno del tutto impoveriti, altrimenti sorgerebbero nuovi e gravi tumulti; n� i ricchi i quali sempre di meno utilizzano quei beni di lusso, essendo aumentato il prezzo, cresceranno troppo in potenza e in ricchezza. Entrambi gli eccessi infatti sono dannosi, come lasciarono detto i grandi filosofi e la realt� stessa dimostra {Utrumque enim noxium est, uti magni philosophi affirmatum reliquerunt & res ipsa indicat}�: Mariana (1599: 327).
[135] Secondo quanto sosteneva lo stesso Julius Paulus, infatti: �L�origine della compravendita {emendi vendendique} risale al baratto {permutatio}. Un tempo, infatti, non esisteva la moneta {nummus}, n� si chiamavano l�un termine merce {merx}, l�altro prezzo {pretium}, ma ciascuno, in base alla necessit� del momento e delle circostanze, scambiava cose inutili con utili {sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilibus permutabat}, giacch� spesso accade che ci� che ad uno abbonda ad un altro manchi. Ma dal momento che non sempre n� facilmente si verificava che, quando tu avevi ci� che io desideravo, per contro, fosse da me posseduto quello che avresti voluto ricevere tu, si � scelto un materiale {electa materia est}, la cui valutazione pubblica e permanente {publica ac perpetua aestimatio} permetterebbe di risolvere le difficolt� dello scambio {permutationum} per mezzo di un�uguaglianza quantitativa {aequalitate quantitatis}�: Paulus, Dig., 18, 1, 1.
[136] Su cui si veda Roover (1958).
[137] Mariana (1609b: 580). Le affermazioni del gesuita si fondavano sull�autorit� di giuristi come il glossatore canonista Enrico da Susa, detto l�Ostiense dal titolo cardinalizio di Ostia, il commentatore Niccol� Tedeschi, detto Panormitano, ed Innocenzo.
[138] Cfr. quanto sostenuto in proposito da Ballesteros Gaibrois (1939: 46-47).
[139] Mariana (1599: 330-331).
[140] Mariana (1599: 208). Pur con tutte le cautele che tali paralleli devono suscitare, tuttavia, al riguardo si pu� affermare che lo stesso filosofo viennese Karl Raimund Popper (1902-1994) ha avuto modo di sostenere concetti similari quando, proprio sulla scorta di un esempio storico di furto, attuato da parte dei Fenici ai danni degli Ateniesi, ha precisato che �[s]e prima non si � instaurato un sistema legale, non si pu� avere un mercato libero. [�] Un tale sistema pu� essere instaurato soltanto dallo Stato e dal suo sistema legale. E anche nel caso di una societ� in cui vi siano pratiche di semi-ruberia, vale a dire di corruzione, anche l� la gente fa degli intrighi che non possiamo considerare un mercato libero. [�] Se immaginiamo un tentativo di instaurare quello che chiamiamo �capitalismo� senza un sistema legale, ci troveremo di fronte a corruzione e furto�: cfr. Popper (1992: 33).
[141] Mariana (1599: 328).
[142] Mariana (1609b: 588).
[143] Cfr. quanto sostenuto da Ballesteros Gaibrois (1939: 26); di questo stesso autore si veda anche (1944).
[144] Lo stesso Mariana notava che �[o]gni uomo saggio {vir prudens} [�] deve tenere in considerazione i tempi e la forma di Stato {reipublicae} in cui � nato, e non lasciarsi prendere dal desiderio di un totale rinnovamento: aspirare s� al meglio, ma rammentando sempre che gli imperi e le repubbliche {imperia & respublicas} non mutano se non in peggio�: Mariana (1599: 36).
[145] Olgiati (1943: 115 e 118).
[146] Su tale metamorfosi intellettuale, si consulti lo studio di Haydn (1950).
[147] �[C]onficiendis omnibus nullius vita quamvis longaeva sufficiat, nisi observatio multorum prudentiaque accedat multo usu collecta� Mariana (1599: 19).
[148] Mariana (1609c: 398).
[149] Cfr. Hayek (1952).
[150] Cfr. su questo punto Ferraro (1989).
[151] Mariana (1609a: 413-462).
[152] In proposito si veda anche Mariana (1599: 161-167).
[153] Cfr. S�nchez Agesta (1981: xviii).
[154] �Separati assolutamente i due poteri, si deve per� cercare, con impegno, che entrambi gli ordini siano uniti dai lacci dell�amore e dalla reciproca corrispondenza {Prorsus divulsa utraque potestate curandum diligenter, ut uterque ordo benevolentia & mutuis inter se officijs constringantur}. Questo pu� accadere facilmente se ad entrambi sia consentito l�accesso agli onori e agli oneri dell�uno e dell�altro. Infatti, in tal modo, una volta conciliati gli animi, mentre gli uomini rivestiti del sacro ordine si adopereranno per la salvezza della repubblica, i principi e i grandi del regno prenderanno con impegno il compito di difendere la religione cristiana. Da ci� si manifesta la speranza certa di potere ingrandire in onori e ricchezze se stessi e i suoi�: Mariana (1599: 110).
[155] Tanto che, in chiara polemica con le concezioni protestanti, asseriva: �Sono in errore, e in errore gravissimo, quanti, rifacendosi ai primi tempi della Chiesa, reputano molto pi� utile per il bene della repubblica e di tutti {e republica atque communi salute fore}, se i Pontefici, sull�esempio degli Apostoli {Pontifices Apostolorum exemplo}, fossero costretti ad abdicare a tutte le loro ricchezze, a tutti i loro domini e poteri temporali {curamque reipublicae}. In realt� questi uomini sono ciechi non considerando a quanti mali si andrebbe incontro una volta privati i sacerdoti di tali mezzi, quanta confusione ci sarebbe tra la plebe {plebis licentia}, quanto disprezzo per il sacro ordine {sacrati ordinis}. Solo se, privati delle ricchezze, diventassero pi� virtuosi allora forse dovremmo accettare la loro opinione. Ma spogliati delle ricchezze ora, per come vanno gli uomini e i tempi, sarebbero maggiori i vizi {Sublatis opibus si virtutes succederent, probanda eorum ratio esset fortassis. Nunc detractis opibus, ut sunt homines & tempora, major vitiorum licentia existat}: riscontriamo infatti che, in quegli stati in cui i sacerdoti vivono miseramente, questi non sono affatto migliori, ma peggiorano in tutti i sensi la loro condotta e sono disprezzati dal popolo, con grande disonore per la religione cristiana�: Mariana (1599: 276-277).
[156] �Multas in una provincia esse religiones non est verum�: Mariana (1599: 419).
[157] �A mio parere il principe deve proteggere la nobilt� {nobilitas} e dare, in base agli illustri meriti dei loro predecessori, qualcosa ai discendenti solo se alla nobilt� di nascita {natalium splendorem} si aggiungano l�ingegno {industriam}, la virt� {virtutem} e l�integrit� dei costumi {mores haud dissimiles}. Nulla � pi� vergognoso di una nobilt� vile {ignava nobilitate}, che inorgoglita dalla gloria dei predecessori, consuma nella prodigalit� e dissolutezza {nequitia & levitate} le ricchezze {opes} ottenute in eredit�; fidando negli elogi che meritarono i loro nonni, illanguidisce nella lascivia e nella pigrizia, aspirando ad ottenere con i suoi vizi il premio della virt� e, grazie all�apparenza di nobilt�, di occupare con indolenza e infingardaggine i posti dati a uomini forti di carattere. Tali uomini devono essere allontanati dal principe per la loro duplice ignominia: non solo contaminano se stessi con tale onta, ma macchiano anche lo splendore del loro lignaggio {generis claritatem}. Infatti, quanto pi� illustri furono i loro avi, tanto pi� sono degni di odio coloro che oscurano con passioni vergognose lo splendore della nobilt� {splendorem nobilitatis}. Ma soprattutto la maggior parte di loro � talmente temeraria e forte che, insuperbiti da titoli inutili {nominibus inanissimis superbientes}, disprezzano gli uomini di oscuri natali, per quanto siano abili, forti ed operosi, giungendo perfino a non riconoscerli come uomini. Ricoperti di molti onori ne desiderano sempre di maggiori, credendo, questi uomini perfidi ed ambiziosi, che tutti i premi dovuti alla virt� {virtuti} siano da attribuire alla loro nobilt� {nobilitati}�: Mariana (1599: 293).
[158] �[�] Princeps contingat, alioquin si rempublicam in periculum vocat, si patriae religionis contemptor existit, neque medicinam ullam recipit, abdicandum iudico, aliumque substituendum: quod in Hispania non semel fuisse factum scimus�: Mariana (1599: 43-44).
[159] Cfr. Fava (1953: 125).
[160] Cfr. S�nchez Agesta (1981: xv).
vai indietro