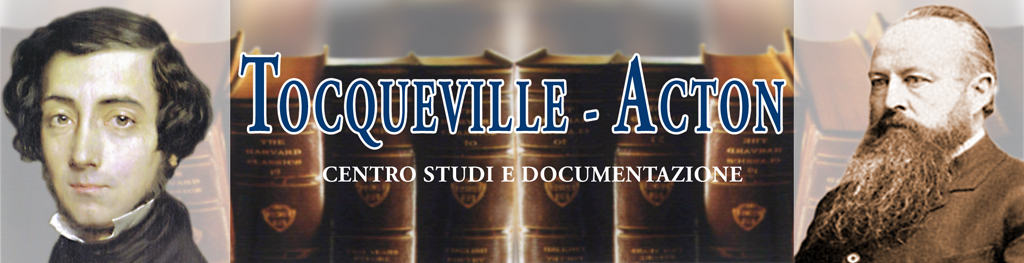
![]() D. Antiseri,
Luigi Sturzo Difensore della
Scuola Libera
D. Antiseri,
Luigi Sturzo Difensore della
Scuola Libera
![]() M.N. Rothbard,
Sinistra e Destra: le prospettive della libert�
M.N. Rothbard,
Sinistra e Destra: le prospettive della libert�
![]() A. Oliviero,
Economia e democrazia nel pensiero di Ludwig von Mises
A. Oliviero,
Economia e democrazia nel pensiero di Ludwig von Mises
![]() L. Tirabassi,
Noi e l'America
L. Tirabassi,
Noi e l'America
vai indietro
Luigi Sturzo Difensore Della Scuola Libera
di Dario Antiseri
Relazione
al Convegno Internazionale di Studio
Universalit� e cultura
nel pensiero di Luigi Sturzo
Istituto Luigi Sturzo
Roma, 28-30 ottobre 1999
-- Su �Giustizia e libert�� del 1 febbraio del 1935 compare un attacco contro il Partito Popolare Italiano, a proposito della libert� di insegnamento. Sempre su �Giustizia e libert�� del 15 marzo dello stesso anno Sturzo replica affermando di non comprendere la ragione di un simile attacco. E aggiunge: �Che il partito popolare italiano abbia mantenuto sempre la sua fede nella libert� [�] non credo che si possa dubitare. A parte ogni altra prova, ne fanno fede i due dei nostri capi morti in esilio, Giuseppe Donati e Francesco Luigi Ferrari. Che poi i cattolici al potere sappiano rispettare la libert� d�insegnamento che hanno sempre invocata, la prova � data dal Belgio, dove i cattolici da soli han governato per circa quaranta anni fino al 1914, e poi sempre in maggioranza fino ad oggi. In s� lungo periodo mai la libert� d�insegnamento � stata da essi rinnegata o menomata; al contrario, sempre sostenuta e difesa. Non desidero fare polemiche, ma solo rigettare una ingiusta insinuazione�.
-- Il 23 gennaio del 1936 il corrispondente del Times d� la notizia da Milano che in Italia saranno militarizzati anche i bambini al di sotto dei sei anni, in una organizzazione che si chiamer� pre-Balilla. In tal modo in Italia i bambini da 4 a 6 anni divennero pre-Balilla; da 6 a 8 anni erano Figli della Lupa; da 8 a 14 Balilla; da 14 a 18 Giovani italiani - e cos�, dopo 14 anni di indottrinamento - erano pronti ad essere incorporati nella milizia fascista.
Ebbene, il 30 gennaio, da Londra, Sturzo invia un articolo a El Mat� di Barcellona, articolo che il giornale pubblica l�8 di febbraio e che il 26 dello stesso mese verr� ripreso anche da Popolo e libert� di Bellinzona. Si chiedeva don Sturzo: qual � lo scopo di siffatta completa militarizzazione dell�infanzia? Eccolo: �Si vuole formare un nuovo spirito: quello della disciplina assoluta, della dedizione completa allo stato: l�altro scopo � quello di creare psicologicamente un obiettivo guerriero necessario e permanente�. Ma Sturzo faceva presente: �Obiettivi militari permanenti l�Italia non ne ha e non pu� averne. Solo obiettivi di difesa [�] Quando lo scopo � la difesa del paese, l�educazione militare ha alla sua base un�idea morale, quando la guerra offensiva e la conquista sono scopi permanenti, l�educazione militare ha per base un elemento non morale. Trasportate questo elemento nell�educazione della giovent� e avverr� la perversione di fini ottimi e giusti in fini ingiusti e immorali. Che dire - cos� concludeva Sturzo il suo articolo -, che dire quando si comincia a quattro anni a parlare di guerre e di conquiste, di nemici da combattere e da odiare? Quale base anticristiana alla vista di un popolo!�.
-- Il 5 marzo del 1947, sul numero 2 di �Belfagor� appare un lungo e impegnativo saggio di Sturzo dal titolo Il problema dell�educazione degli Stati Uniti e l�educazione umana. In quei giorni l�Assemblea costituente era nel pieno dei lavori e il saggio di don Sturzo voleva essere un contributo alla discussione sul problema dell�educazione. Sturzo punta innanzi tutto la sua attenzione sull�educazione morale dei giovani. �Non si creda che si tratti - egli scrive - dell�educazione morale dell�alunno come cosa a parte della sua formazione intellettuale e della pratica conoscenza delle materie scolastiche. Lo sviluppo delle tendenze altruistiche nel moderare l�egoismo innato desta quella simpatia comprensiva che � fondamentale per una piena conoscenza del mondo in cui viviamo, mondo di uomini e di cose, di idee e di fatti, di viventi (animali e piante compresi) e di materia da vivificare �. Sturzo precisa: �Se nelle scuole si apprendesse non solo il precetto di amare il prossimo come noi stessi, ma il modo come intendere la societ� in cui e per cui l�uomo si evolve e si realizza storicamente, e i mezzi con cui influire perch� l�attivit� dell�uomo sia rivolto al maggior profitto comune, allora l�alunno comprenderebbe assai meglio se stesso come uomo, la sua ragion d�essere, il momento storico nel quale egli vive, le prospettive di utilit� comune e i mezzi per proseguirla effettivamente�. Sta qui la ragione, scrive Sturzo, per cui � imprescindibile �dare, lungo tutto il periodo educativo, la comprensione storica delle cose�. E questo implica la necessit� di combattere come pericoloso per l�educazione di un paese civile �il rifiuto della conoscenza storica, del proprio paese e degli altri, anzi dell�umanit�. La societ� � quel che la storia l�ha fatta; noi siamo quel che la storia ci ha fatto. Noi siamo piantati nella storia, come l�albero � piantato nella terra�. La storia - insiste don Sturzo - �ci d� il senso della relativit� e della continuit�, dell�interdipendenza dei popoli e della loro creativit�: ci dice come l�uomo ha superato e vinto gli ostacoli della natura e del vivere insieme; ci fa realizzare il valore della libert� e della moralit�; quale sia stata nei secoli la lotta perenne per il bene, che � lotta per le grandi conquiste della civilt�. Non � vero che la storia ci rende pessimisti. La storia - scrive Sturzo - ci rende ottimisti �perch� ci mostra le enormi possibilit� che gli uomini hanno ad intendersi�. Per Sturzo, �chi sa leggere la storia vede che l�odio fra gli uomini � nato dalla paura e l�amore dalla conoscenza reciproca; l�odio dall�egoismo che segrega, e l�amore dall�altruismo che salda i contatti e li rende efficaci�.
-- Nel luglio del 1947 su �Sophia� e sul n.7 di �Idea� Sturzo pubblica un articolo riguardante La libert� della scuola. Qui, con acume e preveggenza impressionanti Sturzo pone il dito su di una piega che da quei giorni non si � pi� rimarginata. Leggiamo: �L�eredit� fascista nel campo della scuola � stata disastrosa come in campo militare e politico. Il monopolio statale fu completo; la scuola privata credette giovarsi delle concessioni e dei favori che pag� con la perdita di ogni libert� didattica e funzionale�. Dunque: per salvare la scuola � necessario, urgente, cambiare rotta; sennonch� - egli annota - �il disorientamento persiste, e le linee sostanziali tracciate dagli articoli 27 e 29 della Costituzione (che poi diventarono gli articoli 33 e 34 del testo costituzionale), invece di fissare una chiara direttiva accettabile, con il loro pesante impaccio legislativo ne aggravarono la crisi�.
Un giorno un amico di Sturzo, colpito dalle aspre critiche di costui nei confronti della scuola monopolizzata dello Stato, chiese quali fossero le sue proposte per riformarla. E la sua risposta fu �di aprire le finestre e fare entrare una buona corrente d�aria di libert�, altrimenti vi si morir� asfissiati�. Certo, Sturzo ben conosceva le radici e le ragioni della scuola di Stato in Italia. Egli non intendeva minimamente proporne l�abolizione. Voleva soltanto che il sistema scolastico venisse riformato �senza improvvisazione e con sani criteri didattici e sociali�. Ma il punto principale era, a suo avviso, �quello dell�orientamento dell�opinione pubblica verso la libert� scolastica e contro il monopolio di Stato�. Tutto ci� nella convinzione che �finch� la scuola in Italia non sar� libera, neppure gl�italiani saranno liberi: essi saranno servi, servi dello Stato, del partito, delle organizzazioni pubbliche e private di ogni specie [�], La scuola vera, libera, gioiosa, piena di entusiasmi giovanili, sviluppata in un ambiente adatto, con insegnanti impegnati alla nobile funzione di educatori, non pu� germogliare nell�atmosfera pesante creata dal monopolio burocratico statale�.
-- Sull��Illustrazione italiana� del 12 febbraio del 1950 Sturzo affronta (con un articolo dal titolo: Scuola e diplomi) la questione dei diplomi - del pezzo di carta, del titolo rilasciato dallo Stato, visto come talismano in grado �di aprire le porte dell�impiego stabile�. Sturzo � deciso: �Occorre capovolgere la situazione: sia lo studio, non il diploma ad aprire le porte dell�impiego�. Ed ecco la sua proposta: �Ogni scuola, quale che sia l�ente che la mantenga, deve poter dare i suoi diplomi non in nome della repubblica, ma in nome della propria autorit�; sia la scoletta elementare di Pachino o di Tradate, sia l�universit� di Padova o di Bologna, il titolo vale la scuola. Se una tale scuola ha una fama riconosciuta, una tradizione rispettabile, una personalit� nota nella provincia o nella nazione, anche nell�ambito internazionale, il suo diploma sar� ricercato, se, invece, � una delle tante, il suo diploma sar� uno dei tanti�.
Sturzo, inoltre, si poneva il problema degli insegnanti, e proponeva che sia le scuole statali che quelle non statali avessero �il diritto di partecipare alla scelta dei professori� - giacch� altrimenti si dovrebbe dire che le scuole siano esclusivamente in funzione degli insegnanti.
-- La direzione dell��Illustrazione italiana�, nel pubblicare l�articolo di Sturzo, espresse in una nota alcune riserve. Sturzo, allora, invi� al giornale una lettera in cui precisava che le sue idee sulla libert� di scuola erano note sin da prima della fondazione del partito popolare e che egli l�aveva difesa nei quattro anni del suo segretariato politico �quando alla Camera furono contrastati i tre disegni di legge scolastica proposti da Croce, da Corbino e da Anile�. E aggiungeva �che le sue esperienze inglese, olandese, svizzera, belga e americana dal 1924 al 1946 �sono state posteriori, e sono servite a confermarmi nell�idea che solo la libert� pu� salvare la scuola in Italia�.
E poi: �La storia del �confessionalismo scolastico� che si avvantaggerebbe della �libert��, fa pendant con quella del �comunismo� che si avvantaggia della libert�, o del �laicismo� che si avvantaggia della libert�.
Bisogna scegliere o la libert� con tutti i suoi �inconvenienti� ovvero lo statalismo con tutte le sue �oppressivit��.
Io ho scelto la libert� fin dai miei giovani anni, e tento di potere scendere nella tomba senza averla mai tradita.
Perci� ho combattuto in tutti i campi, e non solo in quello scolastico, lo �statalismo�, sia quello pre-fascista, sia quello fascista, e combatto oggi lo statalismo post-fascista, del quale parecchi dei miei amici, bongr�, malgr�, si sono fatti garanti.
L�intolleranza scolastica dei laicisti � sostanziata dalla presunzione che essi difendono la libert�; mentre la libert� non � monopolio di nessuno.
Il monopolio scolastico dello stato � sostanziato da una presunzione, che solo lo stato sia capace di creare una scuola degna del nome; mentre non � riuscito che a burocratizzarla e fossilizzarla.
In sostanza, non c�� libert� dove c�� intolleranza e dove c�� monopolio. Questa � la triste situazione italiana�. Lo era nel 1950. E lo �, disgraziatamente, anche oggi.
-- Il sofisma della libert� appare su �La via del 23 settembre del 1950. Qui Sturzo contesta le equazioni laiciste stando alle quali �scuola-di-stato uguale libert� d�insegnamento; scuola privata uguale privazione della libert� di insegnamento�. In questa sede riveste tuttavia grande rilevanza la lettera che lo stesso giorno, a completamento dell�articolo, don Sturzo invia all�on. Guido Gonella, allora ministro della Pubblica istruzione:
�Caro Gonella,
ho letto articolo per articolo il progetto di riforma scolastica e, mentre apprezzo l�enorme lavoro compiuto e lo sforzo di dare ordine all�attuale sistema scolastico, ho parecchi dubbi, non poche perplessit� e perfino delle serie obiezioni.
Forse, partendo da criteri diversi e da esperienze diverse, non troviamo il terreno comune di intesa in materia cos� grave e complessa.
Mi rendo conto che tu non sei libero di attuare un tuo ordinamento e sei vincolato da tutto il sistema burocratico che opprime la scuola statale, e che tende a rendere soggetta allo stato la scuola non statale e tutte le iniziative culturali e assistenziali della scuola.
Io combatto lo statalismo, malattia che va sempre pi� sviluppandosi nei paesi cosiddetti democratici, che in Italia (come in Francia) toglie respiro e movimento alla scuola.
Siamo arrivati a questo, che quella piccola e contrastata partecipazione civica nell�ordinamento della scuola (comune e provincia) che era nell�Italia pre-fascista, non ha pi� posto neppure nel tuo progetto, e che le poche attribuzioni date dalla costituzione alla regione sono, nel tuo progetto, regolamentate e soverchiate con l�ingerenza burocratica del ministero e degli ispettorati regionali (violando, perfino, i diritti delle regioni a statuto speciale). Non ti dico quale disappunto per me leggere le disposizioni che riguardano l�insegnamento privato.
Un italiano andato in America, mi scriveva scandalizzato che l� non c�� un ministero della pubblica istruzione. Gli risposi, a giro di posta, che, perci�, l�americano � un popolo libero e l�italiano no.
Comprendo bene che l�Italia, senza lo stato (e il suo ministero della pubblica istruzione) sarebbe senza scuole sufficienti per una popolazione cos� densa e cos� povera; perci� bisogna rassegnarsi alla scuola di stato, come il minor male, evitando, per�, che resti cos� accentrata, burocratizzata e monopolizzata come l�abbiamo ereditata dai fascisti e come, purtroppo, sembra che venga tramandata (auspice la democrazia cristiana) ai nostri posteri�.
-- Il 6 maggio del 1952 si spegneva a Noordwjck, in Olanda, Maria Montessori. Nel giugno dello stesso anno, ancora su �La via�, viene pubblicato un articolo di Luigi Sturzo intitolato Ricordando Maria Montessori.
�1907: ero da due anni sindaco di Caltagirone. La scuola mi interessava pi� di ogni altro ramo dell�amministrazione: non invano avevo insegnato per dodici anni al seminario vescovile, ed avevo gi� fatte le prime battaglie per la libert� della scuola.
Le mie gite a Roma erano frequenti allora, sia per l�associazione nazionale dei comuni, della quale ero consigliere; sia per gli affari del mio comune; cos� mi capit� di incontrare presso amici la dottoressa Montessori che mi invit� a visitare la sua scuola nel quartiere S. Lorenzo. Sapevo che sospetti di naturalismo avevano ostacolato l�iniziativa; dopo un lungo colloquio decisi di visitare le scuole e rendermi conto del tipo di scuola e delle ragioni del metodo.
Andai pi� volte a S. Lorenzo; il mio interessamento si accrebbe di volta in volta; e Maria Montessori non dimentic� mai il piccolo prete che per il primo aveva preso diretto interesse alla sua iniziativa, l�aveva incoraggiata, ed aveva affermato che nessuna pregiudiziale anticristiana fosse alla base di quell�insegnamento; cosa che poteva essere introdotta in questo e in altri metodi da maestri non credenti.
Da quel periodo iniziale non ebbi occasione di rivedere la Montessori che pi� tardi, in qualche sua sosta a Roma, dopo la fine della prima guerra mondiale, con rapidi incontri per conoscere i progressi delle sue molteplici iniziative.
Poscia a Londra, il giorno di S. Luigi 21 giugno del 1925, in una casa religiosa di Fulham Road, mi vedo portare nella mia stanzetta, un bel mazzo di garofani bianchi: erano della Montessori ed io ignoravo ch�ella fosse nella stessa citt�. Mi si fece viva in un giorno a me caro; in un�ora di forte nostalgia, quando lontano dalla sorella e dagli amici, mi venivano in mente le care feste dell�onomastico, in un paese dove l�onomastico non si ricorda e di amici a Londra non ne segnavo allora che pochi, anzi pochissimi.
Cos� ci rivedemmo; e si parl� dell�Italia, soprattutto dell�Italia, e delle vicende nostre e dello sviluppo del metodo Montessori nel mondo, e dei piani del futuro e ricordammo la visita del prete caltagironese alla scoletta di S. Lorenzo.
L�alone di simpatia e di fiducia che circondarono le varie iniziative all�estero della Montessori e la diffusione del suo metodo, il premio Nobel, tutto serv� a far mettere in prima linea nel mondo la figura di questa italiana. La confrontavo con un�altra italiana, maestrina, fondatrice di ordine religioso, allora beata e poscia santa Francesca Saverio Cabrini, che l�America del nord stima sua concittadina, e che ha fama anche presso il mondo protestante. L�avevo conosciuta anch�essa personalmente, dieci anni prima di aver conosciuto la Montessori, proprio per il mio interessamento alle scuola infantili ed elementari, nel desiderio di avere a Caltagirone una casa delle figlie missionarie del S. Cuore da lei fondate; cos� come avevo desiderato aprirvi una scuola Montessori.
Le mie iniziative fallirono allora, l�una e l�altra per mancanza di soggetti.
Mi son pi� volte domandato perch� da quarantacinque anni ad oggi, il metodo Montessori non sia stato diffuso nelle scuole italiane. Allora come oggi, debbo dare la stessa risposta: si tratta di vizio organico del nostro insegnamento: manca la libert�; si vuole l�uniformit�; quella imposta da burocrati e sanzionata da politici. Manca anche l�interessamento pubblico ai problemi scolastici; alla loro tecnica, all�adattamento dei metodi, alle moderne esigenze. Forse c�� di pi�: una diffidenza verso lo spirito di libert� e di autonomia della persona umana, che � alla base del metodo Montessori. Si parla tanto di libert� e di difesa della libert�; ma si � addirittura soffocati dallo spirito vincolistico di ogni attivit� associata dove mette mano lo Stato; dalla economia che precipita nel dirigismo, alla politica che marcia verso la partitocrazia, alla scuola che � monopolizzata dallo Stato e di conseguenza burocratizzata�.
* * *
Ho inteso sin qui seguire con scrupolo filologico i pensieri di don Luigi Sturzo a difesa della scuola libera. E a questo punto non � certo cosa difficile vedere l�attualit� della sua soluzione razionale dei problemi che, ai nostri giorni, affliggono la scuola italiana. Aveva ragione Adolf Loos a dire che della verit� non chiediamo la data di nascita e che non dobbiamo lasciarsi abbagliare dalle menzogne che ogni giorno ci passano accanto.
Su di un fatto possiamo essere tutti d�accordo: i guai della scuola di Stato, in Italia, non dipendono dalla scuola non statale: la scuola non statale, da noi, non esiste quasi; e per quel che esiste fa risparmiare ogni anno allo Stato qualche migliaio di miliardi. La verit� � che la scuola libera, in Italia, � solo libera di morire. Negli ultimi anni si � spenta quasi una scuola libera al giorno.
Evitando il confronto con altri Paesi europei - come l�Inghilterra, il Belgio, l�Olanda, la Germania -, vi invito a riflettere solo sul fatto che in Costa d�Avorio la scuola non statale occupa l�11% della scuola primaria e il 24% della scuola secondaria; in Italia, la scuola non statale occupa il 6% della scuola primaria e il 5% della scuola secondaria. In Giappone - nel Giappone dello scientismo - esistono 34 universit� cattoliche e circa 280 istituti superiori gestiti dai cattolici. L�imperatrice del Giappone ha studiato in una universit� cattolica. In Italia, dunque, vige un monopolio o quasi-monopolio statale dell�istruzione. Ed � esattamente contro il monopolio statale dell�istruzione che Sturzo ha puntato le sue argomentazioni critiche. Pu� uno Stato di diritto avversare la pretesa del monopolio o quasi-monopolio nella gestione della scuola? Una pretesa del genere non �, piuttosto, un tratto caratteristico dello stato etico? Tale pretesa - scriveva nel 1930 Sturzo nel capitolo 2 (Lo Stato totalitario) di Politica e morale - � tipica degli stati totalitari, dove si esige �la sottomissione intellettuale e morale completa� allo Stato.
Va qui ricordato che non � dovuto certamente al caso il fatto che le Costituzioni dei Paesi che si sono liberati dal comunismo abbiano stabilito, senza possibilit� di equivoci, la libert� di scuola:
- la Costituzione ungherese (1989) all�art. 67,2 stabilisce che �i genitori devono avere il diritto di scegliere il tipo di educazione che essi desiderano assicurare ai loro figli�.
- la Costituzione croata (1990) dice (all�art. 63) che �i genitori hanno il dovere di allevare, sostenere e istruire i loro figli ed hanno il diritto e la libert� di decidere autonomamente l�educazione da dare ai loro figli�.
- la Costituzione bulgara del 1991 (all�art. 47,1) recita che �la crescita e l�educazione dei figli sino a quando questi raggiungano la maggiore et� � un diritto e un obbligo dei genitori; lo Stato offre le risorse�;
- la Costituzione estone (1992) stabilisce (all�art. 37) che �i genitori devono avere la decisione finale nella scelta educativa per i loro figli�;
- In Polonia c�� stata, nel giro di pochi anni, una vera fioritura di scuole libere. Ma la situazione maggiormente interessante � quella russa. In Russia la legge sulla scuola del luglio 1992 rende possibile una espansione senza limiti delle alternative educative, sulla base di stanziamenti governativi paritari per le scuole statali e quelle libere.
* * *
Tutti coloro che, facendo molto chiasso, hanno parlato e parlano di riforme necessarie per portare la nostra scuola al passo con la scuola degli altri Paesi europei, non farebbero male a riprendere tra le mani la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla libert� di insegnamento del 1984, dove, tra l�altro, si stabilisce che: �il diritto alla libert� d�insegnamento implica per sua natura l�obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l�esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all�adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale�.
E dal Parlamento Europeo passiamo al Partito Popolare Europeo. Nel Programme d�action PPE 1999-2004 [(1er Projet) cap. 6 - par. 10] leggiamo: �La formazione � un diritto fondamentale tanto individuale che sociale, di cui � responsabile lo Stato e che deve essere accessibile ad ogni fanciullo indipendentemente dal suo ambiente sociale. Poich� il PPE � convinto che la realizzazione della societ� europea abbia luogo nella libert� e che debba essere riconosciuta l�autonomia dei differenti gruppi sociali, esso si schiera a favore della libera scelta del sistema di formazione. La libera scelta della scuola deve essere una realt�. La spesa dello Stato per l�educazione di ogni scolaro deve essere indipendente dalla scelta dei suoi genitori. Lo Stato deve mettere a disposizione di ogni scolaro una pari somma di denaro�. Ci� - si precisa nel Programma (par. 11) - in base al �principio democratico-cristiano di sussidiariet�. E ancora al par. 25: �In una societ� democratica e aperta, la libera scelta della scuola � una realt�. Le scuole che si basano sull�iniziativa privata rappresentano la libert� e la coscienza della responsabilit� di una societ�. I genitori dovranno avere la libert� di scelta della scuola, quando siano convinti che essa risponde nel modo migliore ai bisogni del loro figlio. Questo include le scuole private. La possibilit� di scelta tra scuole pubbliche e private non rappresenta soltanto una promozione della concorrenza di qualit� ma irrobustisce anche l�interesse dei genitori nei confronti della scuola del loro figlio e li legano pure alla vita quotidiana della scuola. Da qui, la conclusione che � bene promuovere le istituzioni scolastiche fondate sulla iniziativa non statale. La scelta della scuola non pu� in nessun caso, a motivo della attribuzione dei mezzi, dar luogo a delle discriminazioni�.
* * *
Purtroppo si stenta a capire che la competizione - nella vita politica come in economia e come pure nella scienza - � un�alta forma di collaborazione. E insieme a questo principio, non saranno mai sopravvalutate la forza morale e l�efficacia politica del principio di sussidiariet� - fissato in termini inequivocabili nella Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI: �Siccome non � lecito togliere agli individui ci� che essi possono compiere con le forze e l�industria propria per affidarlo alla comunit�, cos� � ingiusto rimettere ad una maggiore e pi� alta societ� quello che dalle minori e inferiori comunit� si pu� fare. Ed � questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della societ�, perch� l�oggetto naturale di qualsiasi intervento della societ� stessa � quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non gi� distruggerle ed assorbirle�. Ribadito nella Pacem in Terris (1968) di papa Giovanni XXIII, il principio di sussidiariet� torna nella Centesimus Annus (1991) di Giovanni Paolo II, dove si afferma che �una societ� di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una societ� di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessit� ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune�.
E� nel principio di sussidiariet� che la scuola libera trova uno dei suoi pi� consistenti fondamenti; e nel principio di competizione trova la base del suo migliore funzionamento.
* * *
La battaglia di Luigi Sturzo � stata una battaglia contro il monopolio statale dell�istruzione. E chiare appaiono le ragioni di questa sua battaglia: il monopolio statale dell�istruzione rappresenta un continuo attentato alla libert�; contrasta con le pi� elementari norme della giustizia sociale; distrugge l�efficienza della scuola.
Il monopolio statale dell�istruzione mette in pericolo la libert�, giacch� � solo con la presenza della scuola libera che alle famiglie viene garantita la possibilit� di una reale alternativa sia sul piano dell�indirizzo culturale, politico e religioso che sul piano della qualit� e del contenuto dell�insegnamento.
Il monopolio statale dell�istruzione, oltre che liberticida, viola le regole della giustizia sociale: chi manda il proprio figlio alla scuola non statale paga due volte, una volta con le imposte - per un servizio che non riceve - e una seconda volta con la retta da corrispondere alla scuola non statale. E pagare due volte l�istruzione per i propri figli � un lusso che non tutti possono permettersi.
N� � possibile, in linea generale, coniugare monopolio dell�istruzione ed efficienza della scuola: ove manca la competizione, l� regnano irresponsabilit� e corruzione; senza concorrenza, gli esiti prevedibili sono inefficienza, servizio scadente e aumenti dei costi.
* * *
Le soluzioni che potrebbero riequilibrare le sorti della scuola italiana nella direzione del principio di sussidiariet� e di quello della competizione - in modo da migliorarne i rendimenti e moralizzarne i comportamenti - sono due: una radicale, il buono-scuola; l�altra di valore quanto meno �terapeutico�: il credito di imposta.
Il buono-scuola non � altro che un mezzo vincolato di pagamento (voucher) che lo Stato mette a disposizione dei contribuenti, perch� questi possano spenderlo liberamente sul mercato scolastico, decidendo a quale tipo di istituto, statale o non statale, affidare l�educazione dei propri figli. Il valore del buono si pu� determinare - tecnicamente - dal rapporto fra ci� che lo Stato spende attualmente per un dato tipo di scuola e il numero di studenti che frequenta quella stessa scuola. Il buono-scuola pu� funzionare come uno strumento di �equalizzazione� delle opportunit� individuali; il buono-scuola � una carta di liberazione per i poveri - con esso anche i meno abbienti potranno pagarsi le scuole �dei ricchi� - oltre che come garanzia sul controllo di efficienza delle diverse offerte scolastiche.
Il credito d�imposta consiste invece nella possibilit� di detrarre dall�imposta dovuta sul reddito le spese relative all�istruzione dei propri figli, integralmente o almeno in parte. Non � molto rispetto agli obiettivi di libert� e di giustizia sociale sui quali raddrizzare le ormani croniche storture della scuola italiana, ma � certo un buon passo avanti in questa direzione. Mentre ci sono ragioni per ritenere che nella direzione della libert�, della giustizia sociale e dell�efficienza non vada il sistema della convenzione. La convenzione, comunque la questione venga considerata, consister� sempre in una sovvenzione (pagamento degli stipendi degli insegnanti, pagamenti degli affitti e analoghe misure) che lo Stato o altro ente pubblico concede a scuole non statali. La verit� � che: chi paga compra. Lo sapeva bene un antico romano - Publilio Siro - che �beneficium accipere libertatem est vendere�.
* * *
Sturzo non tralasci� di rispondere alle obiezioni avanzate da laicisti e statalisti contro l�introduzione di linee di competizione all�interno del nostro sistema scolastico. E, innanzi tutto, non ci sono ragioni - in uno Stato di diritto - per proibire scuole confessionali, a patto che queste si inseriscano nel quadro dei valori della societ� aperta (tolleranza, antirazzismo, solidariet�, ecc.). Le diversit� (di visioni del mondo, di valori scelti, ecc.) sono l�essenza della societ� aperta. Pericolosa per la societ� � la negazione delle diversit�, e non la loro aperta, leale e tollerante affermazione. Come sottolineato dal card. Lustiger, il soffocamento della diversit� � la prima causa della sua violenta esplosione.
D�altro canto, una scuola non � una scuola che indottrina per il semplice fatto di essere una scuola libera o ad orientamento confessionale; ed una scuola non � critica e tollerante per il semplice fatto che � statale. Le istituzioni sono come le fortezze; resistono se � buona la guarnigione. E buone guarnigioni - come cattive guarnigioni - possono operare in scuole libere come in scuole statali.
Si � detto e si ripete che, in regime di buono-scuola, non poche famiglie non sarebbero in grado di scegliere la scuola adeguata per i loro figli. Tale presa di posizione � offensiva; � un affronto alla democrazia (elettori a diciotto anni, tanti italiani - uomini e donne - sarebbero, ancora pi� avanti negli anni - incapaci di far la migliore scelta per i propri figli). Ed � un�idea falsa, nella generalit� dei casi: anche nei paesi pi� sperduti della nostra Penisola, pure la mamma meno colta e il padre pi� distratto sanno quale � la maestra pi� brava, pi� disponibile, pi� umana; e sanno quali sono i docenti pi� validi della locale scuola media. L�interesse � sorgente di energia per la cattura delle informazioni. In ogni caso, se un genitore sbaglia, sbaglia per suo figlio; i politici possono sbagliare per intere generazioni.
Ed ecco una ulteriore obiezione che viene ripetuta sino al fastidio: la scuola � un settore strategico; dunque non pu� venir lasciata al �mercato�. Ai sostenitori di una siffatta posizione replichiamo in modo deciso e secco: proprio perch� la scuola � un settore strategico, essa va gestita con le regole del mercato, mettendo in competizione scuole statali e scuole non statali. E aggiungiamo: niente � pi� necessario del pane - quello del pane � sicuramente un settore strategico-, eppure noi abbiamo il pane buono ogni mattina, per la ragione che se un forno ci servisse male noi avremmo la possibilit� di servirci da un altro fornaio.
* * *
Sturzo non immaginava affatto di abolire la scuola di Stato. La voleva riformare, migliorare - attraverso la competizione. E va ribadito che quanti - seguendo l�insegnamento di Sturzo - sono a favore dell�introduzione di linee di competizione nel nostro sistema scolastico non sono contrari alla scuola di Stato. La scuola di Stato, da noi, � un grande patrimonio - un patrimonio che da pi� parti mostra segni di crisi - sintomi di quella malattia grave che � lo statalismo. Lo statalismo - scrive Sturzo - �� disordine, disarmonia, sopraffazione, violenza nei confronti della personalit� umana, rottura dell�organismo statale; statalismo non � lo stato, ma � contro lo stato�[1].
E lo ripeto: coloro i quali, sulla questione della scuola seguono l�insegnamento di Sturzo, non sono contro la scuola statale, sono contro lo statalismo, vale a dire contro il monopolio statale dell�istruzione. Ed � per guarire la scuola da questa malattia che pensiamo alla terapia della competizione. La competizione migliorer� sia la scuola statale che la scuola non statale. E� ora di smetterla di credere valida l�equazione stando alla quale: � buono solo ci� che � pubblico; � pubblico solo ci� che � statale; � statale solo ci� che pu� diventare preda dei partiti. E� pi� pubblico, svolge un miglior servizio pubblico una efficiente scuola non statale oppure una scuola statale inefficiente e sciupona?
Nessuna scuola sar� mai uguale ad un�altra: un preside pi� operoso, insegnanti pi� preparati, una segreteria pi� efficiente fanno la differenza. Nessuna scuola sar� mai uguale ad un�altra, ma tutte potranno migliorarsi ad opera di una aperta, leale, competizione. E temono la concorrenza soltanto le scuole poco serie - siano esse statali o non statali - e tutti coloro che, atterriti alla sola idea di dover competere con colleghi eventualmente pi� preparati e con istituzioni meglio organizzate, preferiscono vivere in nicchie ecologiche protette. Da ci� segue che: lo statalista, proibendo la scuola non statale, fa del male alla scuola statale. Ancora una volta: buone intenzioni lastricano le vie dell�inferno. E senza che la competizione vivifichi dall�interno il nostro sistema scolastico, questo non potr� competere con i sistemi degli altri Paesi europei.
* * *
Non una sola volta Sturzo si � rivolto contro i laicisti - �non importa il colore se liberali, radicali o socialisti� - i quali parlano della scuola di stato �come il non-plus-ultra della libert� d�insegnamento�. Questi laicisti, favorendo il monopolio scolastico dello stato, creano soltanto una scuola burocratizzata, fossilizzata, inefficiente e sciupona.
E a tutt�oggi non � difficile assistere ad irritate esplosioni di laicismo anticlericale, ormai fuori di luogo e fuori di tempo, in base al quale si combatte la scuola non statale �perch� scuola dei preti�. Posizioni del genere sono del tutto insostenibili: i cattolici che lottano per la scuola libera lottano per la pi� ampia libert� di insegnamento. E se qui non vanno dimenticati i dati sulla percentuale di scuole non statali a conduzione laica, in un confronto con i dati riguardanti le scuole cattoliche,
|
|
Scuole laiche |
Scuole cattoliche |
|
Elementari Medie inferiori Medie superiori |
33,4 11,3 51,0 |
66,5 88,6 49,0 |
c�� poi da dire che sarebbe davvero auspicabile che i cattolici, in Italia, fossero oggi in grado di innescare una seria competizione tra scuole statali e scuole non statali. Tale competizione andrebbe a beneficio dell�intero sistema scolastico nazionale. Purtroppo, le cose non stanno cos�, giacch� molti cattolici rifiutano sia il sistema del buono-scuola che quello del credito d�imposta e si limitano a invocare dei sussidi, sotto forma di convenzione, in cui � il potere politico a stabilire chi debba essere beneficiario o cliente di turno. La convenzione - come gi� precisato - trasforma uomini liberi in cani al guinzaglio, e umilia istituzioni gloriose riducendole a serbatoi di voti.
In ogni caso, negare l�esistenza di scuole ad orientamento confessionale equivarrebbe a negare la �societ� aperta�. In Germania esistono scuole neutre e scuole ad orientamento confessionale, protestanti o cattoliche. In Olanda sono state aperte scuole induiste. Forse che la Germania e l�Olanda sono Paesi meno democratici dell�Italia? La diversit� di visioni del mondo e di valori scelti sono l�assenza della societ� aperta. La societ� aperta � chiusa solo agli intolleranti.
C�� chi, pi� in particolare, ha scritto che l�istituzione di scuole confessionali porterebbe a una balcanizzazione della societ�. A costui vorrei far notare che la balcanizzazione si � proprio avuta in societ� dove le scuole libere, comprese quelle confessionali, erano rigidamente proibite. E, al termine Mi permetto di citare un breve brano di Friedrich A. von Hayek: �A differenza del razionalismo della Rivoluzione francese, il vero liberalismo non ha niente contro la religione e io non posso che deplorare l�anticlericalismo militante ed essenzialmente illiberale che ha animato tanta parte del liberalismo continentale del XIX secolo�[2].
[1] L. STURZO,
Il travaglio
della D.C.,
Ed. Politica Popolare, Napoli, 1959, p. 33.
[2] F.A. von HAYEK, Perch� non sono un conservatore, in La societ� libera, trad. it., Vallecchi, Firenze, 1919; rist. come saggio a s� stante dalle edizioni di Ideazione, a cura di L. Infantino, Roma, 1997, p. 47.
Sinistra e Destra : le prospettive della libert� *
di M.N. Rothbard
Il Conservatore � stato a lungo segnato, che ne sia consapevole o meno, da un pessimismo di lungo periodo: dalla convinzione che la tendenza del lungo periodo, e perci� il tempo stesso, sia contro di lui. Perci�, che ci sia una tendenza inevitabile verso lo statalismo di sinistra in politica interna e verso il comunismo all�estero. E� questa disperazione di lungo periodo ad essere responsabile del bizzarro ottimismo di breve termine del Conservatore, dal momento che quello di lungo periodo � abbandonato senza speranza, il Conservatore sente che la sua unica speranza di successo riposa nel presente. In politica estera, questo punto di vista porta il Conservatore ad esigere una disperata resa dei conti con il comunismo, poich� sente che pi� a lungo aspetter� e peggio andranno le cose; in politica interna, � condotto a concentrarsi totalmente sulla prossima elezione, dove spera sempre in una vittoria senza mai raggiungerla. Quintessenza dell�uomo pratico e preda di una disperazione di lungo periodo, il Conservatore rifiuta di pensare o di fare progetti al di l� dell�elezione del momento.
Il pessimismo, tuttavia, sia quello a breve che a lungo termine, � esattamente ci� che la prognosi del conservatorismo merita, dal momento che il conservatorismo � il residuo morente dell�ancien r�gime dell�era pre-industriale e, come tale, non ha futuro. Nella sua forma americana contemporanea, il recente revival conservatore incarna l�agonia di una White Anglo-Saxon America ineluttabilmente moribonda, fondamentalista, rurale e provinciale. Che cosa sar� allora delle prospettive della libert�? Troppi libertari erroneamente legano la prognosi della libert� a quella di un movimento Conservatore apparentemente forte e in teoria alleato; questo legame fa si che sia facile comprendere il caratteristico pessimismo di lungo periodo del Libertario moderno. Ma questo scritto sostiene che, mentre le prospettive di breve periodo all�interno e all�estero possono sembrare scarse, l�attitudine adatta per il Libertario � quella di un inestinguibile ottimismo di lungo periodo.
La ragione di questa affermazione si basa su una certa visione della storia che ritiene, per prima cosa, che nell�Europa occidentale prima del diciottesimo secolo esistesse (e ancora continua ad esistere al di fuori dell�occidente) un Vecchio Ordine ben identificabile. Sia che il Vecchio Ordine prendesse la forma del feudalesimo o del dispotismo Orientale, era segnato dalla tirannia, dallo sfruttamento, dalla stagnazione, da caste immutabili, dalla disperazione e dall�inedia per la massa della popolazione. In definitiva, la vita era �povera, bestiale e breve�; Ecco la �societ� per ceti� di Maine e la �societ� militare� di Spencer. Le classi dominanti, o caste, governavano per conquista e portavano le masse a credere in un presunto imprimatur divino al loro comando.
Il Vecchio Ordine era, ed � ancora, il grande e potente nemico della libert�; ed era particolarmente forte nel passato perch� non vi era alcuna certezza circa il suo rovesciamento. Quando noi consideriamo che fondamentalmente il Vecchio Ordine � esistito sin dagli albori della storia, in tutte le civilt�, possiamo apprezzare ancora di pi� la gloria e la magnificenza del trionfo della rivoluzione liberale del diciottesimo secolo.
Parte della dimensione di questa lotta � stata oscurata da un grande mito della storia dell�Europa occidentale inculcato dagli storici illiberali tedeschi alla fine del diciannovesimo secolo. Il mito sosteneva che la crescita delle monarchie assolute e del mercantilismo nella prima et� moderna fu necessaria per lo sviluppo del capitalismo, dal momento che questo serv� a liberare i mercanti e il popolo da restrizioni feudali locali. In realt�, le cose non stavano affatto cos�; il re con il suo Stato nazione fu piuttosto un supremo signore sovra-feudale che reimpose e rinforz� il feudalesimo nel momento stesso in cui si stava dissolvendo grazie alla crescita pacifica dell�economia di mercato. Il re sovrappose le sue proprie restrizioni e i privilegi monopolistici a quelli del regime feudale. I monarchi assoluti erano il Vecchio Ordine con ampio mandato e ancora pi� dispotico di prima. Il capitalismo, ovviamente, fior� prima e pi� attivamente proprio in quelle aree in cui lo Stato centralizzato era debole o inesistente: le citt� italiane, la Lega Anseatica, la confederazione olandese del diciassettesimo secolo. Finalmente il Vecchio Ordine fu rovesciato o gravemente scosso nel suo dominio in due modi. Uno attraverso l�industria e l�espansione del mercato negli interstizi dell�ordine feudale (per esempio, l�industria che in Inghilterra si sviluppava nelle campagne al l� della morsa delle restrizioni feudali, statali e delle corporazioni). Pi� importante fu una serie di rivoluzioni catastrofiche che distrussero il Vecchio Ordine e le vecchie classi dominanti: le Rivoluzioni inglesi del diciassettesimo secolo, la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese, le quali furono tutte necessarie per l�inizio della Rivoluzione Industriale e delle quanto meno parziali vittorie della libert� individuale, del laissez faire, della separazione tra stato e chiesa e della pace internazionale. La societ� per ceti cedette il passo, almeno in parte, alla �societ� del contratto�; la societ� militare cedette parzialmente il passo alla �societ� industriale�. La massa della popolazione ottenne mobilit� di lavoro e di spazio ed un�espansione accelerata del suo livello di vita, cosa per la quale aveva osato sperare ben poco. Il liberalismo aveva certamente portato al mondo occidentale non solo la libert�, la speranza della pace e l�innalzamento dello stile di vita di una societ� industriale ma, forse soprattutto, port� la speranza, speranza in un progresso sempre pi� grande che sollevasse la massa del genere umano dal suo vecchio tunnel di stagnazione e disperazione.
Ben presto nell�Europa occidentale si svilupparono due grandi ideologie politiche, incentrate su questo nuovo fenomeno rivoluzionario: una fu il liberalismo, il partito della speranza, del radicalismo, della libert�, della Rivoluzione Industriale, del progresso, dell�umanit�; l�altra fu il conservatorismo, il partito della reazione, il partito che desiderava restaurare la gerarchia, lo statalismo, la teocrazia, la schiavit� e lo sfruttamento di classe tipici del Vecchio Ordine. Dal momento che il liberalismo aveva chiaramente la ragione dalla sua, i Conservatori ottenebrarono l�atmosfera ideologica con richiami oscurantisti al romanticismo, alla tradizione, alla teocrazia e all�irrazionalismo. Le ideologie politiche furono polarizzate, con il liberalismo all�estrema �sinistra� e il conservatorismo all�estrema �destra� dello spettro ideologico. Che il liberalismo genuino fosse essenzialmente radicale e rivoluzionario fu brillantemente percepito, al crepuscolo del suo impatto, dal grande Lord Acton (una delle poche figure della storia del pensiero che, in modo affascinante, diveniva pi� radicale man mano che invecchiava). Acton scrisse che �il liberalismo desidera ci� che dovrebbe essere, senza considerare ci� che �. Nell�elaborare questa visione, per inciso, fu Acton, non Trotsky, che per primo giunse al concetto di �rivoluzione permanente�. Come Gertrude Himmelfarb ha scritto nel suo eccellente studio su Acton:
la sua filosofia si svilupp� sino al punto in cui il futuro fu visto come il nemico dichiarato del passato, e in cui al passato non fu concessa alcuna autorit� tranne nel caso in cui si fosse conformato alla moralit�. Prendere seriamente questa teoria Liberale della storia, dare la precedenza a �ci� che dovrebbe essere� rispetto a �ci� che � fu, egli ammise, instaurare virtualmente una �rivoluzione permanente�.
La �rivoluzione permanente�, come Acton lasci� intendere nella lezione inaugurale e come ammise apertamente nelle sue note, fu il culmine della sua filosofia della storia e della sua teoria politica [..] . Questa idea di coscienza, cio� a dire che gli uomini portino con s� la conoscenza di ci� che � bene e di ci� che � male, � la vera radice della rivoluzione, perch� essa distrugge la sacralit� del passato [..]. �Il liberalismo � essenzialmente rivoluzionario�, ha osservato Acton. �I fatti devono arrendersi alle idee. Se possibile in maniera pacifica e con pazienza. Altrimenti in maniera violenta. [1]
Il liberale, ha scritto Acton, super� di gran lunga il Whig:
Il Whig ha governato attraverso il compromesso. Il liberale ha dato inizio al regno delle idee. [..] Uno � pratico, gradualista, pronto al compromesso. L�altro elabora un principio filosoficamente. Uno � un politico che mira ad una filosofia. L�altro � un filosofo che persegue una politica. [2]
Cosa accadde al liberalismo? Perch� declin� nel corso del diciannovesimo secolo? Su tale questione si � riflettuto molte volte, ma forse la ragione di fondo fu una malattia intrinseca alle parti vitali dello stesso liberalismo. Dal momento che, con il parziale successo della Rivoluzione Liberale in Occidente, i Liberali abbandonarono sempre pi� il loro fervore radicale e, di conseguenza, i loro obiettivi liberali, per accontentarsi della mera difesa di uno status quo prosaico e insufficiente. E� possibile individuare due radici filosofiche di questa decadenza. Per prima cosa l�abbandono della teoria dei diritti naturali e di una �legge superiore� a favore dell�utilitarismo, dal momento che solamente una teoria dei diritti naturali o di una legge superiore possono fornire una base radicale al di fuori del sistema esistente dalla quale sfidare lo status quo; e solo questa teoria fornisce un senso di necessaria immediatezza alla lotta libertaria focalizzando la necessit� di condurre i governanti criminali sul banco degli accusati. Gli Utilitaristi, dall�altro lato, abbandonando la giustizia per l�utilit�, abbandonarono pure l�immediatezza per una quieta stasi ed inevitabilmente finirono con il diventare gli apologeti dello stato di cose esistenti.
La seconda grande influenza filosofica che incise sul declino del liberalismo fu l�evoluzionismo, o Darwinismo Sociale, che diede i colpi finali al liberalismo come forza radicale nella societ�. Dal momento che i Darwinisti Sociali erroneamente videro la storia e la societ� attraverso i pacifici e rosei occhiali di un�evoluzione sociale infinitamente lenta e infinitamente graduale. Ignorando il fatto fondamentale che nella storia nessuna classe al potere ha mai volontariamente ceduto il suo potere, e che, perci� il liberalismo � stato costretto a fare irruzione attraverso una serie di rivoluzioni, il Darwinista Sociale si � messo ad aspettare pazientemente e allegramente migliaia di anni di evoluzioni infinitamente graduali fino al supposto prossimo stadio di individualismo.
Un interessante esempio di pensatore che rappresenta il declino del liberalismo nel diciannovesimo secolo � Herbert Spencer. Spencer inizi� come liberale magnificamente radicale, virtualmente un libertario puro. Ma, man mano che il virus della sociologia e del Darwinismo Sociale si impadronirono della sua anima, Spencer abbandon� il libertarismo come movimento storicamente dinamico, sebbene all�inizio senza abbandonarne la pura teoria. In breve, mentre guardava ad un eventuale ideale di libert� pura, Spencer inizi� a vedere la vittoria come inevitabile, ma solo dopo millenni di graduale evoluzione, e cos�, nella realt� dei fatti, Spencer abbandon� il liberalismo come credo radicale e combattente e in pratica confin� il suo liberalismo ad una fiacca azione di retrovia contro la crescita del collettivismo della fine del diciannovesimo secolo. In modo piuttosto interessante il fiacco viraggio strategico �a destra� di Spencer divenne immediatamente un viraggio a destra anche nella teoria, esemplificato dal ripudio del famoso capitolo della Statica sociale, Il diritto di ignorare lo Stato.
Agli inizi del diciannovesimo secolo in Inghilterra, i liberali classici iniziarono il loro spostamento dal radicalismo ad un semi conservatorismo; una conferma di questo spostamento fu l�atteggiamento generale dei liberali britannici nei confronti della lotta di liberazione nazionale in Irlanda. Questa lotta aveva un duplice aspetto: contro l�imperialismo politico britannico e contro il potere feudale imposto da quell�imperialismo. I liberali britannici, a causa della loro cecit� Tory verso la spinta irlandese all�indipendenza nazionale e, specialmente, per il diritto di propriet� degli agricoltori contro l�oppressione feudale, divennero simbolo del loro effettivo abbandono dell�autentico liberalismo, che era nato virtualmente dalla lotta contro il sistema terriero feudale. Solo negli Stati Uniti, la grande casa del liberalismo radicale (dove il feudalesimo non era mai riuscito a mettere radici al di fuori del Sud), i diritti naturali, la teoria di una legge superiore ed i conseguenti movimenti liberali radicali, continuarono ad essere preminenti fino alla met� del diciannovesimo secolo. Nelle loro differenti modalit�, i movimenti Jacksoniani ed Abolizionisti furono gli ultimi potenti movimenti libertari nella vita americana. [3]
Perci�, con il liberalismo abbandonato dall�interno, non vi era pi� un partito della speranza nel mondo Occidentale, non pi� un movimento di �sinistra� a guidare la lotta contro lo Stato e contro i residui del vecchio ordine che ancora sopravvivevano. In questo vuoto creato dall�esaurirsi del liberalismo radicale, si inser� un nuovo movimento: il socialismo. I libertari del giorno d�oggi sono abituati a ritenere che il socialismo sia l�esatto opposto del credo libertario. Ma questo � un grave errore, responsabile del profondo disorientamento ideologico dei libertari di oggi. Come abbiamo visto, il conservatorismo era l�esatto opposto della libert�; ed il socialismo, pur collocandosi alla �sinistra� del conservatorismo, era essenzialmente un movimento confuso, a met� strada. Esso era, ed � ancora, a met� strada perch� tenta di raggiungere fini liberali usando mezzi conservatori.
In breve, Russel Kirk, che sostiene che il socialismo sia l�erede del liberalismo classico e Ronald Hamowy, che vede il socialismo come l�erede del conservatorismo, hanno entrambi ragione; poich� il problema sorge a seconda che esaminiamo un aspetto o l�altro di questo confuso movimento centrista. Il socialismo, come il liberalismo e contro il conservatorismo, accett� il sistema industriale e gli obiettivi liberali di libert�, ragione, mobilit�, progresso, pi� alti livelli di vita per le masse, la fine della teocrazia e della guerra; ma cerc� di raggiungere questi fini attraverso l�uso di incompatibili mezzi conservatori: statalismo, pianificazione centralizzata, comunitarismo, ecc. O piuttosto, per essere pi� precisi, vi erano fin dall�inizio due diverse tendenze all�interno del socialismo: una era la corrente autoritaria di destra che da Saint Simon in avanti glorificava lo statalismo, la gerarchia e il collettivismo e che era perci� una proiezione del tentativo del conservatorismo di accettare e dominare la nuova civilt� industriale. L�altra era la tendenza di sinistra, relativamente libertaria, esemplificata in modo diverso da Marx e da Bakunin, rivoluzionaria e molto pi� interessata a raggiungere le finalit� libertarie del liberalismo e del socialismo; ma, specialmente, a realizzare lo sgretolamento dell�apparato statale per realizzare la �cancellazione dello Stato� e la �fine dello sfruttamento dell�uomo da parte dell�uomo�. In maniera abbastanza interessante, la caratteristica frase marxiana, la �sostituzione del governo degli uomini con l�amministrazione delle cose� pu� essere ritrovata, per via indiretta, a partire dai grandi liberali francesi dell�inizio del diciannovesimo secolo Charles Comte (nessuna relazione con Auguste Comte) e Charles Dunoyer. E cos�, anche per quanto riguarda il concetto di �lotta di classe�; ad eccezione del fatto che per Dunoyer e per Comte le classi essenzialmente antitetiche non erano gli uomini di affari contro i lavoratori, ma i produttori nella societ� (inclusi i liberi uomini di affari, i lavoratori, gli agricoltori, ecc.) contro le classi sfruttatrici costituite e privilegiate dall�apparato dello Stato. [4] Una volta, nella sua vita confusa e caotica, Saint Simon si trov� vicino a Comte e Dunoyer e trasse da loro la sua analisi di classe mescolando il tutto alla sua maniera e trasformando gli uomini di affari del mercato in �sfruttatori�, unendoli ai proprietari terrieri feudali e ad altri tra i privilegiati dello Stato. Marx e Bakunin ripresero questo dai sansimoniani e il risultato fu di sviare gravemente l�intero movimento della sinistra socialista; poich� allora, in aggiunta alla distruzione dello Stato repressivo, diventava necessario eliminare la propriet� privata capitalista dei mezzi di produzione. Rifiutando la propriet� privata, specialmente del capitale, i socialisti di sinistra si trovarono intrappolati in una cruciale contraddizione interna: se lo Stato deve scomparire dopo la rivoluzione (immediatamente per Bakunin, �svanendo� gradualmente per Marx), allora come far� il �collettivo� ad amministrare la sua propriet� senza divenire esso stesso un enorme Stato di fatto, pur non essendolo nel nome? Questa era una contraddizione che n� i marxisti n� i Bakunisti riuscirono mai a risolvere.
Avendo sostituito il liberalismo radicale come partito della �sinistra�, il socialismo al volgere del ventesimo secolo, cadde preda delle sue contraddizioni interne. Molti socialisti (Fabiani, Lassalliani, persino Marxisti) si volsero decisamente a destra, abbandonarono completamente i vecchi obiettivi libertari e gli ideali di rivoluzione e di cancellazione dello Stato e divennero dei comodi conservatori permanentemente riconciliati con lo Stato, lo status quo e con l�intero apparato del neo-mercantilismo, del capitalismo monopolistico dello Stato, dell�imperialismo e della guerra che si stava rapidamente stabilendo e consolidando nella societ� europea all�inizio del ventesimo secolo. Anche il conservatorismo nel tentativo di confrontarsi con un moderno sistema industriale si era riformato e riorganizzato ed era divenuto un mercantilismo rimesso a nuovo, un regime di statalismo, caratterizzato da privilegi monopolistici di Stato, intesi a favorire, in forme dirette e indirette, capitalisti e proprietari terrieri quasi feudali. L�affinit� tra socialismo di destra e nuovo conservatorismo divenne molto stretta, con il primo che mirava a politiche simili ma con una venatura di populismo demagogico. Cos�, l�altra faccia della medaglia dell�imperialismo era �l�imperialismo sociale�, che Joseph Schumpeter defin� chiaramente come �un imperialismo in cui gli imprenditori ed altri elementi corteggiano i lavoratori per mezzo di concessioni di politica sociale che sembrano dipendere dal successo dell�export monopolistico�. [5]
Gli storici hanno da tempo riconosciuto l�affinit�, e la saldatura del socialismo di destra con il conservatorismo in Italia e in Germania dove la fusione fu rappresentata prima dal Bismarkismo e quindi dal fascismo e dal nazionalsocialismo, quest�ultimo inteso a realizzare il programma Conservatore di nazionalismo, imperialismo, teocrazia ed un collettivismo di destra che conservava e persino consolidava il dominio delle vecchie classi privilegiate. Ma solo di recente gli storici hanno cominciato a rendersi conto che il medesimo percorso si verifico sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Perci� Bernard Semmel nella sua brillante storia del movimento social-imperialista in Inghilterra agli inizi del ventesimo secolo, mostra come la Societ� Fabiana abbia accolto con favore il sorgere dell�imperialismo in Inghilterra. [6] Quando alla met� dell�ultimo decennio del diciannovesimo secolo il Partito Liberale in Inghilterra si divise tra radicali a sinistra e liberal-imperialisti a destra, Beatrice Webb [7], co-leader dei Fabiani, denunci� i radicali come �seguaci del laissez faire e anti imperialisti�, definendo invece i secondi come �collettivisti e imperialisti�. Un manifesto ufficiale Fabiano, Fabianism and the Empire (1900), scritto da George Bernard Shaw [8] (che pi� tardi, con perfetta coerenza, apprezz� le politiche interne di Stalin e di Mussolini e di Sir Oswald Mosley [9]), lodava l�imperialismo ed attaccava i radicali, che �ancora restavano attaccati alle immobili frontiere ideali del repubblicanesimo idealista [e] della non interferenza�. Al contrario, �una Grande Potenza [..] deve governare (un impero mondiale) nell�interesse della civilt� nella sua interezza�. Dopo di ci� i fabiani collaborarono strettamente con i Tories e i liberal-imperialisti. Infatti, alla fine del 1902, Sidney[10] e Beatrice Webb costituirono un piccolo gruppo segreto di pensatori, chiamato The Coefficients; come scrisse in maniera rivelatrice uno dei membri pi� influenti di questo club, l�imperialista Tory Leopold S. Amery,:
Sidney e Beatrice Webb erano molto pi� interessati che fossero messe in pratica le loro idee sul welfare state da chiunque fosse pronto ad aiutarli, anche nel modo pi� modesto, che ad un prossimo trionfo di un partito apertamente Socialista. [..] Non vi era, dopo tutto, niente di cos� innaturale, come la stessa carriera di [Joseph] Chamberlain ha dimostrato, in una combinazione di Imperialismo negli affari esteri con un socialismo municipale o semi-socialismo in patria. [11]
Altri membri dei coefficienti che, come scrisse Amery, dovevano funzionare come �sindacato di cervelli o dirigenza generale� per il movimento, erano: il liberal-imperialista Richard B. Haldane; il geopolitico Halford J. Mackinder; l�imperialista e germanofobo Leopold Maxse, editore della <<National Review>>; il socialista e imperialista Tory Visconte Milner; l�imperialista navale Carlyon Bellairs; il famoso giornalista J. L. Garvin; Bernard Shaw; Sir Clinton Dawkins, socio della banca Morgan e Sir Edward Grey, che, ad un raduno del club, per primo adombr� la politica di intesa con Francia e Russia che si realizzer� nella Prima Guerra Mondiale. [12]
Durante la Prima Guerra Mondiale il famoso tradimento dei vecchi ideali del pacifismo rivoluzionario da parte dei socialisti europei, e persino da parte dei marxisti, non avrebbe dovuto destare sorpresa alcuna; il fatto che ciascun partito socialista appoggiasse il �proprio� governo nazionale nella guerra (con l�apprezzabile eccezione del partito socialista di Eugene Victor Debs [13] negli Stati Uniti) fu la concretizzazione finale del collasso della sinistra socialista classica. Da quel momento in poi, Socialisti o quasi Socialisti si unirono ai Conservatori in una amalgama di base, che accettava lo Stato e l�economia mista (= neo-mercantilismo = welfare state = interventismo = capitalismo monopolistico di Stato = puri sinonimi di una stessa realt� di fondo). Fu per reazione a questo collasso che Lenin ruppe con la Seconda Internazionale per ristabilire il marxismo rivoluzionario classico in una rinascita del socialismo di sinistra.
In realt� Lenin, quasi senza rendersene conto, fece pi� di questo. Si ritiene comunemente che i movimenti �purificatori�, ansiosi di tornare alla purezza classica indebolita da recenti corruzioni, generalmente, nella loro opera purificatrice, vadano oltre rispetto a quanto ritenuto corretto dalle fonti classiche. Vi erano, infatti, delle venature decisamente �conservatrici� negli scritti degli stessi Marx ed Engels i quali spesso giustificavano lo Stato, l�imperialismo occidentale ed il nazionalismo aggressivo e furono queste motivazioni, nelle ambivalenti opinioni dei maestri di questo argomento, che alimentarono pi� tardi lo spostamento della maggioranza dei marxisti nel campo �social-imperialista�. [14] La posizione di Lenin si volse pi� a sinistra rispetto a quella degli stessi Marx ed Engels. Lenin aveva una posizione decisamente pi� rivoluzionaria nei confronti dello Stato, difendeva e sosteneva, coerentemente, i movimenti di liberazione nazionale contro l�imperialismo. La tendenza Leninista era pi� a �sinistra� anche sotto altri punti di vista. Mentre Marx aveva concentrato il suo attacco contro il mercato capitalista in s�, la maggiore preoccupazione di Lenin era rivolta verso quello che considerava il livello pi� alto del capitalismo: imperialismo e monopolio. Di qui il fatto che Lenin, concentrandosi come fece in pratica sul monopolio di Stato e sull�imperialismo piuttosto che sul capitalismo di laissez faire, risult� molto pi� congeniale ai Libertari di quanto non fu Carlo Marx.
Il Fascismo e il Nazismo rappresentarono il culmine in politica interna della moderna spinta verso il collettivismo di destra. E� diventato normale tra i libertari, cos� come presso l�Establishment dell�Occidente, considerare il fascismo e il comunismo come fondamentalmente identici. Ma mentre ambedue i sistemi erano indubbiamente collettivisti, essi differivano parecchio nel loro contenuto socio economico. Il comunismo era un autentico movimento rivoluzionario che senza remora alcuna disperdeva e distruggeva le vecchie �lites di potere, mentre il fascismo, al contrario, rafforzava nel loro potere le vecchie classi dirigenti. Di conseguenza il fascismo era un movimento controrivoluzionario che congelava un complesso di privilegi monopolistici nella societ�; in breve il fascismo rappresentava l�apoteosi del moderno capitalismo monopolistico di Stato. [15] Da qui deriv� il motivo per cui il fascismo apparve, apertamente e senza riserve negli anni �20 e agli inizi degli anni �30, cos� attraente agli interessi del big business in Occidente (cosa che, naturalmente, non accadde mai al comunismo). [16]
Siamo ora in grado di applicare la nostra analisi allo scenario americano. Nella recente storia americana incontriamo un mito controverso che � stato diffuso dagli attuali conservatori e adottato dalla maggior parte dei libertari americani. Tale mito dice approssimativamente quanto segue: l�America era, pi� o meno, un paradiso di laissez faire fino al New Deal; quindi Roosevelt, influenzato da Felix Frankfurter [17], dalla Intercollegiate Socialist Society e da altri �cospiratori� �Fabiani� e comunisti, mise in moto una rivoluzione che port� l�America sulla strada del socialismo e che, pi� avanti oltre l�orizzonte, arriver� al comunismo. Il libertario del giorno d�oggi che adotta questa, o una simile visione, dell�esperienza americana tende a vedere se stesso come appartenente ad una �estrema destra�; leggermente alla sua sinistra sta il conservatore, alla cui sinistra stanno i centristi, e quindi ancora pi� verso sinistra si trovano il socialismo e il comunismo. Di qui l�enorme tentazione per i libertari di farsi attrarre dall�esca rossa; poich�, vedendo l�America scivolare inesorabilmente a sinistra, prima verso il socialismo e in seguito verso il comunismo, sono tentati di saltare gli stadi intermedi e imbrattare tutta la loro opposizione con l�odiato pennello rosso.
Si potrebbe pensare che il �Libertario di destra� sia ben presto in grado di vedere alcune gravi manchevolezze in questa concezione. Intanto, l�emendamento alla tassa sul reddito [18], che egli deplora come l�inizio del socialismo in America, fu approvato dal Congresso nel 1909 con una schiacciante maggioranza di ambedue i partiti. Guardare questo evento come un deciso spostamento verso il socialismo vorrebbe dire considerare il presidente William Howard Taft, che aveva proposto il Sedicesimo emendamento, come un uomo di sinistra, e certamente pochi avrebbero l�ardire di farlo. Infatti, il New Deal non fu assolutamente una rivoluzione; il suo intero programma collettivista era gi� stato anticipato: in tempi pi� vicini da Herbert Hoover durante la depressione e, ancora prima, dal collettivismo di guerra e dalla pianificazione centralizzata che aveva governato l�America durante la Prima Guerra Mondiale. Ogni elemento del programma del New Deal: pianificazione centralizzata, creazione di una rete di cartelli obbligatori nell�industria e nell�agricoltura, inflazione ed espansione del credito, aumento artificiale dei salari e sostegno ai sindacati all�interno di una sovrastante struttura monopolizzata, regolamentazione e propriet� governativa, tutto ci� era stato anticipato e adombrato durante i due decenni precedenti. [19] E questo programma con il suo privilegiare vari interessi del big business al vertice della struttura collettivista non era in alcun modo vicino al socialismo o alla sinistra; non vi era nulla qui che sapesse di ugualitario o di proletario. No, la parentela di questo crescente collettivismo non era affatto con il socialismo-comunismo ma con il fascismo, o socialismo di destra, una parentela che molti grandi affaristi degli anni venti espressero apertamente nel loro desiderio di abbandonare un sistema di quasi laissez faire per un collettivismo che essi avrebbero potuto controllare. E certamente William Howard Taft, Woodrow Wilson e Herbert Clark Hoover sono figure molto pi� verosimili come proto-fascisti che come cripto-comunisti.
Il movimento leninista agli inizi degli anni trenta comprese l�essenza del New Deal molto pi� chiaramente rispetto alla mitologia conservatrice; questo fino alla met� degli anni trenta, quando le esigenze della politica estera sovietica determinarono un netto cambiamento della tendenza del mondo comunista e l�approvazione del New Deal da parte del Fronte Popolare. Cos�, nel 1934, il teorico leninista britannico R. Palme Dutt pubblic� una breve ma acuta analisi del New Deal come �fascismo sociale� � come l�essenza del fascismo ammantata da una leggera vernice di demagogia populista. Nessun oppositore conservatore ha mai sviluppato una denuncia pi� vigorosa o decisa del New Deal. La politica di Roosevelt, scriveva Dutt, consisteva nel �muovere verso una forma di dittatura di tipo bellico�; le politiche di base consistevano nell�imporre un capitalismo monopolistico di Stato attraverso la N.R.A. [20], nel fornire sussidi all�industria, alle banche e all�agricoltura attraverso l�inflazione e la parziale espropriazione della massa del popolo, con livelli salariali reali pi� bassi e tramite la regolamentazione e lo sfruttamento del lavoro con l�imposizione di salari e arbitrati obbligatori. Dutt scriveva che quando al New Deal si toglie il �travestimento progressista e social riformista�, �rimane la realt� di un nuovo capitalismo di Stato di tipo fascista accomodante nei confronti dell�industria�, compresa un implicita �tendenza alla guerra�. Dutt concludeva in maniera efficace con la citazione del redattore del prestigiosissimo <<Current History Magazine>>:
La nuova America [il redattore scriveva nel 1933] non sar� capitalista nel vecchio senso della parola, n� sar� socialista. Se al momento la tendenza � verso il fascismo, si tratter� di un fascismo americano, che incarner� l�esperienza, le tradizioni, le speranze di una nazione dal grande ceto medio.[21]
Cos� il New Deal non rappresentava una frattura qualitativa con il passato americano, al contrario, si trattava di una estensione puramente quantitativa della rete di privilegi di Stato che era stata proposta e realizzata in precedenza: nell�amministrazione Hoover, nel collettivismo bellico della Prima Guerra Mondiale e nell�Era Progressista. Nella brillante opera del Dottor Grabriel Kolko si pu� trovare la pi� esauriente esposizione delle origini del capitalismo monopolistico di Stato, o di ci� che egli chiama �capitalismo politico� negli Stati Uniti. In The Triumph of Conservatism Kolko rintraccia le origini del capitalismo politico nelle �riforme� dell�era progressista. Gli storici ortodossi hanno sempre trattato il periodo progressista (all�incirca dal 1900 al 1916) come un periodo in cui il capitalismo di libero mercato stava diventando sempre pi� �monopolistico�; come reazione a questo regno del monopolio e degli affari, intellettuali altruisti e politici lungimiranti guardarono all�intervento da parte del governo come mezzo per riformare e regolamentare questi aspetti negativi. La grande opera di Kolko dimostra che la realt� era quasi esattamente il contrario di questa credenza. Kolko mette in evidenza che nonostante l�ondata di concentrazioni e di accordi che si formarono all�inizio del secolo le forze della competizione del libero mercato indebolirono e dissolsero rapidamente questi tentativi di stabilizzare e perpetuare la potenza dei grossi interessi economici. Fu precisamente come reazione alla sua incombente sconfitta per mano degli attacchi competitivi del mercato che la grande industria si volse, in misura sempre maggiore dopo il 1900, al governo federale per aiuto e protezione. In breve l�intervento del governo federale era inteso non a ridurre il monopolio della grande industria nell�interesse pubblico, ma a creare monopoli (come pure associazioni di imprese pi� piccole) che le grandi imprese non erano state in grado di realizzare a causa della tempesta competitiva del libero mercato. Tanto la sinistra quanto la destra sono state tratte in inganno dall�idea secondo cui l�intervento dello Stato sia ipso facto di sinistra e contro gli imprenditori. Di qui il mito, endemico nella destra, del New Fear Deal Rosso. Tanto i grossi industriali, guidati dagli interessi dei Morgan, quanto il professor Kolko, quasi unico nel mondo accademico, si sono resi conto del fatto che i privilegi monopolistici possono essere creati solo dallo Stato e non possono essere il risultato di operazioni di libero mercato.
Cos� Kolko dimostra che, a cominciare dal Nuovo Nazionalismo di Teodoro Roosevelt e culminando nella Nuova Libert� di Wilson, in un�industria dopo l�altra, per esempio assicurazioni, banche, mercato della carne, esportazione ed affari in generale, le regolamentazioni che la destra del giorno d�oggi considera �socialiste� non furono soltanto unanimemente sostenute ma concepite e realizzate dai grandi affaristi. Questo era uno sforzo consapevole teso ad ingabbiare l�economia con elargizione di sussidi, stabilit� e privilegi monopolistici. Una visione tipica era quella di Andrew Carnegie; molto preoccupato per la concorrenza nell�industria dell�acciaio che, n� la nascita della U.S. Steel n� le famose �Serate Gary� sponsorizzate dall�impresa Morgan riuscivano ad attenuare, dichiar� nel 1908, �mi torna sempre in mente che il controllo governativo, e questo solo, potr� correttamente risolvere il problema�. Non vi � nulla di allarmante in s� nella regolamentazione governativa, sosteneva Carnegie, �il capitale � perfettamente al sicuro nell�azienda del gas, sebbene sia sotto il controllo del tribunale. Cos� sar� per ogni altro capitale, anche se sotto il controllo del governo�.[22]
Kolko dimostra che il Partito Progressista era sostanzialmente un partito creato dalla Morgan per rieleggere Roosevelt e punire il presidente Taft che era stato troppo zelante nel perseguire le imprese Morgan, mentre i sindacalisti di sinistra fornivano spesso involontariamente una copertura demagogica ad un movimento conservatore e statalista. La New Freedom di Wilson[23], culminante nella creazione della Federal Trade Commission, lungi dall�essere considerata pericolosamente socialista dai grandi industriali, fu accolta entusiasticamente in quanto poneva in essere il loro programma, a lungo desiderato, di sostegno, privilegio e regolamentazione della concorrenza (e il collettivismo bellico di Wilson fu accolto persino pi� entusiasticamente). Edward N. Hurley, presidente della Federal Trade Commission e in precedenza presidente dell�Associazione degli Industriali dell�Illinois, alla fine del 1915 annunci� con gioia che la Federal Trade Commission era finalizzata �all�interesse degli affari in generale�, la stessa cosa valeva per la ICC nei confronti delle ferrovie e dei cantieri navali, la stessa cosa faceva la Federal Reserve per i banchieri della nazione e il Dipartimento dell�Agricoltura per gli agricoltori. [24] Come sarebbe avvenuto in maniera pi� drastica nel fascismo europeo, ogni gruppo di interessi economici era organizzato secondo cartelli e monopoli e sistemato nella sua nicchia privilegiata in una struttura socioeconomicamente ordinata. Particolarmente influenti erano le opinioni di Arthur Jerome Eddy, eminente avvocato che si era specializzato nella creazione di associazioni di commercio e che aveva aiutato la nascita della Federal Trade Commission. Nel suo magnum opus denunciando fieramente la concorrenza negli affari e invocando una �cooperazione� industriale controllata e protetta dal governo, Eddy proclamava che la �Concorrenza � Guerra e che la Guerra � l�Inferno�. [25]
Che dire degli intellettuali del periodo progressista condannati dalla destra del giorno d�oggi come �socialisti�? In un certo senso essi erano socialisti, ma socialisti di che genere? Il socialismo conservatore di Stato della Germania di Bismark, il prototipo di tante forme politiche moderne europee ed americane, e sotto la cui influenza la gran parte degli intellettuali americani della fine del diciannovesimo secolo ricevette la sua educazione superiore. Come scrive Kolko:
Il conservatorismo degli intellettuali contemporanei [..] l�idealizzazione dello Stato da parte di Lester Ward, Richard T. Ely o Simon N. Patten [..] furono anche il risultato della peculiare educazione di molte universit� americane di questo periodo. Alla fine del diciannovesimo secolo il mondo accademico esercitava una influenza sulla teoria sociale ed economica. Le migliaia di accademici di rilievo che avevano studiato nelle universit� tedesche negli anni ottanta e novanta dell�ottocento avevano ovviamente assorbito l�idealizzazione bismarkiana dello Stato, con le sue funzioni centralizzate di welfare. [26]
Per di pi� l�ideale dei pi� influenti professori tedeschi ultraconservatori, che erano anche chiamati �socialisti della cattedra�, era di divenire consapevolmente �la guardia del corpo intellettuale della casa degli Hohenzollern� � e sicuramente lo furono.
Come esempio di intellettuale progressista Kolko cita opportunamente Herbert Croly, direttore del <<New Republic>> finanziato da Morgan. Analizzando il nuovo nazionalismo di Theodore Roosevelt, Croly esaltava questo nuovo hamiltonismo come un sistema per il controllo collettivista federale e per l�integrazione della societ� in una struttura gerarchica. Guardando al futuro oltre l�Era Progressista, Gabriel Kolko conclude che:
Durante la guerra attraverso varie agenzie amministrative e di emergenza fu creata una sintesi tra economia e politica a livello federale, che continu� durante il decennio successivo. Certamente il periodo della guerra rappresenta il trionfo degli affari nel modo pi� eclatante [..] . La grande industria ottenne l�appoggio totale da parte di varie agenzie di regolamentazione e dell�esecutivo. Fu durante la guerra che divennero operativi un oligopolio effettivo e operativo, ed accordi sul prezzo e sul mercato in settori dominanti dell�economia americana. La rapida diffusione del potere nell�economia e l�ingresso relativamente facile vennero virtualmente a cessare. Nonostante la fine di importanti nuovi provvedimenti legislativi, l�unione della grande industria con il governo federale continu� durante gli anni venti e oltre, utilizzando le fondamenta gettate nell�Era Progressista per stabilizzare e consolidare le condizioni all�interno di varie industrie. [..] Il principio dell�utilizzo del governo federale per stabilizzare l�economia, iniziato nel contesto del moderno industrialismo durante l�Era Progressista, divenne la base del capitalismo politico nelle sue molte ramificazioni successive.
In questo senso il progressismo non mor� negli anni venti, ma divenne parte del tessuto di base della societ� americana. [27]
Questo dunque per quel che riguarda il New Deal. Dopo un breve periodo di ondeggiamento a sinistra a met� degli anni trenta, l�amministrazione Roosevelt ricement� la sua alleanza con la grande industria per la difesa nazionale e l�economia bellica che ebbe inizio nel 1940. Queste sono un�economia ed una politica che da allora hanno sempre retto l�America, rappresentate da una permanente economia di guerra, da un pieno capitalismo monopolistico di Stato e dal neomercantilismo, dal complesso militare industriale dei giorni nostri. Le caratteristiche essenziali della societ� americana non sono mutate da quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, questa � stata interamente militarizzata e politicizzata, ad eccezione del fatto che tale tendenza � venuta ad intensificarsi e persino nella vita di tutti i giorni gli uomini sono stati sempre pi� foggiati in obbedenti uomini dell�organizzazione al servizio dello Stato e del suo complesso militare industriale. William H. Whyte Jr. nel suo libro, giustamente famoso, The Organization Man, ha chiarito che questa manipolazione ebbe luogo in seguito all�adozione da parte della grande industria delle visioni collettiviste di sociologi e altri ingegneri sociali �illuminati�. E� anche chiaro che questa armonia di vedute non � solamente il frutto dell�ingenuit� degli imprenditori � certo non quando questa �ingenuit�� coincide con l�esigenza di comprimere il lavoratore e il manager nel modello di un servitore volonteroso all�interno della grande burocrazia della macchina militare-industriale. E, sotto la maschera della democrazia, l�istruzione � diventata una mera esercitazione scolastica di massa in tecniche di adattamento, allo scopo di diventare un ingranaggio della vasta macchina burocratica.
Contemporaneamente, i Repubblicani e i Democratici rimangono bipartisan nel formare e supportare questo establishment come lo erano stati nei primi due decenni del ventesimo secolo. La condiscendenza, il supporto bipartitico allo status quo che sta sotto alle superficiali differenze tra i partiti, non inizi� nel 1940.
Come reag� il residuo esercito di libertari a queste variazioni dello spettro ideologico in America? Si pu� trovare una risposta istruttiva guardando la carriera di uno dei grandi libertari dell�America del ventesimo secolo, Albert Jay Nock [28]. Negli anni venti, quando Nock elabor� la sua filosofia radical-libertaria, egli era universalmente considerato un membro dell�estrema sinistra e come tale si considerava. C�� sempre la tendenza nella vita politica e ideologica a concentrare la propria attenzione sul nemico principale del momento ed il nemico principale di allora era lo statalismo conservatore dell�amministrazione Coolidge-Hoover; fu naturale, perci�, per Nock, per il suo amico e collega libertario H. L. Mencken e per altri radicali unirsi ai semi-socialisti nella battaglia contro il nemico comune. Quando il New Deal successe ad Hoover i socialisti all�acqua di rose e gli interventisti vagamente di sinistra balzarono sul carro del New Deal; a sinistra solo i Libertari come Nock e Mencken ed i Leninisti (prima del periodo del Fronte Popolare) capirono che Roosevelt altro non era se non una continuazione di Hoover, sebbene con una retorica diversa. Fu perfettamente naturale per i radicali formare un fronte unico contro Roosevelt con i pi� vecchi conservatori Hoover e Al Smith i quali ritenevano o che Roosevelt fosse andato troppo lontano o non gradivano la sua fragorosa retorica populista. Ma il problema fu che Nock e i suoi colleghi radicali, sulle prime sdegnosi nei confronti dei nuovi alleati, ben presto iniziarono ad accettarli e perfino a indossare volentieri l�etichetta di �Conservatori� precedentemente disprezzata. Nei ranghi e nelle fila dei radicali questo spostamento si verific�, come � accaduto nella storia per molte trasformazioni di ideologie, inconsapevolmente e in mancanza di una leadership ideologica adatta; per Nock e in una certa misura anche per Mencken il problema incise molto pi� profondamente.
Questo dal momento che vi era sempre stata una grave manchevolezza nella brillante e raffinata dottrina libertaria messa a punto con differenti modalit� da Nock e da Mencken; entrambi erano incorsi a lungo nel grave errore del pessimismo. Entrambi non avevano alcuna speranza che la razza umana adottasse il sistema della libert�; disperando che la dottrina radicale della libert� avrebbe mai potuto essere applicata in pratica, ciascuno a modo suo si sottrasse alla responsabilit� di una leadership ideologica, Mencken gioiosamente ed edonisticamente, Nock in maniera riservata e segreta. Perci� nonostante l�importante contributo di ambedue questi uomini alla causa della libert�, nessuno dei due avrebbe mai potuto diventare leader consapevole di un movimento libertario, perch� nessuno dei due avrebbe potuto vedere il partito della libert� come il partito della speranza, il partito della rivoluzione, o a fortiori il partito di un messianismo secolare. L�errore del pessimismo � il primo passo verso la scivolosa strada in discesa che conduce al conservatorismo; e quindi fu fin troppo facile per il radicale pessimista Nock, sebbene ancora fondamentalmente un libertario, accettare l�etichetta di conservatore e pure ripetere il vecchio luogo comune che vi sia una presunzione a priori contro qualunque cambiamento sociale.
E� affascinante come Albert Jay Nock in questo modo abbia seguito il percorso ideologico del suo amato antenato spirituale Herbert Spencer, entrambi iniziarono come puri Libertari radicali, entrambi abbandonarono le tattiche radicali o rivoluzionarie rappresentate dalla volont� di mettere in pratica le loro teorie attraverso un�azione di massa, ambedue finirono per scivolare da tattiche Tory ad un conservatorismo parziale almeno nel contenuto.
E cos� i Libertari, specialmente per quel che riguarda la percezione della loro posizione nello spettro ideologico, si unirono a pi� vecchi Conservatori i quali furono costretti ad adottare una fraseologia libertaria (ma senza alcun reale contenuto libertario) opponendosi all�amministrazione Roosevelt che per loro era diventata troppo collettivista sia nel contenuto che nella retorica. La Seconda Guerra Mondiale rinforz� e cement� questa alleanza; poich�, al contrario di tutte le precedenti guerre americane del secolo, le forze pacifiste e �isolazioniste� furono tutte identificate, dai loro nemici e di conseguenza da loro stesse, come appartenenti alla �Destra�. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, divenne naturale per i libertari considerarsi come un polo di �estrema destra� con i Conservatori immediatamente alla propria sinistra; e di qui il grave errore di posizionamento che persiste ai giorni nostri. In particolare i moderni libertari hanno dimenticato o non hanno mai capito che l�opposizione alla guerra e al militarismo era sempre stata una tradizione di sinistra che aveva incluso i Libertari; e quindi quando l�aberrazione storica del periodo del New Deal si corresse e la �destra� divenne ancora una volta la grande partigiana della guerra totale, i Libertari si trovarono impreparati a capire che cosa stesse succedendo e si accodarono ai loro supposti �alleati� conservatori. I liberali avevano completamente perso le loro vecchie caratteristiche e le linee guida ideologiche.
Dato un giusto riorientamento dello spettro ideologico, quali sarebbero allora le prospettive della libert�? Non c�� da meravigliarsi che il Libertario contemporaneo, vedendo il mondo diventare socialista e comunista, e credendosi virtualmente isolato e tagliato fuori da ogni prospettiva di azione di massa unitaria, tenda a cadere in un pessimismo di lungo periodo. Ma la scena si illumina immediatamente nel momento in cui ci rendiamo conto che quell�indispensabile requisito della civilt� moderna, il rovesciamento dell�ancien regime, fu realizzato da un�azione libertaria di massa esplosa nelle grandi rivoluzioni dell�Occidente come le Rivoluzioni Francese e Americana, e che port� i successi della Rivoluzione Industriale e i progressi della libert�, la mobilit� e l�aumento del tenore di vita di cui godiamo ancora oggi. Nonostante il ritorno reazionario allo statalismo, il mondo moderno giganteggia sul mondo del passato. Quando consideriamo pure che, in una forma o in un�altra, il Vecchio Ordine del dispotismo, del feudalesimo, della teocrazia e del militarismo ha dominato ogni civilt� umana fino a quella Occidentale del diciottesimo secolo, l�ottimismo su ci� che l�uomo ha raggiunto e pu� raggiungere deve arrivare ancora pi� in alto.
Si pu� replicare, per�, che quell�oscuro periodo storico di dispotismo e stagnazione pu� soltanto rafforzare il pessimismo perch� dimostra la persistenza e la durata del Vecchio Ordine e l�apparente fragilit� ed evanescenza del Nuovo � specialmente alla luce della retrocessione del secolo passato. Ma questa analisi superficiale trascura il grande cambiamento che si � verificato con la rivoluzione del Nuovo Ordine, un cambiamento che � chiaramente irreversibile. Il Vecchio Ordine fu in grado di durare per secoli con il suo sistema di schiavit� proprio perch� non era in grado di risvegliare attese e speranze nelle menti delle masse soggiogate; il loro destino era quello di sopravvivere e di tirare avanti in una abbrutita esistenza di schiavit�, obbedendo ciecamente agli ordini di governanti designati per volont� divina. Ma la rivoluzione liberale impresse in maniera indelebile nelle menti delle masse, non solo in Occidente ma anche nel mondo sottosviluppato ancora sotto il dominio feudale, l�ardente desiderio della libert�, della terra per gli agricoltori, della pace tra le nazioni e, forse pi� di tutto, il desiderio della mobilit� e di un pi� alto livello di vita, cosa che pu� essere raggiunta solo con la civilt� industriale. Le masse non accetteranno mai nuovamente la cieca servit� del Vecchio Ordine; e date le aspirazioni risvegliate dal liberalismo e dalla Rivoluzione Industriale, la vittoria della libert� nel lungo periodo � inevitabile.
Poich� soltanto la libert�, soltanto un libero mercato, possono organizzare e mantenere un sistema industriale e man mano che la popolazione si espande e cresce, diviene sempre pi� necessario il lavoro senza restrizioni dell� economia industriale. Il laissez faire e il libero mercato diventano sempre pi� chiaramente necessari man mano che il sistema industriale si sviluppa; deviazioni radicali causano interruzioni e crisi economiche. Questa crisi dello statalismo diviene particolarmente drammatica e acuta in una societ� pienamente socialista; e di conseguenza l�inevitabile fallimento dello statalismo si � manifestato in maniera clamorosa per primo nei paesi dell�area socialista (cio� a dire comunista). Questo dal momento che il socialismo si confronta con le sue contraddizioni interne in maniera pi� netta. Esso tenta disperatamente di realizzare i suoi obiettivi dichiarati di crescita industriale, di migliori livelli di vita per le masse, di eventuale indebolimento dello Stato ed � sempre meno in grado di realizzare tutto questo con i suoi sistemi collettivisti. Da qui l�inevitabile fallimento del socialismo. Questo progressivo fallimento della pianificazione socialista fu all�inizio in parte trascurato. Infatti, i Leninisti non presero il potere in un evoluto paese capitalista come Marx aveva erroneamente predetto, ma in un paese che soffriva l�oppressione del feudalesimo. In secondo luogo i Comunisti, per molti anni dopo la presa del potere, non tentarono di imporre un�economia socialista; nella Russia sovietica questo non avvenne finch� la collettivizzazione forzata di Stalin agli inizi degli anni trenta rovesci� il buon senso della Nuova Politica Economica di Lenin che Bukharin, il teorico favorito di Lenin, avrebbe esteso fin verso un libero mercato. Persino gli arrabbiati leaders comunisti della Cina non imposero un�economia socialista al paese fino alla fine degli anni cinquanta. In ogni caso l�industrializzazione crescente ha portato una serie di fallimenti economici cos� gravi che i paesi comunisti, contro i loro principi ideologici, hanno dovuto ritirarsi passo dopo passo dalla pianificazione centrale e ritornare in forme e gradi diversi al libero mercato. Il Piano Liberman per l�Unione Sovietica si � guadagnato una grande pubblicit�; ma l�inevitabile processo di desocialistizzazione � andato molto pi� avanti in Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia. Pi� avanzata di tutti � la Yugoslavia che, liberatasi dalla rigidit� stalinista prima degli altri paesi socialisti, in solo una dozzina di anni si � desocialistizzata cos� in fretta che la sua economia ora non � molto pi� socialista di quella della Francia. Il fatto che persone che si definiscono �comuniste� siano ancora al governo del paese � irrilevante per i basilari fattori sociali ed economici. La pianificazione centralizzata in Yugoslavia � virtualmente scomparsa. Il settore privato � predominante non solo nell�agricoltura ma � forte persino nell�industria e lo stesso settore pubblico � stato radicalmente decentrato e posto sotto liberi prezzi, esperimenti di profitti e perdite, propriet� cooperativa dei lavoratori di ogni officina, tanto che difficilmente si pu� dire che esista ancora un vero socialismo. Per andare verso un completo capitalismo resta solo da compiere il passo finale di passare dal controllo esercitato dai lavoratori sulle singole aziende attraverso le organizzazioni sindacali al possesso di titoli individuali di propriet�. La Cina Comunista e gli abili teorici marxisti della <<Monthly Review>> hanno chiaramente compreso la situazione ed hanno lanciato l�allarme che la Yugoslavia non � pi� un paese socialista.
Si potrebbe pensare che gli economisti del libero mercato abbiano acclamato la conferma e la crescente rilevanza del notevole intuito del Professor Ludwig von Mises di mezzo secolo fa: che gli stati socialisti essendo necessariamente privi di un autentico sistema di prezzi, non avrebbero potuto procedere a calcoli economici e, perci�, non avrebbero potuto pianificare con alcun successo l�economia. In realt� un seguace di Mises alcuni anni fa predisse in un racconto questo processo di desocialistizzazione. Ma n� questo autore n� altri economisti liberali hanno dato la bench� minima indicazione n� il riconoscimento, per non parlare del benvenuto, di questo processo nei paesi comunisti, forse perch� la loro quasi isterica visione della minaccia comunista impedisce loro di riconoscere qualsiasi segnale di crollo nel supposto monolite minaccioso. [29]
I paesi Comunisti perci� sono sempre pi� inesorabilmente forzati a desocialistizzarsi e, quindi, eventualmente, a raggiungere il libero mercato. Lo stato dei paesi sottosviluppati � pure motivo di ottimismo per i libertari. Perch� in tutto il mondo i popoli delle nazioni sottosviluppate sono impegnati in rivoluzioni intese a rovesciare il Vecchio Ordine feudale. E� vero che gli Stati Uniti stanno facendo del loro meglio per sopprimere proprio il processo rivoluzionario che un tempo, unitamente all�Europa, li ha liberati dai ceppi del Vecchio Ordine; ma � sempre pi� chiaro che neppure una potenza armata pu� sopprimere il desiderio delle masse di irrompere nel mondo moderno.
Prendiamo ora in esame gli Stati Uniti e i paesi dell�Europa Occidentale. Qui il motivo per essere ottimisti � meno chiaro perch� il sistema quasi-collettivistico non presenta una crisi di contraddizione interna cos� decisa come il socialismo. Eppure anche qui crisi economiche si intravedono nel futuro e guadagnano terreno con la compiacenza dei dirigenti keynesiani dell�economia: inflazione strisciante, riflessa nell�aggravato dissesto della bilancia dei pagamenti del dollaro una volta molto forte; una strisciante disoccupazione prodotta dai livelli salariali minimi e dall�accumularsi delle pi� profonde distorsioni antieconomiche di lungo periodo della costante economia di guerra. Per di pi� le crisi potenziali negli Stati Uniti non sono puramente economiche; vi � un crescente fermento morale tra i giovani d�America contro le pastoie della burocrazia centralizzata, della uniforme educazione di massa e della brutalit� e dell�oppressione esercitate dai servitori dello Stato.
Inoltre, l�esistenza di una livello sostanziale di libert� di parola e di forme democratiche facilitano, almeno nel breve periodo, la possibile crescita di un movimento libertario. Gli Stati Uniti sono pure fortunati nel possedere, seppure in parte dimenticata sotto l�ordinamento statalista e tirannico dell�ultimo mezzo secolo, una grande tradizione di pensiero e di azione libertari. Lo stesso fatto che molto di questo retaggio si ancora riflesso nella retorica popolare, anche se privato in pratica del suo significato, fornisce un ricco terreno di coltura ideologico per un futuro partito della libert�.
Quelle che i marxisti chiamerebbero le �condizioni oggettive� per il trionfo della libert� esistono quindi ovunque nel mondo e pi� che in passato; perch� dovunque le masse hanno scelto migliori condizioni di vita e la promessa della libert� e dovunque i vari regimi di statalismo e collettivismo non sono in grado di realizzare questi obiettivi. Quel che � necessario, quindi, sono semplicemente le �condizioni soggettive� per la vittoria; cio� a dire, un numero crescente di libertari informati che diffonder� tra i popoli del mondo il messaggio che la libert� e il libero mercato sono la via d�uscita dai loro problemi e crisi. La libert� non potr� essere pienamente raggiunta finc