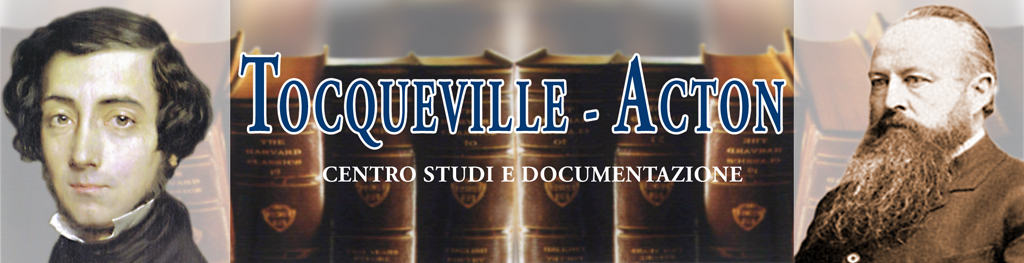
J�rgen Habermas. Il (mite?) agnosticismo di un laico �dialogante�
di Paolo Fornari
Pochi giorni fa J�rgen Habermas � tornato a parlare di fede e ragione, in occasione del convegno organizzato dalla Societ� Italiana di Filosofia Politica. Nel suo intervento, di cui Repubblica ha offerto un�anticipazione (Cfr. l�edizione del 12 settembre), il filosofo si � interrogato su quale possa essere il ruolo delle civilt� tradizionali nella postmodernit�. Di fronte ad una societ� globale in pieno fermento religioso, dice Habermas, la teoria �classica� della secolarizzazione � che descrive la modernizzazione nei termini di una progressiva e inesorabile laicizzazione delle coscienze � sembra essere radicalmente smentita, al punto da indurre diversi sociologi �revisionisti� ad accusarla di eurocentrismo. Ma il problema, osserva Habermas, deve essere re-impostato: non si tratta pi� tanto di sapere se la religione abbia perso o meno rilevanza sulla scena pubblica, quanto di confrontarsi con la presenza vitale e fattuale delle religioni in espansione e domandarsi sotto quali condizioni esse possano trovare cittadinanza nella cultura globale moderna.
Il classico binomio secolarizzazione/tradizione sembra non offrire pi� una comprensione adeguata della situazione contemporanea e la questione deve essere affrontata da una nuova prospettiva metodologica. Ma, in s�, la teoria della secolarizzazione non � ancora stata falsificata. In realt�, sostiene il filosofo di D�sseldorf, il crescente bisogno religioso nella societ� mondiale � adeguatamente spiegato dai �pi� elevati tassi di natalit� dei paesi in via di sviluppo, pi� poveri�. In altri termini, la rinnovata vitalit� religiosa � un fenomeno che interessa solo le fasce deboli della popolazione mondiale, quelle che, vivendo una situazione di profonda �insicurezza esistenziale�, non possono che ricorrere a dispensatori di certezze privati; il fatto poi che i credenti siano la maggioranza non ha in s� alcun valore epistemico, dato che � proprio delle culture non-sviluppate essere feconde. L�idea che la modernizzazione si attui nella secolarizzazione delle coscienze, rimane dunque ancora valida. Il problema � piuttosto come intendere tale secolarizzazione.
In effetti, secondo Habermas, le comunit� religiose, a prescindere dal loro peso numerico, possono ancora rivendicare un �posto� nelle societ� moderne, e contribuire alla formazione dell�opinione e della volont� pubbliche, anche su �questioni controverse�, come l�eutanasia, l�aborto o la fecondazione assistita. � vero che la rete globale tende ad imporre ovunque i propri modelli omologanti (tecnocratici, burocratici e capitalistici), ma � altrettanto vero che la recezione di questi stimoli avviene sempre in un rapporto di tensione dialettica con le culture locali. E ci� perch�, come osserva Eisenstadt, la societ� mondiale multi-culturale costituisce una forma neutra, �egualmente svincolata da tutte le civilt� tradizionali�, una sovrastruttura comune che le diverse civilt� possono plasmare dall�interno, mettendo in campo la propria interpretazione della modernit�. E nel confronto fra le interpretazioni, le singole culture possono contribuire a dare forma alla sovrastruttura stessa. In questo modo, un sistema impersonale e omologante � suscettibile di trasformarsi in una sensibile �cassa di risonanza�, un�arena globale, in cui le singole civilt� possono far sentire la propria voce.
Perch� il confronto abbia successo � tuttavia necessario che si rispettino alcuni �presupposti cognitivi�. Occorre cio� che tutte le culture, in questa arena, parlino il linguaggio della �ragione laica�, usando argomenti capaci di convincere chiunque, a prescindere dalle propensioni metafisiche o affiliazioni religiose. A dover compiere questo necessario �auto-distanziamento riflessivo� non sono solo i cittadini credenti, ma anche coloro che aderiscono a concezioni secolari dell�esistenza, i quali sono chiamati a mettere da parte le proprie riserve anti-metafisiche e anti-religiose. Solo cos� pu� sorgere un orizzonte di discorso ideologicamente neutro � e dunque laico, pi� che laicista � di reciproca comprensione. Ciascun interlocutore deve saper distinguere quelle concezioni legate a specifiche concezioni del mondo, dalle credenze minime (thin) generalmente accettabili. In questo modo si potr� giungere alla definizione ragionevole di valori condivisi, pur senza dover essere necessariamente d�accordo sulle questioni pi� impegnative.
Ma � proprio questa retorica minimalista a fare problema. Essa presuppone infatti che gli interlocutori abbiano gi� una idea di ci� che significa �ragionevole�, altrimenti nessun accordo sarebbe possibile. Ora, ci� che rende incommensurabili le diverse visioni del mondo, � proprio il fatto di fondarsi su una diversa concezione della ragionevolezza. La sola storia delle civilt� occidentale ci ha posto di fronte a diverse concezioni di ragione: c�� il nous aristotelico, capace di assurgere ai principi primi dell�essere, ma c�e anche il cogito cartesiano; c�� la ragione aperta al trascendente di un S. Tommaso, ma c�� anche la ragione illuministica che vorrebbe prendere le misure alla Rivelazione. A che tipo di ragione si riferisce Habermas? Tommaso d�Aquino potrebbe, a buon diritto, sostenere che le sue vie siano argomenti perfettamente adeguati al criterio della ragionevolezza �laica�; ma Habermas non annovererebbe certo le sue cinque �vie� tra le �credenze minime�. Per l�Aquinate, � proprio della ragione rimandare a ci� che la fonda, mentre rifiutando tale fondamento, negherebbe se stessa. Al contrario, per il pensiero laicista, � proprio della ragione non fondarsi su altro che su e stessa. L�uno, scoprendosi contingente, riconosce nell�obbedienza all�ordine oggettivo dell�essere la propria perfezione; l�altro, non curandosi delle proprie radici ontologiche, fa del proprio limite il solo vero assoluto. In entrambi i casi siamo di fronte ad un Assoluto, la cui individuazione � il risultato di una scelta: per Dio o per la creatura. Tertium non datur.
Compiere, a questo livello, un �autodistanziamento� critico, significherebbe, per una ragione orientata al trascendente, negare se stessa, per il pensiero laico, la conversio ad Verum. La grande arena dello scambio laico, si risolverebbe cos� in un ritrovo di schizofrenici, in cui ognuno dovrebbe sostenere in ambito pubblico ci� che privatamente ritiene falso. Il �mite agnosticismo� habermasiano lungi dal consentire un dialogo autentico, si rivela essere un luogo di esclusione, un ambito precluso a chiunque voglia parlare con franchezza. Quando, infatti, ci si trova a discutere di aborto o di eutanasia, la decisione iniziale per l�ordine dell�essere o contro di esso � determinante. La soluzione di tali questioni presuppone infatti che si stabilisca preventivamente se la misura della giustizia debba trovarsi in ci� che la ragione decide essere rilevante o piuttosto nell�ordine oggettivo della realt�.
Habermas vorrebbe mettere la scelta fra parentesi, come irrilevante fatto privato, riservando all�ambito pubblico un uso �neutro� della ragione. E qui sta l�inghippo. La ragione pu� rimanere neutra solo finch� si discetta di questioni di logica formale, o di affermazioni ovvie, del tipo �� giusto essere buoni�, o �si deve fare il bene�. Quando per� si debba stabilire cosa significhi essere buoni e cosa sia bene, le diverse concezioni non potrebbero rimanere neutre. O il bene si fonda su un struttura oggettiva, oppure � la ragione stessa a pronunciarsi � magari affidandosi a procedure democratiche � su cosa esso sia. Il vero dialogo � possibile solamente quando gli interlocutori mettono in campo tutte le risorse della propria ragione, quando cio� propongono la �propria� verit� nella sua interezza. Il �mite agnosticismo� habermasiano funziona solo per questioni di scarsa rilevanza. Quando il dibattito va a toccare i fondamenti stessi dell�esistere � quando cio� si tratta di �questioni controverse� �, l�espressione non ha pi� alcun senso: o non si � agnostici, oppure lo si �, ma in maniera tutt�altro che mite.
Rimane ancora una questione da trattare. Si � detto infatti che � la scelta iniziale a determinare ogni successivo uso della ragione. Ne possono derivare due conclusioni. O questa scelta � esclusa dalla sfera del razionale � come vuole Habermas � oppure deve poter essere essa stessa pi� o meno �razionale�. La prima conclusione pu� dare adito, a sua volta, a due conseguenze: l�affermazione di una strutturale incommensurabilit� fra le diverse visioni del mondo, oppure il �mite agnosticismo� habermasiano che, in definitiva, esclude la possibilit� di qualsiasi comunicazione rilevante. Diverso invece, � dire che la ragione � gi� implicata nella scelta per o contro l�ordine dell�essere. Perch� allora la scelta non � pi� un mero accidente che inspiegabilmente incrocia l�esistenza di singoli individui, e in definitiva neanche una �scelta� meramente arbitraria, bens� l�affermazione di un ordine oggettivo, che la ragione, se vuole essere fedele a se stessa, non pu� fare a meno di riconoscere. Lasciarsi istruire da esso o rifiutarlo non � affatto indifferente, poich� �scegliere� male significa tradire la ragione, il che � equivale a tradire se stessi.
� a questo livello che si pu� dare un vero confronto culturale, a condizione che le culture si presentino per ci� che sono, senza imporre agli altri e a s� stessi una �mitezza� fittizia e, in definitiva, violenta.

vai indietro