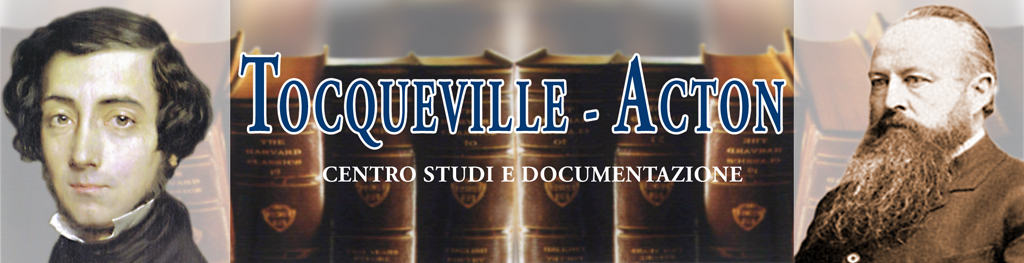
![]() D. Antiseri,
Antiperfettismo,
solidariet� e sussidiariet�: principi a difesa della libert�
D. Antiseri,
Antiperfettismo,
solidariet� e sussidiariet�: principi a difesa della libert�
![]() S. Fallocco,
L'uso retorico della nozione di "effetto perverso": la polemica
tra Albert O. Hirschman e Raymond Boudon
S. Fallocco,
L'uso retorico della nozione di "effetto perverso": la polemica
tra Albert O. Hirschman e Raymond Boudon
![]() E. Di Nuoscio,
Epistemologia
e Liberta� Saggio sulla
filosofia di John Stuart Mill
E. Di Nuoscio,
Epistemologia
e Liberta� Saggio sulla
filosofia di John Stuart Mill
vai indietro
Antiperfettismo, solidariet� e sussidiariet�: principi a difesa della libert�
di D. Antiseri
1. Le ragioni della libert�
Due pensieri: uno di Luigi Einaudi e l�altro di Karl Popper.
Luigi Einaudi: �Liberalismo [...] � quella politica che concepisce l�uomo come fine. Si oppone al socialismo il quale concepisce l�uomo come un mezzo per raggiungere fini voluti da qualcuno che sta al di sopra dell�uomo stesso, sia esso la societ�, lo Stato, il governo, il capo�. Karl Popper: �Perf evitare malintesi desidero chiarire compiutamente che uso sempre i termini �liberale�, �liberalismo�, ecc., nel senso in cui questi sono tuttora generalmente usati in Inghilterra [...] Per liberale non intendo una persona che simpatizzi per un qualche partito politico, ma semplicemente un uomo che d� importanza alla libert� individuale ed � consapevole dei pericoli inerenti a tutte le forme di potere e di autorit�.
Sta proprio qui il cuore della tradizione del pensiero liberale: nella considerazione dell�uomo come fine e nella difesa della libert� individuale nel rispetto degli uguali diritti degli altri. E aveva certamente ragione Alexis de Tocqueville ad affermare che �chi cerca nella libert� qualcosa di diverso da essa � fatto per servire, e non per essere libero�. Ma, intanto, quali sono le ragioni della libert�?
� �Nel campo di coloro che cercano la verit� non esiste nessuna autorit� umana; e chiunque tenti di fare il magistrato viene travolto dalle risate degli d�i�. E� questo il messaggio epistemologico di Albert Einstein; lo stesso di quello di Karl Popper: �Tutta la nostra conoscenza rimane fallibile, congetturale [...] La scienza � fallibile perch� la scienza � umana�. E ancora: evitare l�errore - ammonisce Popper - � un ideale meschino; se ci confrontiamo con problemi difficili, � facile che sbaglieremo; l�importante - e la cosa pi� tipicamente umana - � apprendere dai nostri errori. L�errore individuato ed eliminato costituisce il debole segnale rosso che ci permette di venire fuori dalla caverna della nostra ignoranza.
Ebbene, il fallibilismo epistemologico - vale a dire la consapevolezza che le nostre conoscenze sono e restanto smentibili - � il primo fondamentale presupposto del pensiero liberale. Nessuno pu� presumere di essere in possesso di una verit� razionale da imporre agli altri. Razionalmente possiamo soltanto collaborare - attraverso la critica alle teorie vigenti e le proposte alternative ad esse - per il conseguimento di teorie sempre migliori. L�atteggiamento del liberale - scrive Popper - � quello di chi � disposto ad ammettere: �io posso avere torto e tu puoi avere ragione, ma per mezzo di uno sforzo comune possiamo avvicinarci alla verit�. Razionale non � il medico che, per salvare la diagnosi, uccide il paziente; razionale � il medico che, per salvare il paziente, uccide - cio� falsifica - elimina le diagnosi una dopo l�altra, finch� arriva - se ci riesce - a quella giusta. In breve: liberi perch� fallibili.
� Il liberale consapevole della propria e dell�altrui fallibilit�, sa anche - seguendo Hayek - che le conoscenze, specie le conoscenze di situazioni particolari di tempo e di luogo, le conoscenze �all�istante�, sono disperse, diffuse tra milioni e milioni di uomini - e questo, mentre impone di decentrare le decisioni, rende impraticabile la pianificazione economica centralizzata, la quale dovr� condurre necessariamente al disastro economico e all�oppressione politica non potendo, per altro verso, utilizzare il �calcolo economico� funzionante in un�economia libera con i prezzi di mercato quale sistema ottimo di raccolta delle informazioni.
� Consapevole della propria e dell�altrui fallibilit� e della propria e dell�altrui ignoranza, il liberale sa che il mondo dei valori - per usare un�espressione di Max Weber - � un mondo politeista; sa che le visioni del mondo filosofiche o religiose possono venir proposte e testimoniate, e mai imposte. Da qui la societ� aperta - che � aperta a pi� visioni del mondo religiose o filosofiche, a pi� valori, a pi� proposte di soluzione dei problemi concreti, alla maggior quantit� di critica. La societ� aperta � chiusa solo agli intolleranti.
� �Il potere corrompe e il potere assoluto corrompe assolutamente� - � questo l�ammonimento di Lord Acton. E il liberale, reso edotto dall�esperienza, sa appunto, che del potere presto o tardi si abusa. Di conseguenza, il liberale non si chiede chi deve comandare?, quanto piuttosto come controllare chi comanda? - questo vogliono sapere uomini fallibili che costruiscono, perfezionano e proteggono le istituzioni democratiche, pensate per poter convivere (nella continua proposta di alternative, nella critica e nel dissenso) con altri uomini fallibili portatori di ideali diversi e magari contrastanti. Ma non dobbiamo dimenticare che le istituzioni sono come le fortezze: resistono se � buona la guarnigione. E poich� non esistono metodi infallibili per evitare la tirannide, il prezzo della libert� � l�eterna vigilanza.
� Il liberale sa che la competizione � la pi� alta forma di collaborazione. La scienza progredisce tramite la pi� severa competizione tra idee; la democrazia � competizione tra proposte politiche tese alla soluzione di problemi; la libera economia � competizione di merci e servizi sul mercato. Competizione da cum-petere, che vuol dire cercare insieme, in modo agonistico, la soluzione migliore. La competizione � una macchina di esplorazione dell'ignoto; arricchisce il mondo di idee, beni, servizi - e di nuovi problemi; � strumento di solidariet� poich� viene incontro ai consumatori: consente l'appagamento delle loro preferenze al costo pi� basso. Hayek: �Cos� come per la sfera intellettuale, anche in quella materiale la concorrenza � il mezzo pi� efficace per scoprire il modo migliore di raggiungere i fini umani. Solo l� dove sia possibile sperimentare un gran numero di modi diversi di fare le cose si otterr� una variet� di esperienze, di conoscenze e di capacit� individuali tali da consentire, attraverso la selezione ininterrotta delle pi� efficaci tra queste, un miglioramento costante�.
� E va da s� che chi aborre la competizione, deve avere chiaro il suo rapido ritorno alla vita della trib� o all'interno della caverna. La competizione, infatti, � il terrore di tutti i conservatori - conservatori di destra, di centro e di sinistra. Ha scritto von Hayek, nel saggio Perch� non sono un conservatore, che �uno dei tratti fondamentali dell'atteggiamento conservatore � il timore del cambiamento�. Ostile ai cambiamenti, il conservatore avverte d'istinto che sono le nuove idee a provocare siffatti cambiamenti, e di conseguenza le avversa. �Diversamente dal liberalismo, caratterizzato dalla fondamentale credenza nel potere a lungo termine delle idee, il conservatorismo � vincolato dal bagaglio di idee ereditate in un dato momento�.
� Il liberale non cade nella tentazione di dare sostanza ai concetti collettivi, quali "stato", "classe", "partito", "rivoluzione" e cos� via. Non reifica questi concetti, non li fa insomma diventare cose, entit� autonome e indipendenti dagli individui. �Sono gli uomini che esistono [...]; ma ci� che non esiste - scrive Popper - � la societ�. La gente crede invece alla sua esistenza e di conseguenza d� la colpa di tutto alla societ� o all'ordine sociale�. Ecco, egli conclude, �uno dei peggiori errori � credere che una cosa astratta sia concreta. Si tratta della peggiore ideologia�. E, con Popper, don Luigi Sturzo: �Contro gli organicisti di tutti i tempi, che fanno degli organismi sociali delle entit� per s� stanti, io sostengo che la societ� in concreto � la coesistenza degli individui cooperanti coscientemente per un fine comune, e che n� la societ� n� le sue istituzioni o i suoi organi sono un quid tertium, una ipostasi vivente, una realt� distinta dalla realt� degli individui associati ed operanti ad un fine comune [...] Chi agisce e chi patisce sono gli individui associati�.
� Contro gli statalisti e contro i monopolisti, il liberale � liberista - difende cio� l�economia di mercato - perch� questa in primo luogo, genera il maggior benessere per il maggior numero di persone e, sostanzialmente, per tutti. Ma ci sono altre e pi� importanti ragioni per cui va difesa l�economia di mercato. L�economia di mercato vuol dire, prima di ogni altra cosa, propriet� privata dei mezzi di produzione. Ed � esattamente la propriet� privata dei mezzi di produzione a garantire, nel modo pi� sicuro, le libert� politiche e i diritti individuali. Difatti, come ha scritto Hayek, �chi possiede tutti i mezzi stabilisce tutti i fini�. Ed uno Stato, dove non esiste la propriet� privata, � uno Stato in cui sono automaticamente cancellate tutte le libert� fondamentali. Ci ricordano Mises ed Hayek: a che vale scrivere su di un pezzo di carta che c�� libert� di stampa, quando tutte le cartiere e tutte le tipografie appartengono allo Stato, cio� al gruppo che detiene il potere? Non � forse un inganno - come di fatto lo � stato - stabilire su di una Carta costituzionale che � garantita la libert� di riunione, se poi tutti i locali, comprese le chiese, appartengono allo Stato? La verit� � che: economia di mercato e stato di diritto vivono e muoiono insieme.
Il liberale sa che l�economia di mercato presuppone e genera valori. L�economia di mercato genera il pi� ampio benessere. Sta a fondamento delle libert� politiche. Esige la pace interna ed esterna, poich� altrimenti si distruggerebbe la condizione minimale che rende possibile la cooperazione in regime di divisione del lavoro. A nessuno � lecito scambiare il �profitto� con il �saccheggio�. Commercium et pax era scritto sul porto di Amsterdam. Ludwig von Mises afferma che �la pace � la teoria sociale del liberalismo�. E, prima di lui, F�d�ric Bastiat: �Se su di un confine non passano le merci, vi passeranno i cannoni�. Insomma: la libert� economica, vale a dire la �logica di mercato�, genera la pi� ampia prosperit�; � inscindibilmente connessa alle libert� politiche; esige la pace. E pone al centro della umana comunit� una persona libera, creativa, responsabile. L'economia di mercato � democrazia economica: libero l'imprenditore, sovrano il consumatore.
� La figura dell�imprenditore, dell�innovatore che crea ricchezza e posti di lavoro, ha attraversato il deserto dell�impopolarit� e dell'odio. Tutta una mitologia ideologica ha visto nella competizione una giungla, nel profitto un furto, nell�imprenditore un ladro. Come sottolineato da Joseph Schumpeter, tra il migliore imprenditore e il pi� spietato feudatario, gli storici ci dicono che � quest�ultimo che � riuscito �non solo a impressionare di pi� ma anche ad essere amato�. Sennonch�, ai nostri giorni � soprattutto dopo il crollo del Muro di Berlino e l�implosione dall�Unione Sovietica � i meriti dell�imprenditore vengono sempre pi� ampiamente riconosciuti nella motivata metamorfosi dall�idea del �padrone sfruttatore� nell�idea del �costruttore di pubblico benessere��. E in una situazione del genere vale per l�imprenditore il consiglio che pi� di settanta anni fa Schumpeter dava agli imprenditori tedeschi, nel senso che ogni imprenditore deve imparare che �non basta aumentare realmente il livello dei salari grazie al suo impegno produttivo, ma occorre anche che la gente gli creda, creda cio� al fatto che egli lavora per essa anche quando apparentemente lavora per se stesso�. Tutto ci� per dire che �qualsiasi interesse, se vuole imporsi, deve sapere reclutare�.
E se � ben vero che non sempre e non tutti gli imprenditori sono accorti, abili, ingegnosi e desiderosi di critiche e che le societ� che hanno abbracciato l�economia di mercato non sono il paradiso, � altrettanto vero � per dirla con Michael Novak � che �la strada che pi� e meglio conduce i popoli al benessere, elevandone maggiormente il tenore generale di vita, non � il sistema economico socialistico ma quello capitalistico�. John Stuart Mill: �Se la concorrenza ha i suoi difetti, essa previene pure mali peggiori�.
� Da autentico e consapevole riformista il liberale �, per dirla con Antonio Rosmini, un antiperfettista. Sa che non esiste nessun metodo razionale per decidere quale sia la societ� perfetta: la societ� (presunta) perfetta � la negazione della societ� aperta. E l�antiperfettista ripete con Paul Claudel che �chi cerca di realizzare per gli altri il paradiso in terra, sta in effetti preparando per loro un molto rispettabile inferno�. In realt�, in ogni utopista si nasconde un capitano di ventura. Conseguentemente, il liberale rifiuta il costruttivismo - di stampo illuministico, prodotto di �una irragionevole Et� della Ragione -, vale a dire la concezione secondo cui tutte le istituzioni e tutti gli eventi sociali sarebbero risultati di piani intenzionali, di espliciti progetti voluti e realizzati. Difensore della famiglia, attento alle formazioni o corpi intermedi, il liberale propone una teoria evolutiva delle istituzioni, le pi� importanti delle quali (linguaggio, moneta, diritto, ecc.) egli vede quali esiti inintenzionali di azioni umane intenzionali volte ad altri scopi. Ammonendo lo scienziato sociale a non togliere mai lo sguardo dall�emergenza di conseguenze inintenzionali di progetti intenzionali, il liberale respinge la teoria cospiratoria della societ� stando alla quale tutti i fatti incresciosi ed eventi sociali negativi sarebbero esiti di progetti o congiure architettate da uomini malvagi - e la respinge esattamente per la ragione che l�inevitabile insorgenza di conseguenze inintenzionali di azioni umane intenzionali fa capire che possono esistere cause senza colpe e riuscite senza merito.
� �Non esiste un uomo che sia pi� importante di un altro uomo� - � questo il primo e fondamentale principio di uguaglianza del liberalismo. Uguali in dignit�, gli uomini, nella societ� aperta, sono uguali davanti alla legge. E una terza uguaglianza � quella riguardante l�uguaglianza delle opportunit�. Gli esiti saranno sempre diversi, la riuscita o meno di un progetto di vita dipender� dai tanti fattori (l�impegno, gli incontri, le occasioni, la salute, la fortuna, e cos� via) � ma le possibilit� di una riuscita vanno garantite. La dottrina liberale d� onore al merito e combatte i privilegi. L�uguaglianza delle opportunit� � uguaglianza �liberale�; l�uguaglianza degli esiti � uguaglianza �socialista� - � la via della miseria e delle pi� oppressive disuguaglianze, la via della schiavit�.
Scriveva Luigi Einaudi � a proposito dell�uguaglianza davanti alla legge � (Si veda il suo Memorandum, risalente ai mesi a cavallo tra la fine del 1942 e la primavera del 1943): �Corti e tribunali speciali, giudici di eccezione non devono esistere. Il solo magistrato ordinario, differenziato eventualmente per competenza, deve giudicare. E deve essere indipendente. Nominato dal re, giudicante in nome del re, ma indipendente dal re, dal potere esecutivo e da quello legislativo. Un paese nel quale i giudici non siano e non si sentano davvero indipendenti, i quali non siano chiamati a giudicare in nome della pura giustizia, se occorre, anche contro le pretese dello stato � un paese senza legge, pronto a piegare il capo dinanzi al demagogo primo venuto, al tiranno, al nemico. Il presidio maggiore della libert� dei cittadini in Inghilterra � l�indipendenza della magistratura. La celebre risposta del mugnaio di Sans-Souci a Federico II, il quale voleva le sue terre: ci sono dei giudici a Berlino! E� la prova che quella prussiana era una societ� sana; e la sua resistenza a Napoleone ne fu la prova�.
2. La �solidariet� non � sinonimo di �assistenzialismo�
La concezione liberale della societ� � stata e viene senza sosta sottoposta ad un processo che sembra senza fine. Ed � esattamente il valore della solidariet� nei confronti degli infelici, dei pi� svantaggiati, di quanti vivono nella miseria ed hanno urgente bisogno di cure e di aiuto - � appunto il valore della solidariet� a cui fanno appello tanti cattolici, e non solo loro, per scagliarsi contro l�economia di mercato.
Non � certamente il caso di porre in discussione le buone intenzioni di quanti � cattolici o no � sono contrari al mercato in nome della solidariet�. Ma proprio in base al teorema delle conseguenze inintenzionali delle azioni intenzionali, si sa che di buone intenzioni sono lastricate le vie dell�inferno. Scriveva Thoreau nel 1845: �Non c�� odore peggiore di quello della bont� andata a male [...] Se sapessi per certo che qualcuno sta venendo a casa mia col deliberato proposito di farmi del bene, scapperei a gambe levate�. Milton Friedman commenta cos� questo pensiero di Thoreau: �Chiunque � libero di fare del bene, ma a spese sue�.
In ogni caso � � sempre Hayek a parlare � l�esigere il rispetto della legge, la difesa dai nemici esterni, il campo delle relazioni estere sono attivit� dello Stato; e �pochi metteranno in dubbio che soltanto lo Stato pu� occuparsi delle calamit� naturali quali uragani, alluvioni, terremoti, epidemie e cos� via, e realizzare misure atte a prevenire o a rimediare ad essi�. Ma c�� di pi� � e qui le considerazioni che seguono sono di estrema importanza. Hayek sostiene che la �Grande Societ�� non solo pu� permettersi di aiutare i pi� deboli, gli svantaggiati; essa deve anche farlo. Lo pu� fare perch� � ricca. Lo deve fare perch� nella �Grande Societ�� chi non pu� o non pu� pi� provvedere a se stesso non � possibile che sia aiutato � come era nel caso di piccoli gruppi tribali � dai membri con i quali era vissuto faccia a faccia. In breve: la �Grande Societ�� � afferma Hayek � deve proteggere malati, vecchi, handicappati fisici e mentali, vedove e orfani e tutti coloro che non sono in grado di guadagnarsi da vivere in un�economia di mercato. �Assicurare un reddito minimo a tutti, o un livello sotto cui nessuno scenda quando non pu� pi� provvedere a se stesso, non soltanto � una protezione assolutamente legittima contro rischi comuni a tutti; ma � un compito necessario della Grande Societ� in cui l�individuo non pu� rivalersi sui membri del piccolo gruppo specifico in cui era nato�.
Cos�, dunque, Hayek � l�esponente pi� prestigioso del liberalismo contemporaneo - ci costringe a riflettere sul fatto che mercato e solidariet� non sono affatto concetti e realt� contrapposti. Ovvero dobbiamo ridurre la solidariet� a inutili lacrime versate sulle nostre reciproche miserie? O, peggio ancora, dobbiamo pensare che la solidariet� equivalga allo storno di risorse da chi produce a clientes parassiti? Solidariet� non � sinonimo di assistenzialismo. Mercato e solidariet� sono coniugabili. Non coniugabili, invece, sono mercato e dissipazione delle risorse, mercato e corruzione, mercato e privilegi. Lo statalismo fa l�uomo ladro � sulla base del principio: pronto bottino, pronto saccheggio. E sempre lo statalismo trasforma i cittadini in accattoni ricattabili che per mestiere fanno gli elettori
3. Il principio di sussidiariet�
�Gli Americani di tutte le et�, condizioni e tendenze, si associano di continuo. Non soltanto possiedono associazioni commerciali e industriali, di cui tutti fanno parte, ne hanno anche di mille altre specie: religiose, morali, grandi e futili, generali e specifiche, vastissime e ristrette. Gli Americani si associano per fare feste, fondare seminari, costruire alberghi, innalzare chiese, diffondere libri, inviare missionari agli antipodi; creano in questo modo ospedali, prigioni, scuole. Dappertutto, ove alla testa di una nuova istituzione vedete, in Francia, il governo, state sicuri di vedere negli Stati Uniti un'associazione�. E' cos� che Alexis de Tocqueville, ne La democrazia in America, descrive il funzionamento, nella vita sociale, di quel principio che in seguito verr� chiamato �principio di sussidiariet�. Tale principio - autentico baluardo a difesa della libert� degli individui e dei �corpi intermedi� nei confronti delle pretese onnivore dello statalismo - trova una formulazione, ormai diventata classica, nell'Enciclica Quadragesimo anno (1931) di Pio XI, dove, al paragrafo 80, si dice che �siccome non � lecito togliere agli individui ci� che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunit�, cos� � ingiusto rimettere a una maggiore e pi� alta societ� quello che dalle minori e inferiori comunit� si pu� fare.Ed � questo insieme un grave danno ed uno sconvolgimento del retto ordine della societ�; perch� l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della societ� stessa � quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non gi� distruggerle e assorbirle�.
Siffatto principio di sussidiariet�, successivamente ripreso in altre Encicliche papali e in documenti ufficiali della Chiesa - basti richiamare la Pacem in terris (1963) di Giovanni XXIII o la Centesimus annus (1991) di papa Wojtyla - era stato gi� formulato da Rosmini nella Filosofia della politica, dove leggiamo che �il governo civile opera contro il suo mandato, quand'egli si mette in concorrenza con i cittadini, o colle societ� ch'essi stringono insieme per ottenere qualche utilit� speciale; molto pi� quando, vietando tali imprese agli individui e alle loro societ�, ne riserva a s� il monopolio�. In breve: lo Stato �faccia solo quello che i cittadini non possono fare�. In un discorso pronunciato in Senato, il 20 febbraio del 1954, Sturzo affermava: �Non nego un misurato intervento nelle varie branche dell�attivit� privata, specialmente a scopo integrativo, e dove l�iniziativa privata non possa da s� corrispondere adeguatamente alle esigenze pubbliche�. E� questo, dunque, il principio di sussidiariet� orizzontale ben diverso dall'altra formulazione che porta il nome di sussidiariet� verticale dove, per esempio, si dice che la Regione far� quello che non fa lo Stato, la Provincia far� quello che non fa la Regione, e i Comuni e le aree metropolitane faranno quello che non fa la Provincia. E qui � chiaro che, se il principio di sussidiariet� verticale non viene esplicitamente coniugato con quello di sussidiariet� orizzontale, si cade in modo inequivocabile in una pi� subdola e pericolosa forma di statalismo celebrata nella formula: ci� che non fa il pubblico lo fa comunque il pubblico. Ma � proprio contro ogni forma di oppressione nei confronti della libert�, responsabilit�, spirito di iniziativa dei singoli e delle associazioni spontanee che � stato difeso il principio di sussidiariet� e ovviamente non solo dai cattolici. La Filosofia della politica di Rosmini � del 1838. Undici anni pi� tardi, nel 1849, J.S. Mill pubblica On Liberty, ben consapevole che �i mali cominciano quando invece di fare appello alle energie e alle iniziative di individui e associazioni, il governo si sostituisce ad essi; quando invece di informare, consigliare e, all'occasione, denunciare, e imporre dei vincoli, ordina loro di tenersi in disparte, e agisce in loro vece�.
Su questa linea si sono mossi i grandi liberali del nostro secolo: Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek e Karl Popper, tra gli altri. Scrive Hayek: �E' totalmente estranea ai principi base di una societ� libera l'idea secondo la quale tutto ci� di cui il pubblico ha bisogno debba essere soddisfatto da organizzazioni obbligatorie�. Il vero liberale, ad avviso di Hayek, deve auspicare il maggior numero possibile di associazioni volontarie, di quelle organizzazioni �che il falso individualismo di Rousseau e la Rivoluzione francese vollero sopprimere�. E, poi, Karl Popper: �Io sostengo che una delle caratteristiche della societ� aperta � di tenere in gran conto, oltre alla forma democratica di governo, la libert� di associazione e di proteggere e anche di incoraggiare la formazione di sotto-societ� libere, ciascuna delle quali possa sostenere differenti opinioni e credenze�.
A fondamento del principio di sussidiariet� vi � in primo luogo la fede nella libert�: si tratta di un fondamento etico. Aveva ragione Tocqueville a sentenziare che quanti nella libert� cercano qualcosa di diverso dalla libert� sono nati per servire. Inoltre, come gi� sappiamo, la soluzione della maggior parte dei problemi (e, dunque, il soddisfacimento dei bisogni umani) deve venir lasciata a quanti sono in possesso di quelle conoscenze di situazioni particolari di tempo e di luogo disperse tra milioni e milioni di uomini, conoscenze di cui non potr� mai disporre nemmeno il pi� potente governo, n� il pi� sapiente e potente tiranno. Per questo, in un orizzonte del genere ognuno vede �l�importanza dell�esistenza di numerose associazioni volontarie non soltanto per gli scopi particolari di coloro che condividono un interesse comune ma anche per fini pubblici nel vero senso della parola�. Lo Stato, prosegue Hayek, �dovrebbe avere il monopolio della coercizione necessaria a limitare la coercizione stessa; ci� non significa che lo stato debba avere l�esclusivo diritto di perseguire fini pubblici�. Sennonch�, �l�attuale tendenza dei governi a portare tutti gli interessi comuni di vasti gruppi sotto il proprio controllo tende a distruggere il vero spirito pubblico. Come risultato, un numero sempre crescente di uomini e donne si sta allontanando dalla vita pubblica, a cui in passato avrebbe dedicato molte energie�.
L'uso retorico della nozione di "effetto perverso": la polemica tra Albert O. Hirschman e Raymond Boudon
di S. Fallocco
1. Retorica e dibattito politico
Tra i contributi del pensiero greco alla storia della civilt�, la retorica si � venuta a configurare come procedimento razionale praticabile nell'ambito di attivit� umane, quali, per esempio, la politica e il diritto[1].
Essa �, da un lato, l'arte di comunicare con efficacia, dall'altro, l'insieme delle tecniche e degli strumenti linguistici attraverso i quali si persuade a comportarsi in determinati modi anzich� in altri e si regola la propria parola per ottenere questo effetto[2]. In sostanza, � l'arte di dare prova di eloquenza davanti a un pubblico (reale o potenziale) per guadagnarlo alla propria causa. Da questo punto di vista, nella misura in cui punta ad influenzare la visione del mondo degli individui, la retorica esercita un potere manipolatorio, che consiste, appunto, nell'azione di determinare in un attore sociale (sia esso persona, gruppo o collettivit�) l'agire e il pensare in un modo compatibile con gli interessi di chi se ne serve, tramite tecniche di persuasione in grado di trasformare volontariamente l'interpretazione della verit�, lasciando l'impressione della libert� di opinione e di decisione.
Ne consegue che gli esiti dei processi politici, talora, non sono determinati soltanto dalle preferenze individuali e dall'influenza esercitata dal contesto istituzionale, bens� anche dalla "forma" che assumono le questioni dominanti all'interno del dibattito politico.
La formulazione degli argomenti, i quali devono fornire le ragioni o i motivi per persuadere ad agire in un certo modo, fa affidamento (e trae forza) o sul richiamo alla mitologia classica, i cui racconti (si pensi alla sequenza hubris-nemesis, al mito di Edipo, all'immagine di una divinit� vendicativa) dovrebbero ammonire a riflettere bene prima di intraprendere determinate azioni, oppure su mirate interpretazioni storico-sociologiche, invocate per il loro carattere intransigente[3], che nega - cio� - quel tipo di discussione, contrassegnata non dalla persuasibilit� degli individui a recepire influenze e ad accettare cambiamenti nelle attitudini e nei comportamenti, e nemmeno dall'intento di far prevalere la propria opinione su quella dell'interlocutore, bens� da un'istanza dialogica che fa dell'interscambio comunicativo un'occasione per individuare soluzioni possibili di problemi controversi.
E' questa la tesi sostenuta, nel volume Retoriche dell'intransigenza. Perversit�, futilit�, messa a repentaglio, dal politologo Albert Hirschman, il quale, denunciando i meccanismi retorici che hanno generalmente accompagnato lo scontro tra spinte riformatrici e spinte reazionarie durante le lotte per le libert� individuali, politiche e sociali, sviluppatesi per oltre due secoli (dalla Rivoluzione francese all'avvento della democrazia), elabora una tipologia degli argomenti usati prevalentemente dai "reazionari"[4] contro il mutamento politico e sociale: la tesi della perversit� (perversity), secondo cui �qualunque azione mirante a migliorare un qualche aspetto dell'ordinamento politico, sociale o economico serve soltanto ad esacerbare la condizione cui si vuole porre rimedio� [Hirschman, 1991, p.14]; la tesi della futilit� (futility), la quale afferma che �i tentativi volti a trasformare la societ� saranno vani� [Ibid.]; e, infine, la tesi della messa a repentaglio (geopardy), secondo cui �il costo del cambiamento o della riforma � troppo elevato perch� si metta a repentaglio una qualche preziosa conquista precedente� [Ibid.].
Scritto tra la fine del 1985 e il 1989 (in ogni caso, prima del collasso del comunismo nell'Europa dell'Est), Retoriche dell'intransigenza nasce dalla preoccupazione, paventata, peraltro, dalla rielezione di Ronald Reagan negli Stati Uniti, di una nuova offensiva conservatrice in materia di politica sociale ed economica.
A tal riguardo, proprio nel 1985, la Fondazione Ford aveva deciso di riunire un gruppo di cittadini e di studiosi, tra cui lo stesso Hirschman e il sociologo Ralf Dahrendorf, col compito di approfondire le tematiche relative alla crisi del Welfare State. Lo spirito battagliero che aveva contrassegnato il lavoro all'interno di questo comitato e che risulta evidente soprattutto nei primi capitoli del libro, tradisce l'indole militante del politologo di origine tedesca, il quale, fin da giovane, sfidando (e pagando con l'esilio) il nazismo, aveva aderito con convinzione ed entusiasmo al socialismo[5].
Pubblicato negli Stati Uniti nel 1991, il volume � stato presto tradotto - col titolo Deux si�cles de rethorique r�actionnaire � anche in Francia, dove ha suscitato una viva reazione da parte del sociologo Raymond Boudon, il quale, dalle pagine del bimestrale parigino Le D�bat[6], ha messo in discussione, in particolare, l'utilit� di un�analisi finalizzata a sottolineare l�eventuale uso retorico della nozione di effetto perverso.
Ne � seguita una disputa accademica, durata, peraltro, lo spazio di una replica (alquanto stizzita) di Hirschman a Boudon, la quale, tuttavia, merita di essere presa in esame per il rilievo scientifico che la nozione di "effetti perversi" e, pi� in generale, di conseguenze inintenzionali dell'azione umana intenzionale, di cui costituisce una fattispecie, ha nell'ambito delle scienze sociali, lungi dalla possibilit� di rivestirne il contenuto con argomenti retorici a fini persuasivi o anche ideologici.
2. La tesi di Hirschman
Nel 1949, il sociologo inglese Thomas H. Marshall tenne all�Universit� di Cambridge una famosa conferenza su �Cittadinanza e Classi Sociali in Occidente�, dove distinse tre dimensioni della cittadinanza: civile, politica e sociale, sostenendo che, a partire dal XVIII fino al XX secolo, tre successive �ondate� riformiste avevano condotto all�affermazione progressiva di una serie di istituzioni e di diritti corrispondenti a ciascuna di esse: pi� specificatamente, il Settecento aveva visto le grandi battaglie per l�istituzione della cittadinanza civile, dalla libert� di parola a quella di pensiero e di religione; nell�Ottocento, invece, era stato l�aspetto politico della cittadinanza, ossia il diritto dei cittadini di partecipare all�esercizio del potere politico, mediante l�ampliamento del diritto di voto a gruppi sempre pi� vasti, a compiere i maggiori passi in avanti; infine, l�avvento del Welfare State nel Novecento aveva riconosciuto che condizioni minime di istruzione, di salute, di benessere economico e di sicurezza sono indispensabili alla vita di un individuo civilizzato, allargando con ci� stesso il concetto di cittadinanza alla sfera sociale ed economica[7].
Seguendo questo schema di Marshall, formulato originariamente in riferimento al caso inglese, poi applicato ad altri casi nazionali, fino ad essere diffusamente considerato in grado di rendere conto dello sviluppo politico dell�Occidente nel suo complesso, Hirschman sostiene che alle tre fasi di sviluppo in senso democratico seguirono altrettante ondate �reazionarie�, finalizzate a neutralizzare i traguardi fino ad allora raggiunti: pertanto, il suo scopo dichiarato � quello di insistere sulle �grandi posizioni e manovre polemiche pi� verosimilmente destinate a venir adottate da quanti s�impegnano a screditare e a rovesciare politiche e movimenti d�idee �progressisti��[Hirschman, 1991, p.14].
In particolare, egli sostiene che, tra queste, l�argomento della perversit� � il solo su cui concentreremo la nostra attenzione - �� il primo che viene in mente come strategia retorica specifica, quando si cerca un argomento decisivo da opporre ad una data proposta di riforma�[Ivi, 1997, p.64]. Esso consiste nel sottolineare che certe azioni intraprese (o che si intende intraprendere) possono produrre, �via un concatenamento di conseguenze non volute, l�esatto contrario dell�obiettivo proclamato� e che, pertanto, �il tentativo di spingere la societ� in una certa direzione avr� per effetto s� un movimento della societ�, ma nella direzione opposta�[Hirschman, 1991, p.19].
Questa � stata, a suo parere, la strategia controrivoluzionaria di Edmund Burke, il quale nelle Riflessioni sulla Rivoluzione francese sostenne, gi� nel 1790 (un solo anno dopo lo scoppio della Rivoluzione francese), che il tentativo dei rivoluzionari di conquistare la libert� avrebbe prodotto una �ignobile oligarchia fondata sulla distruzione della Corona, della Chiesa, della nobilt� e del popolo� e avrebbe posto fine �a tutti gli innumerevoli sogni e visioni di uguaglianza e di diritti dell�uomo�[Burke, 1963, p.384 e ss.]. Sarebbe, cio�, sfociato nella tirannide; dunque, in un risultato non voluto e non previsto dai rivoluzionari stessi.
La fortuna di questa interpretazione, che in seguito divenne una sorta di �legge storica� al servizio della causa controrivoluzionaria negli anni della Restaurazione, � legata innegabilmente alla forza dell�eloquenza[8] con cui Burke si impegn� a combattere il corso della Rivoluzione francese, ma anche (o soprattutto), come lo stesso Hirschman sottolinea, al fatto che, gi� ai suoi tempi, esistesse un �terreno intellettuale preparato ad accogliere l�affermazione che occasionalmente pu� verificarsi l�opposto�[Ivi, p.22] di ci� che ci si prefigge.
Il pensiero di Burke, infatti, era completamente intriso dalle idee filosofiche dell�Illuminismo scozzese del XVIII secolo[9], che aveva insistito sull�importanza degli effetti inintenzionali dell�azione umana intenzionale, sia pur sottolineandone in particolare la positivit� e la desiderabilit� : la convinzione di Mandeville, di Hume e di Smith, che ne furono i pi� autorevoli rappresentanti, era, infatti, che, lasciato libero di soddisfare il proprio interesse secondo le proprie inclinazioni, l�individuo realizza non solo il proprio interesse ma anche il bene della comunit�. Diversamente, in Burke le conseguenze inintenzionali scaturite dai piani e dalle azioni dei rivoluzionari francesi, nella misura in cui hanno portato a forme di tirannide sono conseguenze negative ed indesiderabili. Effetti perversi, appunto.
Un analogo ragionamento affiora nell�invettiva di Joseph De Maistre, il controrivoluzionario cattolico che, in Considerazioni sulla Francia (1796), interpreta la rivoluzione francese come la manifestazione storica dell�impossibilit� da parte dell�uomo di essere l�artefice della propria storia, la quale, appunto, non obbedisce alla ragione umana, ma a una divina provvidenza �vendicativa� che stava preparando la salvezza della Francia e la reintegrazione del potere dopo l�anarchia degli anni della Rivoluzione, disponendo, in tal modo, un esito delle azioni umane che finiva per essere l�esatto opposto delle intenzioni degli uomini. Pertanto, - scriveva -�� persino possibile rilevare un�affettazione della Provvidenza (se mi si permette l�espressione), nel senso che gli sforzi del popolo per raggiungere un certo obiettivo sono precisamente lo strumento che essa impiega per allontanarnelo�[De Maistre, 1985, p.75].
Tra le numerose idee politiche che possono essere considerate altrettante reazioni ai progressi della democrazia in generale si pu�, altres�, annoverare - continuando la rassegna di autori selezionati da Hirschman - quella espressa da Gustave Le Bon, che si colloca storicamente ai tempi della �seconda ondata� reazionaria, caratterizzata, in particolare, dalla ferma opposizione all�ampliamento del suffragio universale. In Psicologia delle folle (1895), prendendo le mosse dalla dicotomia tra individuo e �folla� � l�uno concepito come attore razionale che agisce per soddisfare il suo interesse, l�altra concepita come soggetto irrazionale, facilmente influenzabile e propenso ad entusiasmi sconsiderati - polemizza contro l�avvento delle moderne societ� di massa, nelle quali, appunto, grazie all�estensione del diritto di voto, si andavano insediando, come attori di prima grandezza, proprio quelle �folle irrazionali� che considerava un pericolo per l�ordinamento interno e internazionale. Per questo, egli sottolinea la necessit� di arginare al pi� presto l�avvento della democrazia che, peraltro, a suo parere, si sarebbe trasformata sempre pi� nel dominio della burocrazia, la quale �attraverso la produzione incessante di leggi e di provvedimenti restrittivi, ha come risultato fatale la progressiva riduzione della sfera nella quale i cittadini possono muoversi liberamente, vittime dell�illusione che, moltiplicando le leggi, la libert� e l�uguaglianza siano maggiormente assicurate�[Le Bon, 1970, p.39].
Dunque, non ci si accontentava di sottolineare che le istanze riformiste potevano tradursi in un fallimento; si voleva dimostrare con pervicacia che le conseguenze che ne derivano si risolvono in un peggioramento che avviene in quella medesima dimensione in cui si attendeva il miglioramento.
Questo tipo di riflessione risulta evidente nel giudizio denigratorio, espresso dagli oppositori alle moderne politiche di Welfare, nella �terza� fase reazionaria, che coincide con il dibattito, apertosi gi� a partire dalla prima met� dell'800, sui problemi dell'assistenza sociale agli strati pi� poveri della societ�, che stavano subendo pesantemente le conseguenze del libero mercato del lavoro. A titolo d'esempio, Hirschman prende in esame la vicenda legata all�introduzione delle Poor Laws in Inghilterra tra il 1760 e il 1830, le quali stabilivano, in linea generale l'integrazione dei salari pi� bassi, specialmente in agricoltura, al fine di assicurare, in qualche modo, la pace sociale e di sostenere la produzione alimentare nazionale. La loro approvazione fu estremamente controversa e offr� l�opportunit� a chi si opponeva alle politiche di sussidi sociali � da Defoe a Burke, da Malthus a Tocqueville � di rilevare che le misure adottate avevano operato di fatto come ulteriore incentivo alla povert�, in quanto avevano fatto del ricorso ai sussidi statali una "professione legale". Con il risultato che, l'intento di migliorare le condizioni sociali ed economiche degli strati pi� poveri della popolazione aveva innescato l'effetto perverso di aggravarle, lasciando le persone coinvolte intrappolate vita natural durante nell'accidia e nella povert�. Un argomento, questo, ribadito tanto nel primo quanto nel tardo capitalismo, se � vero che Hirschman rinviene una retorica dell�effetto perverso, per esempio, anche nel libro di Charles Murray, Losing Ground (1984), che rappresenta il pi� pubblicizzato tra gli attacchi sferrati negli Stati Uniti contro il Welfare State[10].
In sostanza, - commenta Hirshman - i critici della Rivoluzione francese, dell'introduzione del suffragio universale e delle moderne politiche assistenzialistiche, mettendo in evidenza una sostanziale discrepanza tra le intenzioni individuali e gli esiti sociali, hanno sostenuto che �l'aspirazione alla democrazia produce oligarchia e tirannide, cos� come i programmi di assistenza sociale accrescono la povert� anzich� diminuirla� [p.20]. Di conseguenza, �irresistibilmente attratti a schernire quanti aspirano a cambiare il mondo in meglio�[Ivi, p.31], essi hanno �raccomandato estrema cautela nel riformare le istituzioni esistenti e nell'attuare politiche innovative�[Ivi, p.163]. Favorendo, peraltro, (come nel caso soprattutto di Burke), talora e del tutto inintenzionalmente, - aggiunge - �un'escalation della retorica rivoluzionaria e progressista�[Ibid.] da parte di coloro che sono sempre pronti a riplasmare il mondo. Infatti, sostenendo con tanta insistenza la tesi della perversit�, avrebbero spinto �i partigiani del mutamento radicale a coltivare (�) la convinzione che tutti i passati tentativi di risolvere i problemi della nazione si sono risolti in un completo fallimento�[Ivi, p.164]. E cos� facendo, hanno in qualche modo legittimato l'esigenza rivoluzionaria di ricostruire la societ� dalle fondamenta, dal momento che �chi afferma il fallimento dei precedenti tentativi riformatori sostiene, implicitamente o esplicitamente, che il vecchio ordine deve essere abbattuto e un nuovo ordine ricostruito dalle fondamenta, senza alcun riguardo per le conseguenze negative dell'operazione�[Ibid.].
E' evidente, a questo punto, a necessit� da parte di Hirschman di abbassare il tono della polemica: infatti, pur avendo sostenuto, per ben cinque capitoli del libro, che �l�invocazione della tesi della perversit� � un caratteristica basilare della retorica reazionaria� [Hirschman, 1991, p.39], nel VI capitolo, dal titolo �Dalla retorica reazionaria alla retorica progressista�, Hirschman valuta la possibilit� di delineare argomenti retorici �progressisti� suscettibili di apparire come la controparte di quelli reazionari.
L�intento � quello di porre in evidenza che le discussioni tra reazionari e progressisti � ciascuno con il suo bagaglio di argomenti intransigenti � sono, nella maggior parte dei casi, ��dialoghi tra sordi� ed espedienti per evitare quella deliberazione e quella comunicazione genuina tra gruppi rivali che si suppone siano caratteristiche della democrazia�[Hirschman, 1997, p.78].
Tuttavia, mentre, nel caso delle posizioni riformiste, il ricorso all�argomento retorico dell�effetto perverso, sembra scaturire quasi obbligatoriamente dalla necessit� di arginare le manovre reazionarie per screditare idee e politiche progressiste[11], l��evidenza empirica� della correlazione tra carattere reazionario del pensiero politico e la propensione ad impiegare l�argomento della �perversit��, evidenza empirica che Hirschman ricava dalla minuziosa analisi critica di tre secoli di storia del pensiero politico, sembrano fargli accreditare il pensiero reazionario come retorico per definizione. E, infatti, anche se i tre moduli retorici non sono �propriet� esclusiva dei �reazionari�� e �possono essere invocati da qualunque gruppo che avversi o critichi nuovi indirizzi politici o politiche di recente introduzione (�), ci� nondimeno (�) sono tipici soprattutto degli attacchi conservatori contro politiche progressiste in atto o proposte; e i loro grandi protagonisti sono stati pensatori conservatori�[Hirschman, 1991, p.15][12].
In ogni caso, fatta questa distinzione, la questione che a lui preme sottolineare � un'altra.
Certo � che se Hirschman si fosse limitato a porre in evidenza come dietro a certi argomenti di carattere politico sia costantemente rintracciabile uno specifico codice retorico (che � poi, appunto, essenzialmente quello tipico del pensiero reazionario da tre secoli a questa parte) senza metterne in discussione la loro indebita generalizzazione, avrebbe finito per fare il gioco degli stessi reazionari: che si tratti o meno di un esercizio retorico, infatti, l'insistenza sulla reiterazione di certi eventi non riconducibili alle intenzioni degli individui coinvolti serve ai reazionari stessi ad alimentare la credenza nell�onnipresenza degli effetti perversi. Ecco perch� tiene a puntualizzare � che assai spesso gli argomenti passati in rassegna sono per pi� di un verso �sospetti� [Ivi, p.168] di sovrautilizzazione[13]: infatti, il potere attrattivo che esercitano, riconducibile alla loro connessione con la mitologia classica, nonch� alla soddisfazione che procurano all�amor proprio di coloro che li propongono, fa s� che possano essere invocati, in una maniera quasi routinaria, per rendere conto di una vasta gamma di situazioni, quando, al contrario, si pu� facilmente dimostrare che � improbabile che nel mondo reale essi si riproducano in misura anche solo lontanamente paragonabile a quella affermata.
Pertanto, volendo suscitare dei dubbi circa il suo verificarsi con la stessa frequenza asserita dai suoi fautori, Hirschman sottolinea che l�effetto perverso � �lungi dall�essere l�unica specie concepibile di conseguenza inintenzionale o effetto collaterale�[Ivi, p.41][14].
A tal riguardo, bisogna precisare che, quando si parla di conseguenze inintenzionali, si pone l�accento su risultati di azioni umane intenzionali, le quali producono esiti che sono al di fuori degli intendimenti degli agenti. Tra gli effetti dell�azione e l�intenzione dell�attore o degli attori che pongono in essere questa stessa azione esiste, cio�, uno �scarto�, tale per cui questi effetti non possono essere ricondotti direttamente a quell�intenzione. Come tali, i risultati non anticipati dell�azione intenzionale sono, per definizione, sempre non voluti dal punto di vista dell�attore, anche se, come ammoniva Merton, �le conseguenze inintenzionali non dovrebbero essere considerate necessariamente indesiderabili. Dal momento che, sebbene questi risultati siano inintenzionali, non sono sempre assiologicamente negativi. In breve gli effetti indesiderati non sono sempre indesiderabili�[Merton, 1998, p.7][15].
Ebbene, nonostante dagli scritti dei filosofi morali scozzesi del XVIII secolo, che per primi hanno attirato l'attenzione sul fatto che certe regolarit� dell'azione umana non sono il prodotto di un progetto deliberato, emergesse chiaramente che le azioni individuali motivate dall�interesse personale possono avere un effetto sociale positivo, Hirschman rileva che, col tempo, e precisamente con l�esperienza della Rivoluzione francese, il concetto di conseguenza inintenzionale ha acquisito una connotazione prevalentemente negativa, nel senso che �l��inintenzionale� stinse facilmente nell��indesiderabile� e di qui nell��indesiderabile��[Hirschman, 1991, p.40]. Tanto pi� che storicamente si � indotti, in genere, a prestare maggiore attenzione agli effetti inintenzionali negativi, che in quanto tali pongono problemi che devono essere urgentemente affrontati e risolti.
Porre l'accento sulla diversa valenza (positiva o negativa)[16] che gli effetti inintenzionali possono assumere, significa, dunque, ristabilire una corretta interpretazione del significato del concetto di conseguenze inintenzionali. Ne consegue che una posizione che faccia delle conseguenze inintenzionali una sottoclasse degli effetti perversi (mentre, al contrario, sono questi ultimi a costituire una variante delle conseguenze inintenzionali) finisce per distorcere la realt� e, come tale, per Hirschman, va stigmatizzata, soprattutto quando (ed � questo il caso delle posizioni reazionarie e conservatrici) si sostanzia in critiche e ostacoli ad azioni di riforma, volte ad estendere i processi di democratizzazione politica e sociale.
In ogni caso, la sensazione che se ne ricava � che l'aver denunciato l'uso retorico e, conseguentemente, la tendenza a generalizzare indebitamente la nozione di effetto perverso non sia sufficiente ad indebolire (o, addirittura, a confutare) le argomentazioni favorite dai reazionari, per quanto utile a testarne l'efficacia in rapporto alle istanze che le hanno ispirate. Questo, almeno fin quando ci si arresta al piano descrittivo, trascurando quello esplicativo delle cause che hanno prodotto il verificarsi di certi eventi non voluti e non previsti.
Pertanto, l�intento, sia pur lodevole, del �progressista� Hirschman di smascherare quanto possa essere insidioso il pensiero reazionario, laddove preferisce muoversi secondo �manovre� precostituite piuttosto che negare in modo esplicito la legittimit� dei valori democratici, sembrerebbe - suo malgrado - innescare esso stesso un effetto perverso: quello di aver oscurato in qualche misura il rilievo scientifico che il concetto di conseguenze inintenzionali riveste nell�ambito delle scienze sociali.
3. La polemica con Raymond Boudon
Che l�impiego in modo retorico o ideologico della tesi della perversit� rischi di trascurare l'uso scientifico del concetto di conseguenze inintenzionali sembra essere la principale preoccupazione espressa dal sociologo francese Raymond Boudon, il quale afferma che �lungi dall'essere in se stessa una nozione retorica, essa ci consente innanzitutto di capire il mondo� [Boudon, 1992, p. 110] Come peraltro � ci ricorda - lo stesso Hirschman aveva dimostrato in un suo scritto del 1970[17], dal titolo Lealt�, defezione e protesta. Rimedi alle crisi delle imprese, dei partiti e dello Stato, analizzando due specifiche situazioni: quella della crisi del sistema di trasporto ferroviario in Nigeria, nella seconda met� degli anni '60, rispetto alla quale aveva messo in evidenza come il passaggio da una situazione di monopolio nel settore dei trasporti ad una situazione di concorrenza perfetta, piuttosto che incentivare le ferrovie nigeriane ad attivare processi di modernizzazione per il miglioramento della loro produttivit�[18] aveva provocato la defezione (exit) dei clienti pi� esigenti e indirettamente - inintenzionalmente - il venir meno proprio dell'incentivo alla modernizzazione; e quella del degrado delle scuole pubbliche americane, che allo stesso modo, pu� essere spiegato come effetto della diserzione delle classi agiate verso le scuole private[19].
Tuttavia, proprio quando ci si aspetterebbe un chiarimento sulla distinzione tra il rilievo epistemologico del concetto di conseguenze inintenzionali e l�uso retorico che ne � stato fatto, Boudon finisce per indugiare proprio su quest�ultimo aspetto, muovendo una serie di critiche, talora non prive di equivoci.
Come nel caso in cui fa notare, portando come esempio il contributo di Marx, ne Il Capitale, o di Bossuet, nel Discorso sulla storia universale, che, quando viene impiegata in chiave retorica, la nozione di perversit� �appare presso i �progressisti� con una frequenza tanto grande almeno quanto presso i �reazionari��[Ibid.].
Giustamente, nella sua replica[20], Hirschman ha potuto con tutta facilit� rammentargli che lui stesso, per primo, aveva riconosciuto e argomentato che �i reazionari non hanno il monopolio della retorica�[Hirschman, 1991, p.153].
In ogni caso, trattasi di una polemica inutile, dal momento che lo stesso Boudon, qualche pagina pi� avanti rispetto a quelle in cui gli aveva, pi� o meno esplicitamente, rimproverato di aver suggerito l�idea secondo cui la retorica sarebbe per essenza reazionaria, si chiede (in parte contraddicendosi, dunque) se Hirschman abbia trattato della retorica dei �progressisti� �per dimostrare la sua imparzialit� e la sua fedelt� al principio scientifico fondamentale della �neutralit� assiologica��[Boudon, 1992, p.116].
Perch� sia giunto a rovesciare l�impostazione polemica trattando della retorica progressista, Hirschman lo spiega qualche anno pi� tardi (nel 1993) in un articolo apparso sulla rivista francese Commentaire[21] e poi confluito in Autovversione, una raccolta di saggi in cui l�autore torna sulle opere di una vita aprendo nuove strade alla ricerca[22].
Riadattando un termine che Nietzsche aveva usato nel pamphlet contro Wagner, di cui in passato era stato un grande ammiratore, egli definisce quest��arte di rovesciare se stessi� un�impresa �autosovversiva�, in quanto dimostrazione della sua inclinazione a scovare e a inseguire elementi che contraddicono o che sono, comunque, in tensione con affermazioni e tesi sostenute in precedenza.
Nel caso specifico, lungi dal trattarsi del bisogno di affermare la propria imparzialit�, come ritiene Boudon, o di dar prova di un eccessivo �virtuosismo intellettuale�, come � stato scritto in una recensione del 1991 su Le Monde[23], per Hirschman, che rifiuta l�approccio di quegli scienziati che �nei loro lavori successivi tendono ad esplorare, lungo linee di kuhniana �scienza normale� tutti gli ambiti suscettibili di confermare i loro risultati originari� [Hirschman, 1997, p.119], si tratta semmai di una questione di coerenza, ma anche, soprattutto, del �vantaggio sostanziale di riuscire a concludere il libro su una nota ampia e positiva� [Ivi, p.78]., dando il suo contributo a una cultura pi� democratica, in cui i cittadini non soltanto abbiano il diritto alle loro opinioni e convinzioni, ma, cosa pi� importante, siano pronti a metterle in questione alla luce di nuovi argomenti e di nuovi elementi di prova.
Fermo restando, tuttavia, che la sua convinzione � che �tirate le somme, le nuove dinamiche in cui si � imbattuto (�) non cancellano n� confutano i risultati precedenti, ma si limitano a definire ambiti del mondo sociale in cui le relazioni originariamente postulate non sono valide�[Ivi, p.120].
Un�altra questione che, secondo Boudon, Hirschman avrebbe sottostimato riguarda la mancata distinzione tra pensiero reazionario e pensiero conservatore.
Non c�� dubbio che, da questo punto di vista, il sociologo francese abbia ragione. Stipando indistintamente in un unico grande cassetto tutti i �non-progressisti�, al fine di rilevare il carattere intransigente della retorica reazionaria, Hirschman compie un�operazione che non � corretta sul piano storico-politico, tanto pi� in riferimento alla tesi dell�effetto perverso[24]. Infatti, mentre nella versione reazionaria, le conseguenze delle riforme sono controproducenti perch� l�uomo non pu� cambiare le cose con le sue forze e tutti i tentativi che potrebbe fare in tal senso risultano essere vanificati da una �provvidenza vendicativa�, nella versione conservatrice, le conseguenze sono controproducenti perch� i risultati dell�interazione umana non sono prevedibili, n� pianificabili.
Dunque, nel primo caso, l�individuo � in balia di una volont� diabolica che sfugge al suo controllo e, perfino, alla sua consapevolezza; nel secondo, invece, l�individuo � autonomo, ma, in ogni caso, fallibile, dal momento che i limiti costitutivi della ragione umana e la consapevolezza della dispersione delle conoscenze, gli impediscono di prefigurare con assoluta certezza quale possano essere le conseguenze del suo interagire con altri individui.
Pertanto, fa bene Boudon a insistere sulle differenze tra un De Maistre e un Tocqueville: per De Maistre, infatti, nella rivoluzione non � l'individuo ad agire, bens� la Provvidenza, per cui il comportamento umano pu� essere spiegato mediante cause che agirebbero senza che se ne abbia veramente coscienza. Da questo punto di vista, il controrivoluzionario francese pu� essere collocato, a giusto titolo, nell�ambito della tradizione collettivistica, peraltro ben radicata in Francia, che offre un�immagine del mondo sociale come intersezione di forze misteriose, di processi e di funzioni, dove gli esseri umani sono solo dei corpi passivi, anzi a rigore neppure esistono al di fuori delle relazioni che li istituiscono, li costituiscono e ne specificano il comportamento.
Al contrario, Tocqueville appartiene alla tradizione dell�individualismo metodologico[25], dell�individualismo �vero�, per dirla con Hayek[26], che restituisce dignit� e autonomia agli individui � i soli a cui � possibile attribuire esistenza concreta -, i quali agiscono sulla base delle loro conoscenze fallibili, parziali e disperse, determinando una cascata di eventi causali, che non sempre sono esiti di scelte progettuali e consapevolmente finalizzate, bens�, spesso, il risultato non premeditato delle interazioni individuali.
Tocqueville, infatti, ne L�antico Regime e la Rivoluzione (1856), non mette mai in discussione che ad agire siano gli individui e proprio ai rivoluzionari, eccessivamente fiduciosi nei poteri della ragione, imputa la responsabilit� di avere, sia pur inintenzionalmente, rafforzato alcuni tratti di quell�Antico regime che intendevano spazzare via.
Ha ragione, per�, lo stesso Hirschman, quando lamenta �un travisamento�[Hirschman, 1992, p.148] della sua posizione, non avendo mai accostato nel suo libro i due filosofi politici: de Maistre, infatti, viene trattato come il rappresentante pi� puro delle tesi dell�effetto perverso, mentre Tocqueville viene preso in considerazione per argomentare la tesi della futilit�, di cui la Rivoluzione francese offre un esempio notevole, rappresentando nei fatti una rottura col passato molto meno radicale di quanto si fosse comunemente pensato.
Ci� nonostante, non �, come commenta piuttosto acidamente Hirschman[27], che Boudon non abbia compreso la differenza tra i due argomenti retorici: sembra pi� plausibile pensare che su queste distinzioni non abbia voluto soffermarsi se non con poche battute, ritenendo di fondo, innanzitutto, che la retorica non possa essere ricondotta a tre procedimenti specifici[28]; inoltre, che essa abbia una natura essenzialmente formale, per cui �� difficile per principio concepire che possa darsi una retorica specifica per ogni tendenza politica, [dal moneto che] ogni tecnica retorica pu� essere rintracciata in ogni discorso o in ogni teoria politica quali che siano l�orientamento e il contenuto�. E che, pertanto, non c�� una retorica �reazionaria� e una retorica �progressista�, ma solo una retorica tout court�[Boudon, 1992, pp.115-116]; ma soprattutto, ritenendo, in definitiva, retoriche, dunque un po� sospette, le stesse considerazioni di Hirschman, dal momento che �qualsiasi sociologo sa (�) che il procedimento retorico pi� corrente consiste nel lasciare intendere che la retorica � una caratteristica degli altri� [Ibid.].
In questo senso, sembrerebbe piuttosto retorico suggerire che la tesi dell�effetto perverso venga usata per �schernire quanti aspirano a cambiare il mondo in meglio� [Hirschman, 1991, p.31]. Infatti, non � contro chi aspira a migliorare il mondo, che pu� e deve essere usato l�argomento della perversit�, semmai contro chi coltiva l�ambizione utopistica di riplasmare il mondo. E allora, � vero che richiamare all�attenzione della politica, e della pratica politica, l�ineliminabilit� di conseguenze non volute di determinate azioni si accompagni alla raccomandazione di usare cautela nel riformare le istituzioni; tuttavia tale cautela non � rivolta contro ogni istanza di cambiamento, bens� verso (o contro) i tentativi utopistici miranti a plasmare l�intera societ�, secondo un progetto deliberato prestabilito.
Seguendo l�insegnamento di Popper, e prima ancora di Hayek, il quale delle conseguenze inintenzionali ha fatto lo strumento per criticare le pretese del costruttivismo razionalista in tutte le sue versioni[29], possiamo affermare che alla ingegneria utopica del meccanico olistico, che �pretende di pianificare razionalmente per la societ� nella sua interezza, bench� non si disponga neanche in minima parte della conoscenza fattuale che sarebbe necessaria per legittimare una pretesa cos� ambiziosa� [Popper, 1996, p. 226], si deve, dunque, contrapporre l�ingegneria gradualistica del �meccanico a spizzico�, il quale, conscio dei limiti, della parzialit� e della fallibilit� delle conoscenze umane, �sa che � soltanto dai nostri errori che possiamo imparare. Perci�, avanza un passo alla volta, confrontando con cura i risultati previsti con quelli effettivamente raggiunti e stando sempre in guardia per avvistare le inevitabili conseguenze non volute di ogni riforma� [Popper, 1975, p.70]. Cio�, avanza tentando soluzioni ai problemi che di volta in volta gli si pongono, a cui fanno seguito la critica e l�eventuale eliminazione degli errori.
Per tutte le ragioni che abbiamo detto, a proposito � lo ripeto � dei limiti, della parzialit� e della fallibilit� della conoscenza umana, il meccanico a spizzico sa che la prassi politica non pu� che essere riformistica. Lo � per ragioni scientifiche.
Pertanto, � incalza Boudon � mettere in guardia sul fatto che �l�azione volontaria, per quanto possa essere ben ispirata, pu� avere l�effetto di un impacco che non serve a nulla�[Ivi, p.117] o generare conseguenze controproduttive �equivale a essere reazionario e retorico�[Ibid.] ? E, per esempio, �quando Tocqueville dichiara che la Rivoluzione francese ha rafforzato alcuni tratti dell�Antico Regime (�), piuttosto che averli corretti, si abbandona alla retorica o, invece, enuncia un fatto controllabile�[Ibid.]?
Ecco, dunque, la questione centrale, sulla quale forse Boudon non si � soffermato abbastanza: richiamando l'attenzione sui fenomeni che sono il prodotto di azioni individuali che mirano a ben altri obiettivi si enunciano innanzitutto dei fatti. Fatti che sono controllabili, su dati oggettivi e ben vagliati, dal momento che la loro spiegazione non si appella a "leggi ineluttabili", alla "provvidenza", al "destino", ecc., ma muove dagli effetti di aggregazione di motivazioni, di preferenze e di azioni individuali comprensibili e razionali.
4. Il mestiere dello scienziato sociale
�I problemi cui le scienze sociali tentano di rispondere sorgono in relazione al fatto che l'azione di molti individui produce risultati non previsti, nella misura in cui sono osservabili regolarit� prodotte da alcun disegno� [Hayek, 1967, p.39][30].
Ebbene, per affermare l�uso scientifico della nozione di �effetto perverso� non � sufficiente ricollocarlo nella categoria pi� ampia delle conseguenze inintenzionali dell�azione umana intenzionale. Ci� significherebbe, infatti, restare ancorati alla dimensione descrittiva del fenomeno.
Per affermare l�uso scientifico della nozione di effetto perverso � lo ripeto � bisogna subordinare il momento descrittivo alla finalit� esplicativa. Il che comporta la ricerca delle �cause� a cui imputare la genesi di conseguenze non anticipate dell�azione intenzionale.
La principale di queste � sicuramente riconducibile ai limiti costitutivi della conoscenza umana, che � fallibile, parziale e dispersa tra milioni di individui; limiti, per i quali � possibile individuare, come fa Robert Merton [1998, p.9], alcune �cause concrete�. Innanzitutto il carattere �stocastico� � cio� ampiamente congetturale � della previsione nelle scienze del comportamento umano, per cui �l�insieme delle conseguenze di ogni atto ripetuto non � costante, ma c�� una serie di conseguenze, ognuna delle quali pu� seguire l�azione in ogni caso dato�[Ibid.]. Per esempio, sappiamo che la decisione di aumentare i tassi di interesse ha effetti sul tasso di inflazione. Tuttavia, � probabile che ogni qualvolta tale decisione venga ripetuta avr� conseguenze differenti sul tasso di inflazione. In questo senso la conseguenza pu� essere considerata stocastica e non certa, in quanto non � possibile, in linea di principio, controllare tutti � e proprio tutti - i fattori che influenzano il tasso di inflazione. Pertanto, considerato che �1) (�) le conseguenze di un�azione umana sono infinite�, che �infinite sono le possibili interazioni tra le diverse conseguenze delle differenti azioni umane e cio� (�) infiniti sono i possibili incontri casuali di catene causali indipendenti�, e che �3) (�) in sistemi aperti a flussi d�informazione vengono moltiplicate le possibilit� delle iniziative e quindi delle interazioni�[Antiseri, 1989, p.92], � evidente che la conoscenza parziale con cui � compiuta un�azione favorisce un complesso variabile di risultati inintenzionali di comportamento.
Talora lo stato della conoscenza non �, tuttavia, condizionato solo dalla necessaria finitezza della condizione umana, bens� dai limiti posti da condizionamenti �ambientali�, che vanno ad incidere sulle informazioni che possono essere plausibilmente ottenute. Un secondo fattore di ignoranza deriva, infatti, dalle �esigenze della vita pratica che ci spingono frequentemente ad agire con una certa sicurezza, anche se � chiaro che l�informazione su cui basiamo le nostre azioni non � completa�[Ibid.]. E un terzo fattore � da rintracciare nella �scarsit� di tempo e di energia� [Ibid.] da impiegare nell�acquisizione di conoscenza necessaria a predire i risultati di un azione.
Anche l�errore [Ivi, p.10] � considerato un elemento produttivo di conseguenze inattese, che pu� emergere in vari momenti durante il corso dell�azione: nel valutare una situazione, nell�estrapolare il futuro dal presente, nello scegliere una linea d�azione o nell�esecuzione dell�azione stessa. L�errore � frequente, in particolar modo, nei comportamenti abitudinari, laddove � radicata la presunzione secondo cui le azioni che in passato hanno avuto successo continueranno ad averlo. Infatti, la ripetizione continuata di quel comportamento, automatica e non intenzionale, fa s� che �l�attore non riesca a riconoscere che quelle procedure, che hanno avuto buon esito in certe circostanze, non necessariamente devono averlo in ognuna e in tutte le condizioni� [Ibid.].
L�insorgenza di conseguenze non anticipate pu� essere dovuta anche ad un parziale o mancato uso dell�informazione di cui l�individuo dispone: vale a dire che l�interesse dell�attore per le conseguenze previste e immediate pu� escludere la considerazione di altre o ulteriori conseguenze della stessa azione. E ci� a causa, per esempio, di un �bisogno impellente di soddisfare un interesse immediato� o del fatto di �compiere una determinata azione imposta da certi valori� [Ivi, p.11]. Nel primo caso, infatti, nell�interesse al soddisfacimento di un�esigenza immediata intervengono generalmente degli elementi di carattere psicologico, da cui possono scaturire indecisione e incapacit� di valutare tutte le possibili conseguenze di un�azione. Nel secondo, l�attivit� orientata verso certi valori pu� sviluppare processi che finiscono per retroagire con gli stessi valori che hanno sollecitato l�azione, producendo conseguenze inattese di quell�azione stessa. Da questo punto di vista, � esemplare la spiegazione fornita da Max Weber [1977] della genesi dello spirito del capitalismo come risultato dell�influenza esercitata dall�etica protestante di ispirazione calvinista. Infatti, la dottrina calvinista della predestinazione, fondata sull�incertezza dell�uomo riguardo la propria salvezza (che � grazia di Dio nel suo imperscrutabile giudizio), implicando un impegno attivo del credente ad espletare nel mondo la vocazione che Dio gli ha dato, ha favorito, indirettamente (cio�, inintenzionalmente), il formarsi di quello �spirito� che � il fondamento della societ� capitalistica.
Un ultimo fattore genetico di conseguenze inintenzionali � legato alle difficolt� della previsione nelle scienze sociali, data la possibile interferenza reciproca della previsione con altri avvenimenti sociali fra i quali quello che essa prevede. A tal proposito, Merton ha introdotto i concetti di profezia che si autodistrugge (self-defeating prophecy) e di profezia che si autoadempie (self-fullfilling prophecy). Quanto alla profezia che si autodistrugge, una previsione corretta di effetti indesiderati pu� venire presa in seria considerazione e stimolare iniziative adeguate ad impedire il verificarsi della previsione stessa, eliminando con ci� la prova diretta della correttezza della previsione. E� questo il caso della predizione di Karl Marx, relativa alla progressiva concentrazione della ricchezza e del conseguente impoverimento delle masse, che fin� per potenziare l�organizzazione dei lavoratori, i quali �nella consapevolezza di occupare una posizione di scarsa influenza nei casi di contrattazione individuale, si organizz� per sfruttare i vantaggi della contrattazione collettiva, rallentando cos�, se non eliminando, gli sviluppi che Marx aveva predetto�[Ivi, p.13].
Quanto, invece, alla profezia che si autoadempie, �una definizione falsa della situazione determina un nuovo comportamento che rende vera quella che originariamente era una concezione falsa� [Merton, 1992, p.768]. Se, per esempio, si diffondono voci circa l�insolvenza di una banca, i clienti si precipitano a ritirare i loro risparmi, determinando il fallimento della banca, cio� realizzando lo stesso risultato che la previsione stessa annunciava.
Le conseguenze delle interazioni individuali risultano, pertanto, �mediate (1) dalla struttura sociale, (2) dalla cultura e (3) dalla civilt� [Merton, 1998, p.8], concetti questi ultimi che sono interpretati, dallo stesso Merton, in chiave di individualismo metodologico.
Ci� vuol dire che la ricerca sociologica non ha a che fare con rapporti di determinazione necessitante, che possano essere spiegati con l�azione di forze o leggi immutabili e divenire, quindi, infallibilmente prevedibili. Piuttosto, la ricerca sociologica �incontra scelte condizionate e condizioni che delimitano le scelte, uniformit� relativamente prevedibili e insorgenza di atteggiamenti nuovi e imprevedibili; azione condizionante del gruppo sociale sulla persona e reazione della persona al gruppo sociale� [Abbagnano, 1959, p.51].
Ecco perch�, tra le strategie retoriche tipizzate, la nozione di "effetti perversi" e, pi� in generale, quella delle conseguenze inintenzionali, � la pi� �impressionante� [Hirschman, 1997, p.64]: essa risulta essere la pi� distruttiva tra tutte le obiezioni a ci� che Merton chiama �azione sociale finalizzata�. Come tale, non pu� essere considerata semplicemente alla stregua di una strategia retorica specifica di chi cerca un argomento decisivo da opporre ad una data proposta di riforma. Al contrario, la scoperta di conseguenze inintenzionali di azioni umane intenzionali va assunta come il principio cardine che deve sovrintendere l'analisi dei fenomeni sociali e politici, indipendentemente dalle finalit� ideologiche di chi si deve occupare di spiegarli.
In questo senso, la polemica tra Hirschman e Boudon, per quanto sotto alcuni aspetti superflua, tenuto conto degli equivoci che hanno impedito loro di cogliere correttamente le argomentazioni dell'uno e dell'altro, risulta essere preziosa, nella misura in cui, ribadendo il rilievo epistemologico della nozione di conseguenze inintenzionali, ci ricorda quale sia il mestiere dello scienziato sociale.
Bibliografia
Abbagnano N., Dizionario di filosofia, Torino, Utet, 1971.
Abbagnano N., Problemi di sociologia, Torino, Taylor, 1959.
Antiseri D., Teoria della razionalit�, Roma, Borla, 1989.
Berti E., "Il procedimento logico-formale e l'argomentazione retorica", Quaderni di storia, 1993, pp.88-99, n.37.
Bosetti G., Intervista a Albert O. Hirschman: la retorica reazionaria dell�effetto perverso, in Il legno storto e altre cinque idee per ripensare la sinistra, Venezia, Marsilio, 1991.
Boudon R. � Infantino L., Alexis de Tocqueville: metodo, conoscenza e conseguenze politiche, Roma, Luiss Edizioni, 2002.
Boudon R., "E� reazionaria la retorica?�, in Quaderni di Sociologia, 1992, pp.109-119.
Boudon R., Effetti perversi dell'azione sociale, Milano, Feltrinelli, 1981.
Bourricaud F., "La rh�torique r�actionnaire selon Hirschman", Commentaire, 1991, pp.589-591, n.59.
Burke E., Riflessioni sulla Rivoluzione francese, in Scritti politici, Torino, utet, 1963.
Ceri P., �Le retoriche della reazione: coazione a ripetere�, in Quaderni di sociologia, 1992, pp.121-127.
Fallocco S., La "serendipity" nella ricerca sociale e politica: cercare una cosa e trovarne un'altra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002.
Fedel G., "Retorica e tradizione: una postilla ad Albert O. Hirschman", Quaderni di Scienza politica, 2002, pp.183-197
Hayek F.A., Individualismo: quello vero e quello falso, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997.
Hayek F.A., Nuovi studi di filosofia, politica e storia delle i dee, Roma, Armando, 1988.
Hayek F.A., L�abuso della ragione, Firenze, Vallecchi, 1967.
Hitrschman A.O., Autosovversione, Bologna, Il Mulino, 1997.
Hirschman A.O., Passaggi di frontiera, Milano, Donzelli, 1994.
Hirschman A.O., �L�argomento intransigente come idea ricevuta�, in Quaderni di sociologia, 1992, pp.147-154.
Hirschman A.O., �Replica a Paolo Ceri�, in Quaderni di Sociologia, 1992a, pp.155-156.
Hirschman A.O., �La rh�torique progressiste et le r�formateur�, in Commentaire, 1993a, pp.303-309 [trad.it. �Retorica reazionaria e retorica progressista, Il Mulino, 1993, 5, pp.837-853].
Hirschman A.O., Retoriche dell'intransigenza. Perversit�, futilit�, messa a repentaglio, Bologna, Il Mulino, 1991.
Infantino L., Ignoranza e libert�, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999.
Marshall T.H., Cittadinanza e classe sociale, Torino Utet, 1976.
Menger C., Il metodo della scienza economica, Torino, Utet, 1937.
Merton R.K., �Le conseguenze non anticipate dell�azione sociale intenzionale�, trad. it. in Nuova Civilt� delle Macchine, 1998, pp.7-14.
Merton R.K., Teoria e struttura sociale, Bologna, Il Mulino, 1992.
Murray C., Losing Ground: America�s Social Policy 1950-1980, New York, Basic Books, 1984.
Perelman Ch. - Olbrechts Tyteca L., Trattato dell'argomentazione, Torino, Einaudi, 1967.
Popper K.R., La societ� aperta e i suoi nemici vol.2, Roma, Armando, 1996.
Popper K.R., Miseria dello storicismo, Milano, Feltrinelli, 1975.
Popper K.R., Congetture e confutazioni, Bologna, Il Mulino, 1972.
Vickers B., Storia della retorica, Bologna, Il Mulino, 1994.
Weber M., L�etica protestante e lo spirito del capitalismo, Firenze, Sansoni, 1977.
[1] Come � noto, la retorica nasce, nel V secolo a.c., in Sicilia, avendo Aristotele indicato (nel Sofista) in Empedocle di Agrigento il suo inventore. Nell'accezione originaria dei Sofisti, essa era concepita come l'arte di persuadere un vasto pubblico (muovendolo pragmaticamente ed emozionalmente) con ogni mezzo. In particolare, il maggior teorico ed artefice di questo tipo di retorica fu Gorgia di Leontini, che svincol� il logos, inteso come discorso persuasivo, da ogni legame con l'essere e il conoscere, attribuendogli, peraltro, una sorta di potere magico a cui nulla resiste. Avversata da Platone, il quale, in questi termini, la considerava una forma di adulazione improntata all'inganno per il conseguimento dell'interesse e del piacere personale, nonch� una contraffazione della politica, cio� della scienza del bene, con Aristotele la retorica diventa l'arte di costruire discorsi persuasivi, avente per oggetto l'argomentazione, cio� i mezzi di persuasione impiegati nel discorso pubblico e la forma, ovvero l'analisi dello stile retorico, con le sue forme lessicali e sintattiche e le sue figure retoriche. Questa concezione Aristotelica della retorica, decaduta ad opera degli Stoici e degli epicurei, fu ripresa a Roma da Cicerone e Quintiliano e, in periodo cristiano da Agostino e Boezio. Recentemente � stata proposta come logica delle scienze non dimostrative. Cfr., a questo proposito, Perelman - Tyteca [1967]. Sulla storia della retorica, cfr. Berti [1993], Vickers [1994].
[2] Cfr. la voce �retorica� in Abbagnano [1971, pp.749-750].
[3] Di recente, Giorgio Fedel ha distinto tre tipi di retorica tradizionale, illustrandone il diverso modo di atteggiarsi proprio rispetto al problema dell'intransigenza: a) la retorica essenzialistica, riferita �alle dottrine che legano la tradizione all'idea della divinit� rivelata, tipica delle religioni universali, oppure ad orientamenti teosofici od esoterici che, in qualche modo, assolutizzano un ordine trascendentale del mondo� [Fedel, 2002, p.187]. Secondo questa impostazione, tipica del filone controrivoluzionario francese della prima met� del XIX secolo (De Maistre, Bonald, ecc.), �la tradizione - ci� che in ultima istanza conserva e trasmette la volont� di dio - diventa un'essenza, cio� qualcosa di metafisicamente eterno e assoluto� [Ibid.]. Inoltre, b) la retorica prasseologica, che fa capo a dottrine che concepiscono la tradizione non �come un'essenza agganciata a un ordine divino e trascendentale, bens� come una prassi del passato che continua nel presente� [Ivi, pp.188-189]. Essa � associata alla variante estrema dell'atteggiamento conservatore, secondo il quale vi � una connessione necessaria tra ci� che � e ci� che dovrebbe essere, con l'implicazione che lo stato delle cose deve essere accettato per il semplice fatto che esiste. Infine, c) la retorica evoluzionistica, la quale promana da dottrine che �concepiscono la tradizione (�) come un insieme di strutture (soprattutto istituzioni e regole di comportamento) che deriva s� dal passato temporale, ma alla stregua di precipitato di un processo di evoluzione (�) che non avrebbe raggiunto se non avesse sviluppato queste strutture� [Ivi, p.192]. Ne consegue che, mentre la retorica essenzialistica e quella prasseologica, che avvalorano la tradizione, identificando (nel primo caso) o derivando (nel secondo caso) la tradizione come valore e la tradizione come fatto, propendono per una comunicazione assertiva e perentoria di significati assoluti che ostacola l�istanza dialogica, la retorica evoluzionistica, dove si ha piuttosto �una valorizzazione del fatto-tradizione mediata da valori che la tradizione, quale processo evolutivo, ha prodotto e produce�[Ivi, p.193], � quella delle tre che si presenta come la pi� atta a favorire la piena apertura dialogica: �la sua base razionalistica e strumentale apre in effetti lo spazio alla discussione, anzi la esige� [Ivi, p.195].
[4] In ogni caso, come verr� precisato pi� avanti, l'autore afferma che �la retorica semplicistica, perentoria ed intransigente non � monopolio dei "reazionari"� [Hirschman, 1991, p.153].
[5] Hirschman nasce nel 1915 nella citt� di Berlino, abbandonata dopo l'inizio del "terrore" nazista scatenatosi con l'incendio del Reichstag. Dopo varie peregrinazioni in diverse citt� europee, dove pot� entrare in contatto con gli ambienti antifascisti, si trasfer� negli stati Uniti. Arruolatosi, nel 1943, nelle fila dell'esercito americano, nel dopoguerra entr� a far parte di quel gruppo di "cervelli" che orienteranno la ricostruzione europea, divenendo consigliere del governo americano negli anni del piano Marshall. Questo attivismo continuer� ad essere una componente dell'opera e della vita dello scienziato, oggi professore emerito di Social Science dell'Institute for Advanced Study di Princeton, N.J. Cfr., Hirschman [1994].
[6] Cfr. Le D�bat, marzo-aprile 1992, pp.92-109, n.69. L�articolo in questione fu inviato contemporaneamente in Italia, ai Quaderni di sociologia., col titolo �E� reazionaria la retorica?�. Le citazioni di seguito riportate fanno riferimento a questa traduzione italiana.
Un�altra recensione ostile al volume di Hirschaman � stata pubblicata, su Commentaire, dal sociologo Fran�ois Bourricaud, nell'autunno del 1991. Questo, tuttavia, non deve far pensare ad una situazione di ostilit� generalizzata. Infatti, per rimanere al caso francese, si pu� ricordare l'editoriale di Jean Daniel, sul Nouvel Observateur del 25 aprile del 1991, in cui l'autore considera l'opera in questione una sorta di manifesto anticonservatore che "aveva tacitato i suoi dubbi circa la perdurante esistenza del pensiero di sinistra".
[7] Cfr. Marshall[1976].
[8] �Massacri, torture, impiccaggioni! Questi sono i vostri diritti dell�uomo?�[Burke, 1963, p.413].
[9] Sull�influenza esercitata in particolare da Hume e da Smith su Burke, cfr. Infantino [1999, pp.148-149].
[10] �Abbiamo cercato di provvedere meglio ai bisogni dei poveri e abbiamo invece accresciuto il numero dei poveri. Abbiamo cercato di rimuovere le barriere che impedivano l�emancipazione della povert� e senza volerlo abbiamo costruito una trappola�[Murray, 1984, p.9].
[11] �Non � affatto impossibile � scrive, infatti, il politologo americano � affermare che il repertorio della retorica progressista o liberale possa essere in buona parte generato a partire dalle diverse tesi reazionarie qui analizzate, mediante il semplice stratagemma di rovesciarle o capovolgerle�[Hirschman, 1991, p.153].
[12] Non sono d'accordo con Ceri, quando, dopo essersi domandato come sia possibile che sia tipico del pensiero reazionario qualcosa che non gli � esclusivo, conclude che questa � una contraddizione logica e non sociologica, che si risolve in questi termini: �i tre procedimenti retorici non costituiscono condizioni sufficienti perch� nel singolo caso si possa decretare il carattere reazionario di un�argomentazione; essi sono, per�, condizioni necessarie perch� si dia retorica reazionaria. La riprova � da vedersi nel fatto che in tutte le argomentazioni reazionarie vi � presenza di tali codici retorici, mentre non � cos� in molte argomentazioni progressiste�[Ceri, 1992, p.121].
[13] In una intervista a Giancarlo Bosetti, nel 1991, Hirschman ha precisato questo concetto, sottolineando che �l'idea che ogni cosa nella politica e nella societ� produca il fenomeno del backfire � (�) una deduzione completamente sbagliata tratta dal fenomeno, indubbiamente vero, secondo il quale le azioni hanno conseguenze inattese�[Bosetti, 1991, p.56].
[14] Dopo aver sostenuto che �l�effetto perverso � un caso speciale ed estremo di conseguenza inintenzionale�, Hirschman si spinge addirittura ad affermare che �� possibile sostenere che l�effetto perverso (�), sotto un importante profilo rappresenta la negazione [del concetto di conseguenze inintenzionali], se non addirittura il suo tradimento. Originariamente, il concetto delle conseguenze inintenzionali introdusse nel pensiero sociale incertezza e indeterminazione. Ebbene, in una fuga dalla loro nuova libert�, i fautori dell�effetto perverso tornano ancora una volta a guardare all�universo sociale come a qualcosa di totalmente prevedibile� [Hirschman, 1991, p.40]. In questo senso, esso agisce come una calamita per tutti coloro che bramano certezza.
[15]In un precedente lavoro dedicato proprio al tema delle conseguenze inintenzionali dell'azione umana, ho sostenuto che �le conseguenze inintenzionali sono conseguenze non previste dall'agente, non desiderate (non volute) e, talora, perfino non riconosciute. Ci� non significa, tuttavia, che siano necessariamente imprevedibili, indesiderabili e irriconoscibili per chi pone in essere l'azione e/0 per un osservatore esterno che le voglia spiegare ex post�[Fallocco, 2002, p.85-86].
[16] Ci sono anche situazioni in cui � sottolinea Hirschman � l�azione intenzionale ha effetti inintenzionali sia favorevoli che sfavorevoli, con un risultato netto fortemente dubbio. �La discussione sui presunti effetti perversi delle politiche assistenziali negli Stati Uniti ci offre un esempio di questo preconcetto. L�assicurazione contro la disoccupazione permette al lavoratore licenziato di attendere prima di assumere un altro impiego. In alcuni casi, questa possibilit� di un periodo d�attesa rischia di istigare alla �pigrizia�, nel senso che per un certo tempo il lavoratore non s�impegna seriamente nella ricerca di un nuovo lavoro. Ma l�assicurazione contro la disoccupazione consente altres� al lavoratore di non accettare un posto di lavoro purchessia; e ci� costituisce, fino ad un certo punto uno sviluppo positivo�[Hirschman, 1991, p.43]. Ci sono poi altre situazioni in cui effetti secondari o collaterali sono sicuramente destinati a limitare l�effetto inintenzionale di un�azione mirata ad uno scopo. �Qui l�esito tipico - continua - registra la sopravvivenza di un margine positivo all�aggressione dell�effetto collaterale negativo. I limiti di velocit� o l�obbligo delle cinture indurranno qualche automobilista ad allentare la vigilanza (�) e questo comportamento compensatorio � suscettibile di causare incidenti (�). Ma sembra improbabile che l�introduzione delle norme in questione produca un aumento anzich� una diminuzione del numero totale degli incidenti�[Ivi, p.44].
[17] Scritto che, infatti, non a caso Boudon non ha trascurato di prendere in considerazione quando scrisse Effetti perversi dell'azione sociale, in cui tenta di �fare l'inventario degli studi sociologici che mettono in evidenza effetti di questo tipo�. Cfr. Boudon [1981, p.15]
[18] La teoria della concorrenza, infatti, insegna che le imprese, se vogliono evitare la fuga dei consumatori verso le imprese concorrenti, devono pensare necessariamente a soluzioni che consentano loro di essere competitive sul mercato.
[19] Cfr. Hirschman [1982].
[20] Cfr. Hirschman [1993].